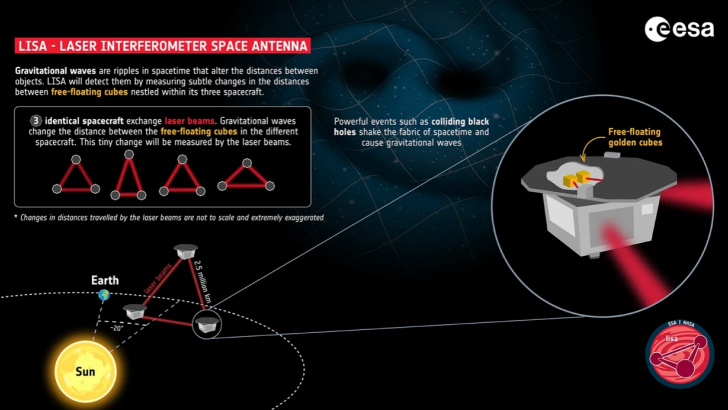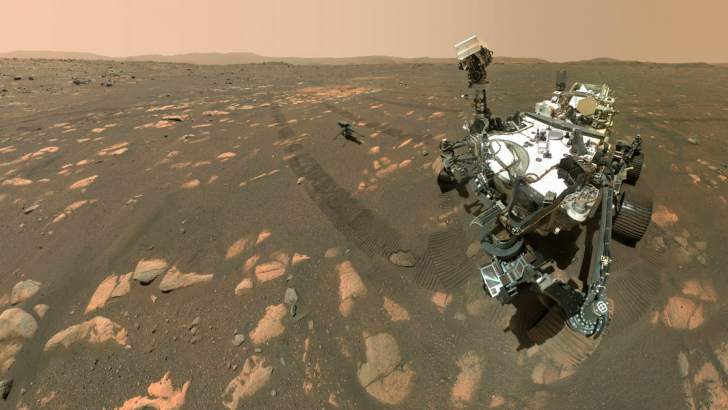SCIENZA E RICERCA
Spazzatura spaziale: un "guinzaglio" per eliminarla

La Terra vista dalla Iss, la stazione spaziale internazionale. Foto: Nasa
Quattro ottobre 1957: lancio del primo satellite artificiale nell’orbita terrestre. 12 aprile 1961: Yuri A. Gagarin è il primo uomo nello spazio. 20 luglio 1969: Neil Armstrong sbarca sulla Luna. Un percorso tutto in salita che alle spalle tuttavia lascia qualche problema da risolvere. Come quello dei rifiuti, già perché di spazzatura ne esiste (molta) anche nello spazio. In parte minore sono oggetti intatti, satelliti che hanno concluso la loro missione o i razzi che li hanno portati in orbita. Per il 60% frammenti di satelliti esplosi a causa di propellente ancora presente nei serbatoi o di collisioni accidentali con altri detriti di grandi dimensioni.
Le conseguenze non sono da poco se si pensa che possono causare la distruzione di satelliti o addirittura la perdita di una missione. E l’eventualità sembra non essere così remota stando ai numeri: sono più di 20.000 gli oggetti osservabili con radar e telescopi di dimensione maggiore ai cinque-dieci centimetri che ruotano intorno alla Terra e oltre 600.000 quelli di dimensioni inferiori (da uno a cinque centimetri). Senza calcolare i detriti ancora più piccoli.
Come affrontare dunque il problema? Padova si sta muovendo in due direzioni: da un lato la rimozione dei detriti dall’orbita terrestre, dall’altro sistemi di protezione. “Quando si parla di cattura di detriti – spiega Alessandro Francesconi, docente di ingegneria aerospaziale, che da tempo si dedica a questo settore di ricerca al centro di ateneo di studi e attività spaziali “G. Colombo” (Cisas) di Padova – si ha a che fare con oggetti della dimensione di qualche metro. L’obiettivo del nostro gruppo è di costruire uno strumento capace di ancorarsi al detrito e trascinarlo fuori dalle orbite terrestri più popolate”. Gli aspetti da considerare sono molteplici: è necessario innanzitutto individuare l’oggetto, avvicinarsi con precisione, aderirvi, stabilizzare l’insieme e connettersi rigidamente per riuscire a fare manovre orbitali.
Avviato qualche anno fa, il filone di ricerca ha già portato ai primi risultati. Il team ha infatti sviluppato e testato in volo stratosferico sistemi infrarossi e magnetici per individuare i detriti e stimare la distanza tra questi e il veicolo “inseguitore”. Ed è stato sviluppato un sistema di cattura (Flexible electromagnetic leash docking experiment - Felds) innovativo rispetto al passato: un filo flessibile collegato a una sfera viene sparato verso l’oggetto da catturare con un ancoraggio di tipo magnetico. Si tratta di un sistema che potrà venire usato non solo con i detriti, ma anche nel caso in cui due satelliti o veicoli spaziali debbano avvicinarsi per manutenzione o rifornimento di carburante. La novità sta nel fatto che fino ad oggi questo tipo di operazioni venivano condotte con strumenti rigidi, bracci robotizzati che richiedevano un elevato grado di precisione nel posizionamento tra i due veicoli per evitare collisioni e nella maggior parte dei casi con l’assistenza degli astronauti.
Ora, dopo vari test di laboratorio, il dispositivo verrà testato a Brema il prossimo novembre. “Siamo arrivati al cuore dell’esperimento” afferma Francesconi. All’interno della torre di caduta Zarm, alta circa 150 metri, l’esperimento verrà infatti riprodotto alle condizioni di microgravità presenti in orbita. La fase successiva prevede di testare il sistema nello spazio su piccola scala tramite satelliti delle dimensioni di circa dieci centimetri, detti “cubesat”, che saranno costruiti interamente a Padova.
“Il dispositivo che testeremo in Germania – sottolinea il docente – è nato da un’idea di cinque studenti del nostro ateneo e si inserisce nell’ambito delle attività didattiche. Attività che, come si vede, nell’attuale congiuntura economica permettono anche di finanziare la ricerca”. Loro sono Davide Petrillo, Alessandro Cavinato e Marco Gaino del corso di laurea magistrale in ingegneria aerospaziale, Federico Chiarotti di ingegneria delle telecomunicazioni e Marco Buonomo di ingegneria elettronica e l’occasione è stata offerta dal programma Drop your thesis! finanziato dall’agenzia spaziale europea e dal centro di tecnologia spaziale applicata e microgravità Zarm di Brema in cui i ragazzi con Felds si sono classificati primi.
Oltre a Felds il team di Francesconi sta studiando anche una seconda possibilità che si basa su sistemi intelligenti a “memoria di forma” in grado di connettersi a detriti di qualsiasi geometria tramite elettroadesione e ha sviluppato due distinti meccanismi di hard docking (di aggancio), uno dei quali già testato in volo stratosferico.
In parallelo, si stanno elaborando sistemi di protezione. “Attualmente – spiega Francesconi – stiamo lavorando alla costruzione di “scudi” in grado di autoripararsi. L’intenzione è di applicarli a serbatoi che contengono fluidi”. In pratica si tratta di pannelli multistrato all’interno dei quali viene collocato uno speciale materiale polimerico che ha la capacità di autoripararsi dopo essere stato perforato e di autosigillarsi evitando in questo modo la perdita di fluidi. Un sistema di “mitigazione” dunque, oltre che di protezione, che evita al serbatoio di esplodere e previene il formarsi di nuovi rifiuti. Se l’obiettivo principale è l’utilizzo in ambiente spaziale, non si esclude un impiego della nuova tecnologia anche in aeronautica per evitare esplosioni in situazioni di pericolo frequenti ad esempio in ambito militare.
“Si tratta di una ricerca che abbiamo completato da poco. Dopo lo studio sui materiali, ora stiamo cercando di applicarla ai sistemi reali creando dei prototipi. Da un lato ne stiamo discutendo con l’agenzia spaziale europea, dall’altro con le aziende del settore aerospaziale interessate alla produzione”.
Lo studio dei sistemi di protezione viene condotto utilizzando un’apparecchiatura sviluppata al Cisas di Padova, la sola in Italia e tra le poche al mondo, che consente di condurre studi di impatto a ipervelocità, riproducendo in questo modo particolari condizioni che si verificano nello spazio. “La velocità degli impatti che avvengono in orbita – argomenta il docente – è molto elevata. I detriti che ruotano intorno alla Terra possono raggiungere anche i 50.000 chilometri all’ora: il cannone a gas leggero doppio stadio di cui ci serviamo per i nostri esperimenti è una delle poche apparecchiature in grado di accelerare dei corpi a simili velocità”.
Al momento lo scudo anti-detriti più resistente è quello progettato a metà degli anni Novanta del Novecento per la stazione spaziale internazionale. Tuttavia risulta troppo costoso per essere installato nei satelliti ordinari come quelli per le telecomunicazioni o per l’osservazione della Terra e viene utilizzato unicamente per garantire la sicurezza all’interno dei moduli in cui abitano gli astronauti. Per quel che riguarda invece i sistemi di rimozione dei detriti la comunità internazionale sta valutando varie ipotesi, ma di concreto ancora nulla. In entrambe le direzioni, dunque, una strada in salita dove le possibilità sono ancora tutte da esplorare.
Monica Panetto