SOCIETÀ
Il congresso del Partito Comunista per tracciare il futuro prossimo della Cina

Una sala del museo del Partito Comunista cinese con il volto di Xi Jinping. Foto: Reuters
Si aprirà il prossimo 16 ottobre il congresso del Partito Comunista Cinese, quello che potrebbe (dovrebbe) sancire la riconferma dell’attuale presidente, Xi Jinping. Il passaggio, com’è intuibile, è tutt’altro che formale: perché determinerà il percorso che il “Celeste Impero” intraprenderà almeno per i prossimi 5 anni, con tutto quel che ne consegue in termini politici, militari, economici e commerciali, in un intreccio di cause ed effetti che, a prescindere dalla traiettoria, coinvolgerà tutti i protagonisti sullo scenario internazionale, nessuno escluso. La più che probabile riconferma di Xi, che nel 2018 era riuscito a rimuovere il limite del doppio mandato, comporterà comunque un cambio di passo nell’azione della Cina: gli analisti pronosticano una maggior “presa di potere” dell’attuale leader, con crescenti dimostrazioni di forza, con l’intento di arrivare alla definita risoluzione di alcuni dei dossier più “fastidiosi” per Pechino, a partire dalla riconquista di Taiwan, nonostante la mossa possa avere costi altissimi, e al momento non pronosticabili. L’immagine che oggi filtra all’esterno è proprio questa: di un leader che si pone al comando di una nazione “invincibile”, idealmente nella scia del “grande timoniere” Mao Zedong, che 101 anni fa fondò il Partito Comunista Cinese, dando il via a una delle dittature più longeve della storia, imponendo il principio dell’autorità assoluta del PCC e contrastando con determinata ferocia ogni palpito di democrazia e di pluralismo. Xi Jinping continua a mostrare un totale controllo degli apparati governativi, burocratici e militari della Repubblica Popolare, nonostante i malumori crescenti che covano all’interno del Partito, con le fazioni opposte, al momento minoritarie, che non mancano di sottolineare le difficoltà della gestione Xi.
I segnali che filtrano da Pechino non lasciano ipotizzare colpi di scena sull’esito del Congresso. Già il fatto che sia stato convocato per metà ottobre può essere letto come un segno di stabilità e di rinnovata fiducia per Xi. «Le date dei passati congressi del partito in cui si è verificato il cambio di leadership erano di solito a novembre», ha spiegato Hsin-Hsien Wang, esperto di politica cinese presso la National Chengchi University di Taiwan. «La scelta di tenerlo a metà ottobre mostra che le fondamenta dell’autorità di Xi sono molto solide». Mentre secondo Ling Li, esperto di diritto e politica cinese dell'Università di Vienna, intervistato dall’emittente tedesca Deutsche Welle, i giochi sarebbero già fatti: «Quando viene annunciata una data, possiamo tranquillamente presumere che i decisori chiave abbiano raggiunto un consenso su quella scelta». Al Congresso, che si svolge nella Grande Sala del Popolo di Pechino, che si affaccia su piazza Tiananmen, partecipano gli oltre duemila delegati del PCC. Sono previste nuove nomine sia per il Politburo (25 membri), sia per il “Comitato permanente del Politburo”, l’organo più potente del Partito, composto attualmente da 7 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica Popolare.

Foto: Reuters
“Zero Covid” e rallentamento dell’economia
Ma anche ipotizzando che la leadership di Xi ne esca consolidata, il percorso che si apre appare comunque pieno di strettoie e di oggettive difficoltà, specchio dell’anno che ha preceduto l’apertura del Congresso. In cima all’elenco c’è la crescita economica assai più debole del previsto (la stima era del 5,5%), con un prodotto interno lordo che nel primo semestre del 2022 è cresciuto appena del 2,5% rispetto all’anno precedente (con un misero + 0,4% nel secondo trimestre): colpa dei timori per una recessione globale, delle incertezze causate dall’invasione russa in Ucraina (alla quale la Cina non si è opposta) e per gli effetti duraturi della pandemia. Nella circostanza non sembra aver aiutato la politica “zero Covid”, uno dei pallini sui quali Xi ha continuato a battere con più tenacia, con durissimi e improvvisi lockdown imposti dal governo cinese in diverse città, accompagnati da drastiche restrizioni alla mobilità per “ridurre al minimo le morti e per proteggere l’economia”: le ferree misure di sicurezza hanno in realtà rallentato la crescita, facendo salire alle stelle il tasso di disoccupazione (quella giovanile è oggi stimabile attorno al 20%), rallentando la produzione e contribuendo al crollo del mercato immobiliare. Ancora lo scorso maggio, il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aveva sostenuto che «…considerando il comportamento del virus, la politica cinese di tolleranza zero contro il Covid-19 non è sostenibile». Spetterà a Xi trovare in futuro il giusto equilibrio tra il controllo della pandemia e la crescita economica. Oltre a dover in qualche modo affrontare l’enorme questione dei diritti umani, con le atroci repressioni dei diritti delle minoranze etniche nelle province autonome dello Xinjiang e del Tibet (qui l’ultimo report, drammatico, pubblicato da Amnesty International).
Ma è oltre i confini, pur vastissimi, dell’impero cinese, che si addensano le principali preoccupazioni internazionali. E non soltanto perché Xi Jinping ha impostato la sua politica estera con un impeto che potrebbe essere definito “coloniale”, dettando regole e disegnando corridoi commerciali in ogni angolo del mondo, stringendo legami economici con i governi più fragili e poveri del mondo che si trasformano regolarmente in “trappole del debito”, regalando infrastrutture strategiche delle quale poi pretende il controllo, in un micidiale e inarrestabile risiko d’interessi che mette a rischio la sicurezza internazionale (e una delle zone più a rischio è l’Indo-Pacifico). In realtà, come ha scritto su The Atlantic Michael Schuman, giornalista e scrittore: «Il mondo si sta dividendo in due sfere, distinte e contrapposte. Una centrata su Washington, l’altra su Pechino. Il deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, combinato con le accresciute ambizioni strategiche ed economiche di Pechino, ha già inaugurato una rinnovata competizione tra grandi potenze e una lotta ideologica tra norme globali liberali e illiberali». Lo scontro tra Cina e Stati Uniti non è più soltanto commerciale o tecnologico, ma ideologico. Il leader cinese vuole scardinare il paradigma che vede negli Stati Uniti, o nell’Occidente, il cardine dell’ordine mondiale. Vuole mettersi, non soltanto idealmente, a capo di un’alleanza di nazioni anti-occidentali. E il recente summit della Shanghai Cooperation Organization, che si è tenuto a Samarcanda, in Uzbekistan (primo viaggio all’estero di Xi dopo la pandemia) ne è stato la prova.

No di Pechino alle “sanzioni unilaterali”
E non si tratta di un’alzata di testa di Pechino, ma di una strategia pianificata. Un tassello fondamentale è stato posto lo scorso aprile, quando il presidente cinese ha presentato la Global Security Initiative (GDI), un’iniziativa che punta a dettare nuove regole per garantire la sicurezza mondiale. Nel testo, tra l’altro, si legge: «Rimaniamo impegnati a rispettare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, respingiamo la mentalità della Guerra Fredda, ci opponiamo all’unilateralismo e diciamo no alla politica di gruppo e al confronto di blocco». E ancora: «Rimaniamo impegnati a risolvere pacificamente le differenze e le controversie tra i paesi attraverso il dialogo e la consultazione, sosteniamo tutti gli sforzi volti alla soluzione pacifica delle crisi, respingiamo i doppi standard e ci opponiamo all’uso sfrenato di sanzioni unilaterali». Un’operazione, questa della GDI, talmente strategica nella politica di Xi da aver fatto scivolare in secondo piano (in termini di narrazione) perfino la Belt and Road Iniziative, il colossale programma d’investimenti che riguarda i paesi dell’Asia, dell’Oceano Indiano e del Mediterraneo. «Dobbiamo lavorare insieme per mantenere la pace e la stabilità nel mondo», ha detto Xi Jinping nel suo discorso, ad aprile. «I paesi di tutto il mondo sono come passeggeri a bordo della stessa nave che condividono lo stesso destino». La risposta americana è stata affidata al Segretario di Stato, Antony Blinken: «Le fondamenta dell’ordine internazionale sono oggetto di seria e continua sfida. La Cina è l’unico paese che si propone l’intento di rimodellare l’ordine internazionale e, sempre più, il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico. La visione di Pechino ci allontanerebbe dai valori universali che hanno sostenuto così tanto del progresso mondiale negli ultimi 75 anni».
Dunque un muro contro muro. Ma cosa potrebbe accadere dopo il 16 ottobre? L’incognita maggiore resta sempre Taiwan. Pochi giorni fa il portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan della Cina, Ma Xiaoguang, ha ribadito il solito refrain: la Cina è disposta a compiere tutti gli sforzi possibili per ottenere una “riunificazione pacifica” con Taiwan, ma che è anche “incrollabile” nel suo impegno per la salvaguardia del proprio territorio. «La madrepatria deve essere riunificata e sarà inevitabilmente riunificata», ha concluso Ma Xiaoguang, dando per scontata una “appartenenza” di Taiwan alla Cina del tutto unilaterale e, oggettivamente, opinabile. Mentre continua e continuamente si aggiorna, da parte di Pechino, la capillare azione di propaganda e di disinformazione, con l’obiettivo di persuadere il popolo taiwanese a sostenere l’unificazione con la Cina (qui un dettagliato e recentissimo reportage sull’argomento, pubblicato dal magazine The Diplomat). Sull’altro fronte, il presidente americano Joe Biden ha ribadito ancora una volta, con la massima chiarezza, in un’intervista televisiva: «Il personale militare statunitense difenderebbe Taiwan se l’esercito cinese dovesse lanciare un’invasione dell’isola governata democraticamente». Il che, ovviamente, ha innescato l’ennesima reazione stizzita di Pechino («Le osservazioni degli Stati Uniti violano gravemente il principio della Cina unica»), secondo un copione che dalla visita di Nancy Pelosi in poi ha visto una continua escalation di tensione. Peraltro con la Casa Bianca che si è poi affrettata a precisare che, nonostante le dichiarazioni del Presidente, “la posizione ufficiale degli Stati Uniti sull’ambiguità strategica non è cambiata”. In due parole: gli Stati Uniti forniscono da anni a Taiwan armi difensive e mostrano i muscoli di fronte ai proclami di riunificazione del governo cinese. Ma formalmente non hanno relazioni diplomatiche con l’isola. Hanno invece “una solida relazione non ufficiale” e “profondi legami commerciali ed economici”. Il segretario dell’Aeronautica statunitense, Frank Kendall, è stato più esplicito: «La Cina – ha detto - farebbe un enorme errore a invadere Taiwan».
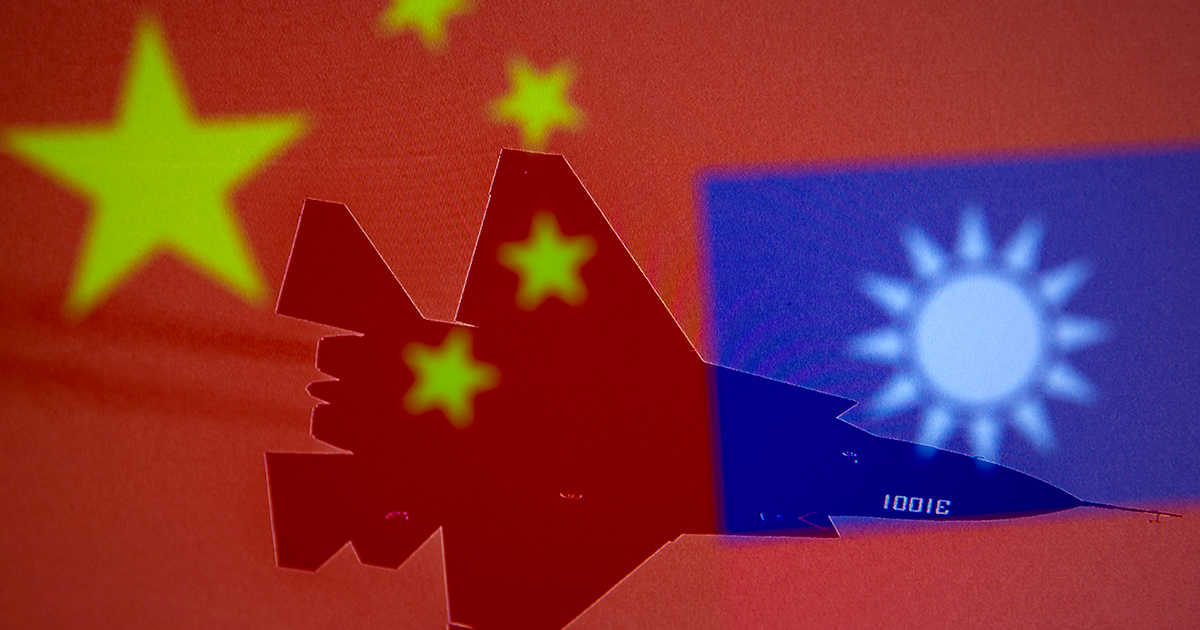
Dossier Taiwan: in gioco è la stabilità
La domanda è sempre la stessa: realmente Xi Jinping sarebbe disposto a mettere a repentaglio la sicurezza mondiale per riconquistare Taiwan? Proprio mentre il governo cinese continua a predicare quanto indispensabile sia “raggiungere la stabilità” nelle relazioni internazionali? Il dubbio resta, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel recente summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) che si è appena tenuto a Samarcanda, in Uzbekistan: prima “uscita” di Xi dai confini nazionali dal dilagare della pandemia e primo incontro con Putin dall’invasione dell’Ucraina (l’ultimo era stato a Pechino, il 4 febbraio scorso, alla vigilia dell’operazione militare decisa dal Cremlino). Nel comunicato diffuso dal ministero degli Affari Esteri cinese, al termine dell’incontro bilaterale, si legge: «La Cina lavorerà con la Russia per adempiere alle proprie responsabilità di paesi principali e svolgere un ruolo di primo piano nell’infondere stabilità in un mondo di cambiamenti e disordine». Parole “tiepide”, che hanno il sapore del richiamo, della critica sommessa, che raccontano come i rapporti di forza (anche commerciali) tra i due paesi stiano cambiando, a favore di Pechino. «La principale priorità per Xi per i prossimi cinque anni sarà la crescita economica, la stabilità politica e sociale, la sicurezza politica e nazionale», sostiene Alfred Chan, professore di scienze politiche alla Huron University College, in Canada. Mentre per David Shambaugh, direttore fondatore del China Policy Program presso la Elliott School of International Affairs presso la George Washington University, i segnali che filtrano per il prossimo quinquennio non sono positivi: «Prevedo più repressione domestica, più assertività esterna e possibilmente aggressività. Xi non cambierà rotta, e certamente non in una direzione più liberale o cooperativa», ha dichiarato a Politico. «Xi e la Cina potrebbero diventare ancora più sfacciati esternamente, consolidando ulteriormente l'alleanza de facto con la Russia e continuando ad ampliare l’impronta militare della Cina in tutto il mondo».
Indizi che tuttavia non fanno una prova, in un’agenda politica che resta avvolta nella più totale segretezza, com’è abitudine. Ma i rischi di un’escalation restano, e sono altissimi. Come scrive, sul magazine Foreign Affairs, anche Cai Xia, docente di teoria politica, in esilio negli Stati Uniti, ex funzionaria del Partito Comunista Cinese, espulsa nel 2020 per aver criticato la politica di Xi Jinping: «La Cina potrebbe sperimentare un circolo vizioso in cui Xi reagisce al senso di minaccia percepito intraprendendo azioni sempre più audaci che generano ancora più respingimenti. Intrappolato in una camera dell’eco e in cerca disperata di redenzione, potrebbe persino fare qualcosa di catastroficamente sconsiderato, come attaccare Taiwan. Xi potrebbe rovinare qualcosa che la Cina si è guadagnata nel corso di quattro decenni: una reputazione di leadership stabile e competente. In effetti, lo ha già fatto».




