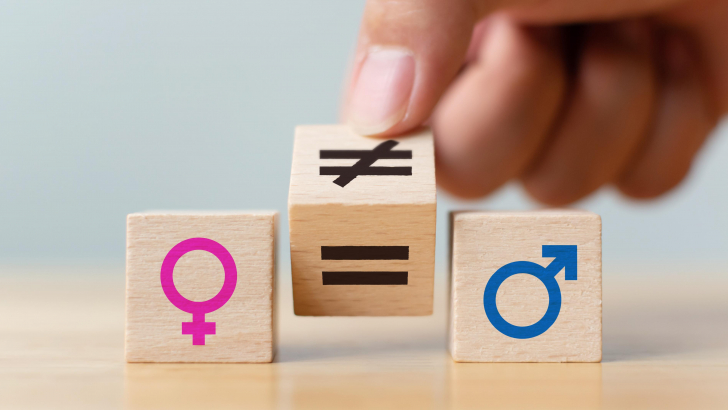CULTURA
Quando la resistenza è lecita

I tumulti di Milano descritti nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni. Illustrazione di Giorgio De Chirico
“Viva il duca e morano le gabelle”. Le tasse, tema intrigante del passato come del presente, sono state la scintilla di sommosse e rivolte di città e di popoli. Fra Cinque e Seicento sono state molteplici le ribellioni di comunità al loro principe. Come ad esempio è avvenuto a Urbino, a Messina, a Mondovì e a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. Quelle insurrezioni sono descritte nel libro Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna (Il Mulino, 2013), scritto da Angela De Benedictis, ordinario di storia moderna all’università di Bologna. I quattro casi sono stati riproposti dalla docente all’ateneo di Padova nell’ambito del ciclo dei seminari di storia del diritto e del pensiero giuridico, perché per quei tumulti e sollevazioni le comunità furono giudicate e trattate da ribelli. È in questi luoghi che si configura il “crimen lesae maiestatis”, il tipico reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna.
“La rivolta fra tardo Medioevo e prima età moderna – ha ricordato Angela De Benedictis – era considerata un crimine di lesa maestà ma è attorno a questo tema che si fa strada anche il concetto di resistenza lecita e del diritto all’autodifesa”. Indagando su quelle quattro rivolte italiane – “per 20 anni” ha detto – e rileggendo la letteratura giuridica dell’epoca, è stato messo a fuoco un tema cruciale che, “sul crinale fra obbedienza e disobbedienza, tra fedeltà e infedeltà, investe il problema della sovranità e dei suoi limiti nell’età moderna”.
Le comunità consideravano il loro “signore”come padre e a lui chiedevano la legittimità di sollevarsi, anche in armi, una volta esauriti i meccanismi dei ricorsi fino ai massimi vertici, contro chi in nome del potere sovrano cercava di umiliarli e sfruttarli. Non volevano disobbedire ma resistere alle ingiustizie. Tre i termini che abitualmente si rincorrono in queste storie: ribellione, obbedienza, fedeltà. La gestione tirannica del potere demandato dal sovrano a fronte dell’inutilità dei reclami, dei ricorsi e delle petizioni, generava il tumulto a difesa di diritti lesi in modo persecutorio e prolungato.
Il crimine di lesa maestà era considerato il più atroce di tutti. Il focus del libro e dell’intervento di Angela De Benedictis è sul “tumulto” in quanto atto gravissimo, ma viene sottolineato come nelle vicende narrate l’accusato rigetti con sdegno la colpa di disobbedienza, giustificando le “proprie azioni e intenzioni con gli argomenti dell’autodifesa e della resistenza lecita”.
La sollevazione di Urbino è contro Guidobaldo II della Rovere e si svolge fra il settembre del 1572 e l’aprile del 1573. Il tumulto scoppia per l’aumento delle tasse. La comunità rifiuta, ma il duca è irremovibile. Vengono scelti 40 ambasciatori. Guidobaldo non li vuole neanche vedere, così come il papa. È una rivolta pacifica. Nonostante ciò il giudice riserva un bel po’ di lavoro al boia con una dozzina di impiccagioni. Prevale l’accusa di lesa maestà, di ribellione, un’accusa ritenuta infamante, ma quell’azione avrebbe meritato una classificazione diversa. Si afferma la non liceità della disobbedienza. Il pensiero politico tende a neutralizzare il conflitto, seziona le tensioni in singoli episodi e colpevolizza l’individuo e non la massa. C’è la riluttanza della politica a vedere la ribellione. La repressione del tumulto passa per schemi di demolizione dei singoli tumultuanti, a fronte dell’impossibilità di punire le masse. Anche i giuristi riconoscono che la moltitudine non va punita perché sarebbero colpiti anche innocenti. È il singolo, una volta estrapolato dalla massa, che viene accusato di fellonia, e di aver tradito i valori della fedeltà, della gratitudine, dell’obbedienza e della devozione. Il tradimento e la disobbedienza sono i presupposti ideologici fondamentali del “crimen leasae maiestatis”. Ribelle è chi non ubbidisce all’autorità costituita, è l’ingrato che si macchia del “crimen ribellionis”, un reato politico che obbliga l’azione penale. Si radica il principio che chi commette il delitto di disobbedienza danneggia il sovrano, legittimato così a “soddisfarsi infliggendo una pena”. Il civis doveva essere colui “qui obedit”. Zitto e buono anche se le tasse aumentavano a dismisura e se le truppe inviate dal duca a Urbino miravano non solo a distruggere la città ma addirittura a violentare le donne.
È finita male per i ribelli anche a Messina (rivolta antispagnola 1674-78) con la città bombardata dal mare. Così come a Mondovì contro la “levata del sale”, episodio che si situa nell’ambito della “guerra del sale (1680-1699). La reazione armata dei monregalesi è originata da esazioni forzate della gabella sul sale anche nei confronti dei coloni degli ecclesiastici (esentati per volere del principe), imposte dal conte di Villanova. Mondovì respinge l’accusa di ribellione al sovrano: la città imbraccia le armi suo malgrado non contro il padre-principe ma per fermare la voracità dei suoi ministri. Una sorta di legittima disobbedienza attuata in nome e per conto del popolo, che corre il rischio di scomparire in un vortice di insopportabili soprusi.
La quarta rivolta messa sotto la lente di ingrandimento da Angela De Benedictis è quella di Castiglione delle Stiviere contro di Gonzaga di Solferino tra il 1689 e il 1694. Anche qui si fa strada lo ius resistendi. Il giurista Antonio Gobbi nel 1694 scrive che i sudditi avevano il diritto di negare al principe l’obbedienza se questi li opprimeva rompendo patti e convenzioni. Essi potevano pure resistergli in armi per la difesa dei propri diritti e del proprio onore senza commettere il crimine di ribellione.
Anche Angela De Benedictis assolve i tumultuanti dall’accusa di ribellione quando prevale la liceità della resistenza. Chi “resiste” vuole essere difeso dal sovrano e nello stesso tempo vuole difendere il sovrano dalla mala gestione dei suoi rappresentanti in loco. Resistenza come ultima chance rispetto al dovere di obbedienza, una legittima disobbedienza in nome della legge stabilita dal sovrano e contro le violenze di sub-governanti senza scrupoli. Resistenza anche per difendere l’immagine stessa della giustizia; impugna la spada, ha gli occhi bendati e tiene in mano una bilancia con i piatti allo stesso livello, in segno di equità, proprio come prevede il “patto”, scritto o non scritto, fra il sovrano e il suo popolo. Giusto allora adirarsi contro chi tradisce quel “patto”. E il criminale non può essere il popolo.
Valentino Pesci