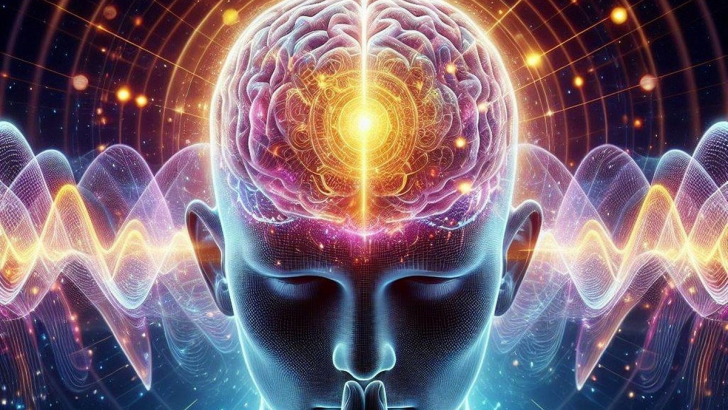SCIENZA E RICERCA
Sentite delle voci nella vostra testa? Rispondete

Approda in questi giorni nelle librerie britanniche e statunitensi l'ultimo volume di Oliver Sacks, il neurologo inglese da anni residente in America che con i suoi libri, da L'uomo che scambiò la moglie per un cappello a Risvegli (in Italia tutti editi da Adelphi), ha saputo aggiornare il vecchio genere scientifico/letterario dei “casi clinici” familiarizzando un pubblico sempre più numeroso con patologie come l'encefalite letargica o la sindrome di Tourette, che fino a alcuni anni fa ben pochi conoscevano al di fuori della cerchia degli specialisti.
Nel caso di Hallucinations (questo il titolo del libro in uscita), sembra però – stando alla recensione di Susanne Koven sul “Boston Globe” – che Sacks, con la cospicua eccezione di un capitolo in cui narra le sue esperienze con anfetamine, Lsd e morfina negli anni '60, abbia concesso meno spazio alle “storie” che tanto affascinano i suoi lettori per concentrarsi invece sulla descrizione di un fenomeno, le allucinazioni appunto, considerato di solito come un chiaro indizio di squilibrio mentale. Ne è una prova l'esperimento condotto nel '73 dallo psicologo americano David Rosenham, che chiese a otto individui sani di presentarsi a un pronto soccorso, asserendo di sentire delle voci. Sebbene le “cavie” si comportassero per il resto normalmente, non mostrassero altri sintomi e non avessero precedenti psichiatrici, furono tutte ricoverate, alcune per settimane, e vennero loro prescritti farmaci antipsicotici. Evidentemente, nota Koven, i medici che le visitarono dovettero dirsi: “Che cosa, se non un grave disturbo mentale, può indurre qualcuno a percepire cose che non ci sono per davvero?”. Ebbene, replica Sacks, “la grande maggioranza delle allucinazioni non ha oscure implicazioni”, dimostrando con esempi e dati che a molti – se non a tutti – può capitare di vedere immagini o sentire suoni che sono in realtà “dentro la testa”.
Ed ecco che, con mirabile tempismo, quasi che questo tema sia pronto a essere rianalizzato, scompaginando così i nostri concetti di normalità e follia, la psicoantropologa Tanya Luhrmann, docente a Stanford, ha scelto di intervenire al convegno Culture, Mind and Brain, che si è tenuto a fine ottobre a Los Angeles, con una conferenza videoregistrata, il cui titolo, tradotto in italiano, suona: “Sentire voci a Accra e a Chennai: come la cultura fa la differenza nell'esperienza psichiatrica”. Autrice nel 2000 di un testo premiatissimo, Of Two Minds, analisi etnografica delle due principali correnti della psichiatria americana, Luhrmann ha confrontato il modo in cui le allucinazioni uditive sono considerate e trattate negli Stati Uniti (e lo abbiamo visto: diagnosi di schizofrenia, ricovero, psicofarmaci), in Ghana, dove le voci indicano abitualmente un “attacco spirituale” da parte di spiriti o stregoni, e in India: qui la valutazione clinica è simile a quella americana, ma il termine “schizofrenia” non porta lo stesso stigma e la cura, così come in Africa, passa anche attraverso un dialogo prolungato con le voci, che in molti casi, da malevole e fastidiose che erano, diventano simpatiche e cordiali.
Ma senza andare lontano, un atteggiamento simile nei confronti di queste allucinazioni si trova anche in Europa: da oltre vent'anni lo psichiatra olandese Marius Romme e la ricercatrice Sandra Escher hanno dato avvio a un movimento, Hearing Voices, che si è già diffuso in vari paesi e che, nota nel blog Neuroanthropology lo studioso australiano Greg Downey, si rifà in parte alle teorie esposte da Julian Jaynes nel suo saggio Il crollo della mente bilaterale (Adelphi 1984). Per Jaynes, scomparso una quindicina di anni fa, la coscienza, o più precisamente la metacoscienza, è per la specie umana una acquisizione relativamente recente, ma ancora ai tempi dell'Iliade “il discorso interiore non era un compagno costante, come è per noi, ma una interruzione insolita, all'apparenza divina, che interrompeva una realtà abitualmente quieta, dominata dalle abitudini”. Per questo Romme e Escher ritengono che le allucinazioni uditive siano un retaggio di quel passato da non soffocare a suon di pillole, ma – alla lettera – da ascoltare, senza timore di rivolgersi alle voci, trattandole con rispetto e magari con simpatia, negoziando con loro i termini della “coabitazione”. Proprio quello che, ignaro di queste teorie, ma pronto a quell'ascolto che dovrebbe essere alla base dell'opera di ogni intellettuale, fece Sartre nel periodo in cui, come racconta anche Simone de Beauvoir nella Forza dell'età, il filosofo ebbe delle allucinazioni, vedendosi circondato continuamente da granchi e aragoste giganti. In un libro uscito l'anno scorso da Grasset, Entretiens avec Sartre, è lo stesso autore della Nausea a parlare di questa esperienza con il suo interlocutore, il giornalista John Gerassi: “Ho cominciato a vedermi intorno dei granchi tutto il tempo. Voglio dire che mi seguivano per strada, erano con me in aula (…). Mi ci sono abituato. Mi svegliavo la mattina e li salutavo: 'Buongiorno, cari, avete dormito bene?'. Parlavo con loro e dicevo: 'Su, ragazzi, adesso si va in classe e dovete starvene tranquilli e zitti', e loro erano là, intorno alla cattedra, in silenzio, fino a quando non suonava la campanella”.
Maria Teresa Carbone