L'ignoranza è il motore del progresso
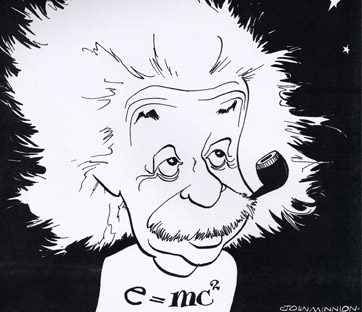
Da qualche anno il neuroscienziato Stuart Firestein tiene con grande successo alla Columbia University un seminario piuttosto insolito. Al centro dei dialoghi che lo studioso intrattiene con colleghi di diverse discipline di fronte a una platea di studenti entusiasti c’è infatti l’ignoranza: biologi e fisici, matematici e astronomi non sono invitati a parlare del loro grande sapere, ma del loro gigantesco “non sapere”. In sostanza, spiega Firestein, tutti questi scienziati “vengono a raccontarci quello che vorrebbero conoscere, quello che secondo loro sarebbe determinante apprendere, come pensano di poter arrivare a scoprire una certa cosa, cosa potrebbe accadere se ci riuscissero, che cosa non sapevano dieci o vent’anni fa e cosa sanno, o non sanno ora”.
Ma è davvero possibile parlare di quello che non si sa? E soprattutto, che senso ha? La spiegazione la dà in una intervista sul Daily Beast lo stesso Firestein (che nel frattempo ha scritto un libro dal titolo inequivocabile, Ignorance. How It Drives Science, Oup 2012, e che parteciperà in ottobre alla decima edizione di Bergamoscienza): “Anni fa, lavorando in laboratorio per le mie ricerche sulle neuroscienze e in parallelo tenendo un corso universitario sugli stessi temi, mi sono reso conto che il lavoro in laboratorio era molto più eccitante. All’inizio non riuscivo a capire perché, ma poi, riflettendo, sono arrivato a una conclusione. Per il corso usavo uno di quei libri di testo pesantissimi (tre o quattro chili, incidentalmente più del doppio del cervello umano) accompagnato da venticinque ore di lezione stracolme di dati e di nozioni – una enorme quantità di sapere che molto probabilmente può far pensare ai ragazzi che noi conosciamo tutto quanto è dato sapere sulle neuroscienze. E il punto è proprio qui, che questo non è affatto vero: in un laboratorio tutti ne sono perfettamente consapevoli e l’atteggiamento mentale è l’esatto contrario, fondato sulla curiosità, sull’apertura. C’è una frase molto bella di Marie Curie in una lettera a suo fratello, scritta tra l’altro quando lei era già molto avanti nelle sue ricerche: ‘Non si pensa mai a quello che si è fatto, ma a quello che resta da fare’. Ecco, mi sono detto, di questo dobbiamo parlare con gli studenti”.
Nulla di nuovo o di rivoluzionario, per carità, se il socratico “Io so di non sapere” ci accompagna da duemila e quattrocento anni. Ma evidentemente tendiamo a dimenticarlo, in un’epoca nella quale i vaniloqui su meriti ed eccellenze sembrano funzionare come collutori quotidiani, e si parla sempre dei risultati, ma assai poco dei percorsi accidentati e zigzaganti che ci hanno portato fin lì. Varrebbe allora la pena di riprendere in mano vecchi testi caduti in disuso. Bene ha fatto per esempio Maria Popova su Brain Pickings a riportare all’attenzione dei suoi venticinque(mila) lettori un breve saggio del pedagogista americano Abraham Flexner, pubblicato su “Harper’s” nell’ottobre 1939, ma ancora molto attuale, fin dal titolo: The Usefulness of Useless Knowledge, ovvero “L’utilità del sapere inutile”.
Dopo avere ricordato che ogni invenzione è il frutto di una lunga serie di tappe (e che, per esempio, i meriti, allora recenti ed esaltatissimi, di Marconi per il telegrafo senza fili si sarebbero dovuti equamente spartire con coloro che, prima di lui, avevano compiuto delle scoperte determinanti “senza scopo di lucro”), Flexner arriva al nocciolo del suo ragionamento: “Neanche per un momento io voglio sostenere che tutti gli esperimenti condotti nei laboratori sfoceranno in un uso pratico, né che questo uso pratico deve essere l’obiettivo ultimo degli esperimenti. Quello per cui mi batto, con tutte le forze a mia disposizione, è l’abolizione della parola ‘uso’ e la liberazione dello spirito umano. Certo, in questo modo manderemo in giro un po’ di innocui fannulloni. Certo, sprecheremo un po’ di preziosi dollari. Ma, cosa assai più importante, toglieremo le pastoie alla mente umana, consentendole di intraprendere avventure come quelle che, ai giorni nostri, hanno portato Einstein e i suoi pari nei territori più remoti dello spazio”.
“Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”. Qualcuno se ne ricorda ancora?
Maria Teresa Carbone









