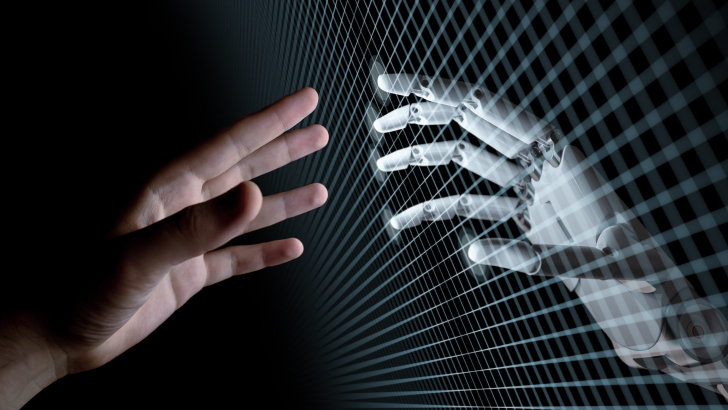Premio Galileo. “Schiavi del clic”, di Antonio A. Casilli

No, i robot non ci stanno rubando il lavoro. Almeno per ora ci fanno addirittura lavorare di più, anche se non sempre ne siamo consapevoli: è l’economia delle piattaforme bellezza, quella in cui siamo noi a pagare (spesso con i nostri dati personali) per accedere ai nostri stessi contenuti, ma è anche quella del lavoro invisibile, spesso accuratamente occultato dai giganti del web dietro il paravento dell’intelligenza artificiale. A svelarlo è Antonio A. Casilli, sociologo e docente all’Institut Polytechnique de Paris, nel libro Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo? (Feltrinelli 2020), nella cinquina finalista del Premio Galileo per la divulgazione scientifica 2021.
Nonostante le ricorrenti profezie sulla sua fine il lavoro è ancora ben lontano dallo scomparire e anzi si rafforza come elemento centrale della nostra vita. I dati ci dicono che i Paesi con una più alta incidenza di automazione – Corea, Giappone e Germania in testa – sono anche quelli con la disoccupazione più bassa. Robot e bot insomma non possono ancora prescindere dal controllo umano e anzi uno studio dell’Ocse, condotto nel 2016 su 21 paesi, è arrivato alla conclusione che l’automatizzabilità delle attuali professioni sia sovrastimata: se è vero che il 50% delle mansioni dovrebbe essere considerevolmente modificato da automazione e IA, al momento appena il 9% degli impieghi rischia veramente di scomparire. E se da una parte il caso Amazon dimostra che – nonostante tutti gli sforzi – anche le azioni apparentemente più semplici e ripetitive non possono ancora essere del tutto abbandonate dagli umani, dall’altra ci sono anche ambiti occupazionali sempre più promettenti, che vanno dalla progettazione e il controllo al customer care.
Intervista di Daniele Mont D'Arpizio; montaggio di Elisa Speronello
“Le promesse associate alle tecnologie digitali, in fatto di una maggiore democrazia e di miglioramento delle nostre condizioni sociali ed economiche, sono state disattese – premette Casilli nella sua intervista a Il Bo Live –. Una di queste era associata alla liberazione dal lavoro, ossia al fatto che con il digitale ci saremmo trovati in una situazione di maggiore libertà e autonomia: una soluzione all’alienazione e allo sfruttamento che caratterizzavano il contesto lavorativo da diversi secoli. Purtroppo, come la crisi pandemica ha dimostrato in maniera urgente e spesso dolorosa per tantissime persone, il fatto di servirsi di piattaforme di comunicazione oppure di strumenti digitali non elimina gli elementi di alienazione, di isolamento e di subordinazione”.
Per ora gli esseri umani devono dunque continuare a faticare, anche se cambiano ovviamente le modalità. Una conclusione tutto sommato tranquillizzante per chi paventava scenari alla Terminator, ma che dall’altro lato preoccupa chi prospettava le magnifiche sorti e progressive dell’economia della conoscenza. Da questo punto di vista il digitale completa il cammino intrapreso con l’inizio della globalizzazione: quello dell’occultamento del lavoro e soprattutto dei lavoratori. Se agli albori dell’epoca industriale – come ha osservato tra gli altri lo storico Donald Sassoon nel libro L’alba della contemporaneità (Padova University Press 2019) – i contatti e gli scontri tra classi sociali erano in un certo senso obbligati, con l’apertura dei mercati globali il lavoro, non solo manifatturiero, si è spesso trovato di fronte all’alternativa tra gentrificazione e trasferimento in Paesi con salari e tutele più bassi.
“ Oggi produciamo valore non soltanto in contesti lavorativi classici ma anche durante il nostro tempo libero
Oggi con la digitalizzazione – come documenta Casilli – non solo viene evitata ai consumatori la disturbante visione del lavoratore: il grado di occultamento arriva in qualche caso a negarne addirittura l’esistenza, come ad esempio accade per tante funzioni di moderazione e di regolazione che caratterizzano le piattaforme social che usiamo quotidianamente. Per quanto invece riguarda la sharing economy, lo spezzettamento e la ricomposizione dei processi produttivi tramite le piattaforme di intermediazione rischia di diventare uno strumento per lo sfruttamento e la perdita di diritti. E c’è infine la questione dei contenuti che noi stessi più o meno consapevolmente cediamo alle piattaforme e alle app di cui ci serviamo: “Oggi produciamo valore non soltanto in contesti lavorativi classici – prosegue il sociologo –. C'è una maniera più subdola di diventare, tra virgolette, schiavi del clic: quella di produrre valore anche durante il nostro tempo libero”. Pensiamo ad esempio all'uso di piattaforme di entertainment, dove si caricano e fruiscono video e immagini, oppure quelle per guardare film e serie tv in streaming: semplicemente consumando, cliccando questo o quel prodotto, produciamo un valore che queste aziende sono poi in grado di estrarre e di monetizzare, profilando le nostre preferenze in modo da utilizzarle direttamente o da rivenderle ad altri.
Vale insomma l’adagio che, se non paghi il prodotto, il prodotto sei tu. Con la conseguenza che i giganti del web, oltre a ingentissimi guadagni, negli ultimi anni hanno concentrato nelle loro mani anche un enorme potere di controllo, basato sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale ma anche e soprattutto sul lavoro, spesso gratuito o precario e malpagato, di milioni di persone. Un proletariato digitale che, osserva Casilli, ricorda in parte quello della prima rivoluzione industriale e che potrebbe prima o poi risvegliarsi. Saranno proprio gli 'schiavi del clic' in futuro quello che Arthur Koestler definiva “il principio attivo della storia”?