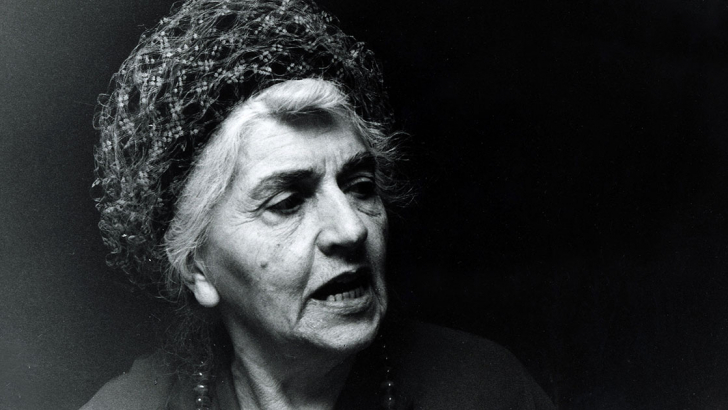SOCIETÀ
Ancora un Presidente protagonista?

Foto: Max Galli/laif/contrasto
I presidenti italiani non hanno mai del tutto incarnato l’archetipo di “presidente notaio”, come solitamente viene definito il Capo dello Stato dentro la cornice del sistema parlamentare, basti pensare ai casi di Pertini e Cossiga ma in alcuni frangenti anche a Gronchi e Saragat. In effetti, il presidente in Italia è riuscito ad essere incisivo nella formazione dei governi anche prima degli anni Novanta, in particolare quando talune formule governative entravano in crisi, come per la fine del centrismo, con la crisi del centro-sinistra e con l’esaurirsi della formula dei governi di unità nazionale. Tuttavia, non c’è dubbio che fino agli anni Novanta il presidente abbia avuto uno spazio di manovra più limitato rispetto a quanto è avvenuto successivamente.
Per esempio, in merito al controllo sulla legislazione, i presidenti più efficaci e incisivi sono stati Scalfaro, Ciampi e Napolitano, intervenendo ex ante ed ex postall’iter legislativo. Da Scalfaro in avanti, i presidenti hanno colmato efficacemente il vuoto politico quando necessario. La scienza politica nello spiegare questo ruolo si è basata soprattutto sulla variabile sistemica relativa all’indebolirsi dei partiti politici. Poca attenzione, invece, è stata posta sulla capacità dei presidenti di sfruttare i meccanismi della società mass-mediatica a proprio vantaggio, in particolare creando media-event e sfruttando la loro visibilità al fine di aumentare il proprio indice di gradimento da parte dei cittadini. In effetti, la principale cesura tra Prima e Seconda Repubblica è data dalla riduzione della distanza tra cittadini e Presidenza che ha visto in Pertini un grande anticipatore, il primo a sfruttare consapevolmente il grande supporto popolare di cui godeva per imporre alcune sue scelte a una riluttante classe politica.
Di conseguenza, il rafforzamento della figura presidenziale dagli anni Novanta in poi ha poggiato su questi due elementi: l’indebolimento dei partiti e la mediatizzazione della politica.
Rispetto al primo elemento, è noto che il collasso dei partiti tradizionali non ha generato partiti in grado di riprodurre la forza dei precedenti né a livello elettorale né considerando il grado di fiducia da parte dei cittadini nei loro confronti. In altre parole, né il principale partito di centro destra (Fi-Pdl-Fi) né il principale partito di centro sinistra (Pds-Ds-Pd) hanno mai controllato insieme più del 50% dei voti, mentre la Dc e il Pci a lungo hanno detenuto insieme i due terzi dell’elettorato. Inoltre, il livello di fiducia nei partiti non è mai salito oltre il 12% negli ultimi dieci anni; al contrario, ancora nel 1992 i partiti erano considerati degni di fiducia dal 31% degli elettori.
In questo contesto di debolezza strutturale, la figura del presidente ha potuto giocare un ruolo di rilievo anche perché la cosiddetta svolta maggioritaria non si è di fatto mai compiuta. Infatti, la riforma elettorale da sola (il Mattarellum) non è stata sufficiente a fare dell’Italia un modello Westminster di democrazia. La situazione è divenuta ancora più critica con il risultato elettorale del 2013, dal momento che al bipolarismo non del tutto consolidato si è sostituito un tripolarismo, che ha portato ad un nuovo impasse istituzionale rendendo necessario ancora una volta l’intervento presidenziale nella formazione del governo e precedentemente l’irrituale rielezione del Capo dello Stato.
Quanto al secondo elemento, in Italia anche i presidenti della Repubblica, e non solo i presidenti del Consiglio, sono stati influenzati dai fenomeni della personalizzazione e della mediatizzazione della politica e hanno acquisito via via una maggior capacità di usare i mass media per chiarire, suggerire, mediare, ridare fiducia, finendo per essere molto più visibili di qualsiasi altro predecessore della cosiddetta Prima Repubblica, perfino di Cossiga con le sue “picconate”.
Scalfaro ha utilizzato i mass media e la televisione in maniera cospicua, anche se limitata al difendere la sua carica e alcune delle sue decisioni: si pensi ad esempio al famoso discorso contro lo scandalo del Sisde (Io non ci sto). Tuttavia non è riuscito a focalizzare in modo permanente l’attenzione dei media sulla Presidenza come invece ha fatto il suo successore, Carlo Azeglio Ciampi che si è fatto interprete di una sorta di pedagogia civile volta a far riscoprire il patriottismo agli italiani. Le iniziative presidenziali come “il viaggio nella memoria storica” hanno prodotto un’ampia partecipazione da parte della gente e di conseguenza hanno ricevuto una grande copertura mediatica; il presidente forte di questa visibilità ha utilizzato proprio questi momenti per rivolgere moniti alla classe politica e ai partiti che non potevano rimanere indifferenti alle parole di un presidente tanto apprezzato. La popolarità di Ciampi è arrivata a toccare l’80% ed è stata in media pari al 71,4% nei sette anni del suo mandato.
Napolitano è stato in grado di far tesoro dell’esperienza dei suoi predecessori e con lui, soprattutto dal 2009 in poi, la Presidenza ha goduto di una sorta di sovraesposizione mediatica, tanto che alcuni analisti hanno coniato il termine di “sorveglianza mediatica” come forma di potere informale di controllo su governo e parlamento da parte del presidente. Nessun presidente ha esternato tanto per chiarire le sue posizioni, le sue decisioni e persino le sue azioni di consiglio o di moral suasion come ha fatto Napolitano attraverso note, lettere e dichiarazioni. Durante il primo mandato è riuscito ad aggirare il problema della sua appartenenza partitica al Pci che lo rendeva una figura divisiva conquistando un consenso anche tra coloro che avevano valori politici distanti dai suoi, passando dal 59,6% al 71,4% della fiducia popolare, con una media che si attesta al 62,1% per i primi sette anni.
Gli ultimi tre presidenti della Repubblica sono stati quindi tutti attori protagonisti dell’agone politico, a volte entrando in conflitto con i governi o addirittura sostituendosi ad essi. Ciascuno di essi ha svolto una qualche funzione di supplenza. Scalfaro ha avuto questo ruolo nei confronti del parlamento e dei partiti travolti dalle inchieste sulla corruzione con la creazione dei governi tecnici (nella fase 1994-96). Ciampi ha supplito all’incapacità dei partiti di creare ulteriori riferimenti di senso per la comunità politica una volta che sono entrate in crisi le grandi ideologie: è stato infatti l’inventore della patria come riferimento politico utile a cementare una democrazia dell’alternanza evitando le radicalizzazioni. Napolitano si è sostituito al parlamento con la creazione del governo Monti e l'introduzione, per la prima volta, della formula della grande coalizione in Italia, ma si è sostituito anche al governo in particolare con l’intervento – da alcuni giudicato persino al di fuori dei limiti costituzionali – sulla guerra in Libia.
Con le dimissioni di Napolitano ci si torna a chiedere se il prossimo presidente sarà forte o debole. La risposta rischia di essere scontata perché i due elementi che hanno significativamente contribuito a rafforzare questa istituzione sono ancora presenti. I partiti rimangono deboli, il maggior partito di centro destra, Forza Italia, ha visto dimezzarsi la propria capacità di attrarre voti con valori intorno al 15%; il Movimento Cinque Stelle pur restando intorno al 19% è destinato a rimanere una forza inerte se perseguirà la strategia della non alleanza; il Pd resta il primo partito con il 37%, ma la leadership di Matteo Renzi non sembra essere in grado di annullare le divisioni e le diverse fazioni riprenderanno forza non appena il consenso del leader diminuirà, come è lecito attendersi se la crisi economica continuerà senza inversione di tendenza.
La mediatizzazione della politica appare ineliminabile anche in Italia e nonostante l’incognita relativa alla personalità del presidente che può avere maggiori o minori capacità comunicative, il muro che divideva Presidenza e cittadini è caduto definitivamente: di conseguenza, sembra improbabile che il futuro Capo dello Stato possa rinunciare ad utilizzare i media per costruirsi un proprio consenso popolare da mettere sul tavolo nel momento in cui le forze politiche dovessero dimostrarsi inconcludenti.
Il problema vero resta quello di capire quali caratteristiche dovrebbe avere il prossimo presidente della Repubblica, dal momento che nemmeno gli outsider della politica – come fu il caso di Ciampi – sembrano poter contare su condizioni che favoriscano il ritorno a un ruolo notarile o quantomeno di attore di secondo piano, sebbene questo era quanto si auguravano le forze politiche che elessero Ciampi al primo scrutinio con una maggioranza del 71,4%.
Secondo i dati di un questionario rivolto a esperti (politologi, giuristi e storici contemporanei) il presidente dovrebbe innanzitutto essere una figura unificante; in secondo luogo dovrebbe favorire i compromessi tra le forze politiche e infine dovrebbe avere una precedente esperienza parlamentare. Fino a oggi l’elezione indiretta ha consentito che il presidente potesse quanto meno contare su un curriculum adeguato per svolgere queste funzioni,anche se l'aver ricoperto importanti ruoli istituzionali prima dell'elezione non ha sempre garantito la capacità di esercitare al meglio le proprie funzioni. Resta da chiarire se un eventuale presidente senza alcuna esperienza istituzionale e partitica – come sarebbe nel caso della scelta di una figura di prestigio, ma esterna al mondo politico – possa essere relegato a un ruolo di secondo piano. Il timore è che resti un attore rilevante ma che si riveli incapace di operare scelte adeguate.
Selena Grimaldi