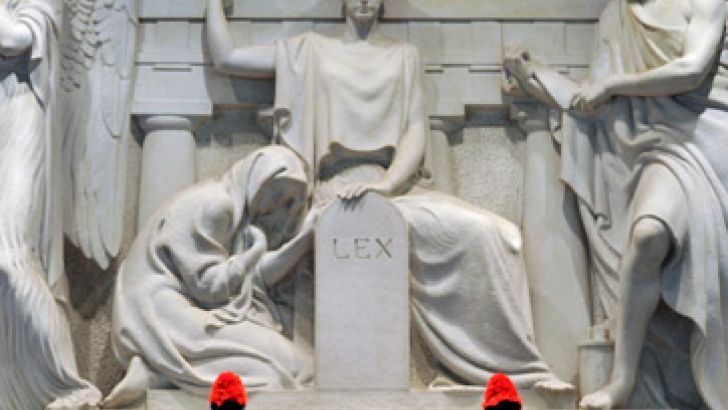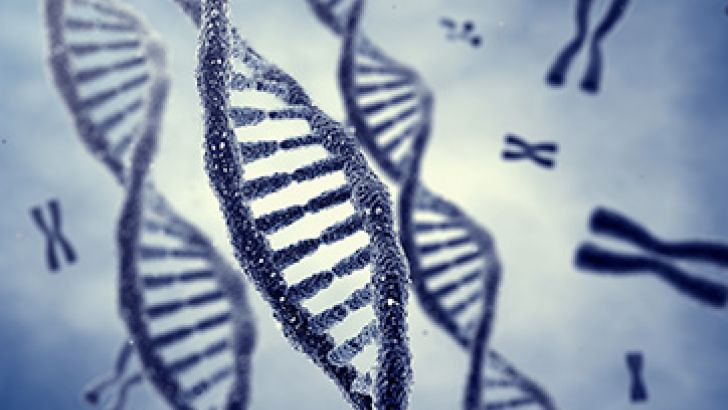SOCIETÀ
Il giusto processo immaginato da un umanista

Foto: Roberto Koch/Contrasto
Un diritto penale ricondotto alle sue ragioni laiche e retto dal principio di legalità per garantire la tutela dell’individuo e della sua libertà: questo passo decisivo fatto da Beccaria porta con sé come conseguenza l’inevitabile proporzione fra reato e pena, che negli ordinamenti tradizionali era tutt'altro che scontata, con un rigoroso rapporto fra danno causato alla società con il reato ed entità della pena minacciata ed inflitta. Siccome il reo ha anch’esso una individualità che va rispettata, la pena dovrà essere la minore possibile e solo in quanto strettamente necessaria. Le pene non devono essere soltanto utili, ma anche necessarie. La finalità delle pene non è quella “di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso”, essa altro non è, invece, se non quella “di impedire il reo dal fare nuovi danni ai suoi concittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”. “Perché una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male deve essere calcolata l’infallibilità della pena, e la perdita del bene che il delitto produrrebbe: tutto il di più è dunque il superfluo, e perciò tirannico” (par. XV).
Ma è soprattutto per la sua lotta contro la pena di morte e contro le pene crudeli, oltre che contro la tortura, quale metodo per pervenire alla affermazione della responsabilità del reo, che il pensiero di Beccaria si diffuse sin da subito, influenzando le legislazioni del tempo e tutte quelle successive (Pisapia). Si tratta della prima decisa posizione contro la pena di morte e la tortura ed assurge a fondamento di ogni sviluppo ulteriore della dottrina dell’umanesimo penale (Pisani). Per il Beccaria la pena di morte non è giusta, né utile, né necessaria ed egli ritiene assurdo che le leggi “che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ne ordinino uno pubblico”. Contro la tortura avanza argomentazioni così convincenti, mettendone in dubbio l’utilità e l’efficacia, da incidere immediatamente su buona parte dei sistemi penali del tempo. Egli dimostra, infatti, come la tortura sia non solo una barbarie, ma anche un mezzo del tutto inidoneo per l’accertamento della verità. Questo è il mezzo sicuro, egli scrive, “di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti” (par. XII). Parimenti rigorosa è la sua critica contro le pene corporali mutilanti, da lui definite “industriose crudeltà”, “barbari ed inutili tormenti” (par. XV) e, più in generale, nei confronti degli eccessi del rigorismo sanzionatorio.
Impossibile soffermarsi su tutti gli ulteriori profili di impressionante attualità presenti nel pensiero di Beccaria, ma è doveroso accennare all’indiscutibile valore assunto dalla sua lotta contro “l’irregolarità delle procedure criminali”. Le sue considerazioni e le proposte di riforma del processo penale sono così incisive da far dire ad autorevole dottrina che proprio sul terreno del processo il trattato di Beccaria fa sentire tutta la sua imponenza, proprio su questo terreno esso esprime tutta la sua capacità di rottura e la forza innovativa. Egli auspica un processo improntato alla esclusiva ricerca della verità del fatto, rapido ed immediato ed inspirato al principio della presunzione di innocenza (Pisani): “Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice né la società può toglierli la pubblica protezione se non quando sia deciso ch’egli abbia violato i patti ai quali le fu accordata. Qual è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente?”.
Ed ancora andrebbero richiamate le sue critiche alla carcerazione preventiva ed alla segretezza della procedura.
In buona sostanza anche in rapporto al processo penale, così come per il diritto sostanziale, emerge in tutta la sua statura lo studioso “nobile e forte per ‘ragione’ ed ‘umanità’” al quale tutti, e non solo i penalisti, devono un “tributo di ammirazione e gratitudine” (Pisani). (2/fine)
Elisabetta Palermo Fabris