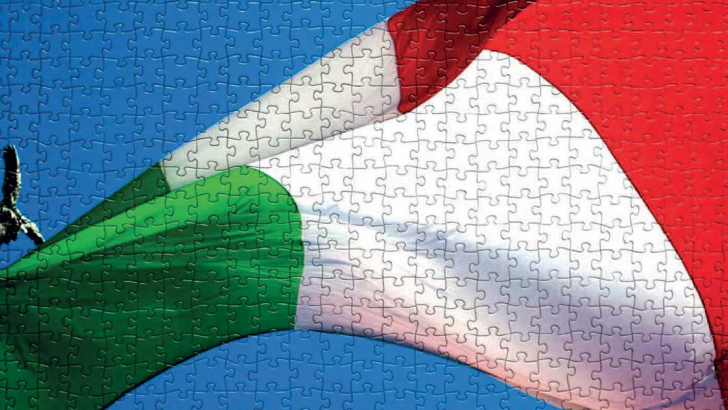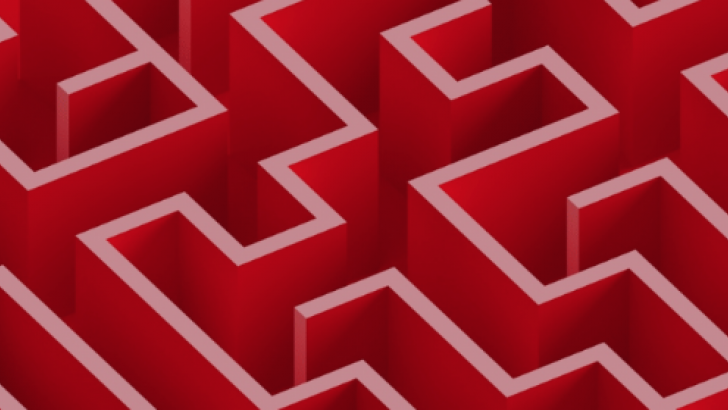CULTURA
La guerra dei monumenti

Foto: Reuters/Stringer
Se ne parla molto meno di Gaza, ma anche al confine tra l’Iraq e la Siria in questo momento è in atto una tragedia umanitaria, altrettanto se non più grave. E non è tutto, visto che l’autoproclamato califfato dell’Isis, giudicato troppo estremista persino da Al Qaeda, sta attaccando anche con il patrimonio artistico e culturale, uno dei più antichi e importanti al mondo. Negli ultimi mesi le notizie di saccheggi e di devastazioni si sono rincorse, fino addirittura alla distruzione dell’antica moschea del profeta Giona (Nabi Yunis): uno dei simboli di Mossul, l’antica Ninive.
Un’immagine che richiama alla memoria quella dei famosi Buddha di Bamiyan, fatti saltare con la dinamite dai Talebani nel 2001. “È la guerra dei monumenti, e coinvolge in particolare chiese, moschee e sepolcri particolarmente venerati”, racconta Massimo Vidale, archeologo dell’università di Padova con esperienza pluriennale anche in Iraq, dove ha lavorato soprattutto a Lagash, un complesso di cinque città sumeriche, e a Ur. “Ciascuna setta cerca di distruggere la memoria e l’identità delle altre. Tutte le fazioni integraliste islamiche sono poi unite nel tentativo comune di cancellare la presenza millenaria delle comunità cristiane nel nord dell’Iraq”. Come è possibile giungere a tanto? “Spesso c’è una vera e propria furia iconoclasta, animata da ragioni religiose. In molti casi però il vero obiettivo è quello di recuperare manufatti da vendere al mercato nero. In questo momento circa 1.000 tavolette cuneiformi escono ogni mese dall’Iraq per andare a ingrossare le collezioni private, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Hanno un grosso mercato, piacciono molto. E anche i musei e le istituzioni sono di fronte a un dilemma”.
Quale? “Cercare di salvare almeno parte di questo patrimonio oppure ignorarlo, per non alimentare il mercato nero. Prima che la situazione precipitasse i musei si rifiutavano di comprare i manufatti dai trafficanti, mentre gli studiosi non pubblicavano studi sulle tavolette provenienti dal mercato clandestino. Tutto però adesso è in discussione, e la cosa migliore è forse essere flessibili e prendere atto della realtà. Tra l’altro, tra tagli di bilancio e instabilità politica, questo è anche un momento molto difficile per l’archeologia. Molti colleghi quasi non vanno più a scavare sul posto, riescono a lavorare solo con oggetti provenienti dal mercato antiquario. Una cosa di per sé deprecabile, che però sta ormai diventando una realtà sempre più diffusa”. Può avere senso un piano per portare in salvo all’estero almeno parte del patrimonio in pericolo? “Diciamo che è una soluzione estrema. Durante il regime dei talebani, ad esempio, soprattutto in Svizzera sono state costituite delle collezioni di oggetti afgani, con l’idea di riportarle un giorno nel loro paese. Il problema è che non si vede un’uscita politica, quindi nessuno sa quando queste collezioni torneranno”.
La mancanza di soluzioni politiche a breve termine è il problema principale anche nel nord dell’Iraq: “Il problema non è il furto o la distruzione del singolo oggetto, ma il totale collasso delle strutture che dovrebbero proteggere il patrimonio archeologico”. Un disastro che ha radici lontane: per lo meno dalle guerre del Golfo. Ma non solo: “Credo che la situazione attuale non sia dovuta alla follia di qualcuno, ma è la logica conseguenza di decenni di politica coloniale, in cui il dominio straniero era basato sulla frammentazione della popolazione su base etnico religiosa, secondo il principio del divide ed impera. E aveva come conseguenza anche i saccheggi archeologici. Molte delle divisioni di oggi hanno basi aleatorie, e sono l’estremizzazione di un processo iniziato nell’Ottocento, in cui la religione a mio avviso è solo un elemento tra i tanti, e nemmeno il più importante. Basti considerare che i confini attuali tra Pakistan, dove ho lavorato, e Afghanistan sono folli, fatti nel 1893 tra emirato afgano e India britannica, e dividono in due l’etnia Pashtun (da cui proveniva la maggior parte dei Talebani, ndr). Continuiamo ancora oggi a pagare le conseguenze di queste scelte”.
Una situazione radicalmente senza speranza? “Direi di no. Nel Sud dell’Iraq ad esempio, dove ho lavorato, adesso c’è una maggiore stabilità grazie alla ripresa della comunità locale. C’è forte senso identitario sciita, aperto all’influsso della cultura persiana proveniente dall’Iran, ma indipendente e distinto da essa. La gente del posto è molto felice del contributo italiano, sono molto ospitali e vorrebbero sviluppare il turismo nelle loro zone. Lì tornerei in qualsiasi momento; anche nel Kurdistan iracheno operano diverse missioni archeologiche italiane, in condizioni di sicurezza ragionevoli”.
Oggi cosa si può fare concretamente per riportare la pace e combattere le distruzioni? “Incrementare le attività di scambio ad esempio. Nella valle dello Swat in Pakistan, con un finanziamento di tre milioni di euro siamo riusciti a costruire un museo e un parco archeologico che adesso danno lavoro a 30 famiglie, senza contare l’indotto. Fino ad ora non c’è stato un solo episodio di corruzione: la gente del posto ha capito che siamo andati per aiutarli e non per fare i nostri interessi”.
Daniele Mont D’Arpizio