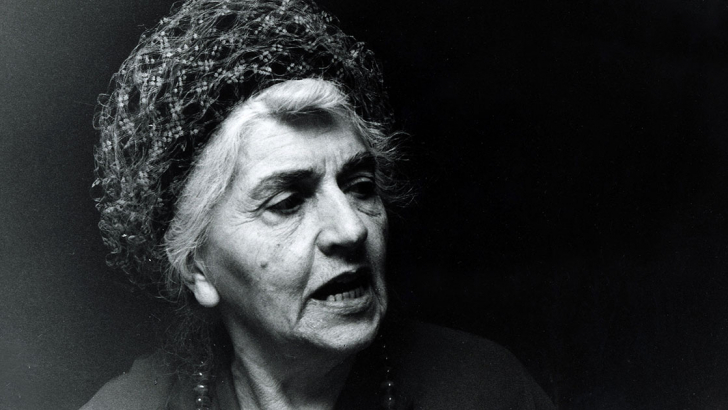SOCIETÀ
La politica italiana 1994-2014

Foto: Reuters/Tony Gentile
Ha un titolo dumasiano, Vent'anni dopo, il libro che Piero Ignazi dedica a Silvio Berlusconi a due decenni esatti dalla sua entrata in politica - anniversario che ricorreva il 26 gennaio e che, con nuovi protagonisti e un panorama profondamente mutato, è stato poco notato. Male, dice Ignazi: perché si tratta di una delle date più importanti della storia politica della Repubblica, e soprattutto perché le trasformazioni che la parabola del berlusconismo – questo il sottotitolo – ha portato nel panorama politico italiano ci accompagneranno ancora a lungo. È infatti quella di un vero e proprio cambio di paradigma come risultato del ventennio berlusconiano una delle tesi portanti del libro: risultato di una lunga egemonia culturale – quella che a Craxi era mancata - capace di caratterizzare un'epoca trasformando lo spazio pubblico, l'immaginario e i riferimenti collettivi. In sintesi, e per quanto attiene al focus specifico del libro: dopo Berlusconi è cambiata la parola politica, in entrambe le possibili accezioni. Sia come significato del termine, sia in quanto funzionamento del discorso pubblico. Una mutazione destinata a condizionare tutti gli attori odierni, ci ricorda l'autore: tanto quelli in sintonia quanto in antitesi alla sua eredità.
Come si è arrivati a una influenza tanto profonda sulla società italiana, cosa ha reso possibile un successo tale da caratterizzare un intero ciclo storico e politico e quale bilancio ne possiamo trarre? Queste le domande da cui parte il lavoro di Ignazi. Molto è stato detto e scritto sull'argomento in questi anni, ma in gran parte si tratta di studi fortemente condizionati dall'attualità politica se non direttamente di pamphlet. Vent'anni dopo, concepito con un taglio agile e per non specialisti, se ne discosta fin dal tono, improntato a sintesi e sobrietà, persino a pacatezza. Lontano dalle punte polemiche non significa affatto, qui, ecumenico: le tesi esposte sono nette, ma emergono più nella scelta dei punti di svolta indicati e delle questioni specifiche approfondite che non nell'enfasi su questo o quell'aspetto particolarmente divisivo. Un arco di tempo tanto lungo impone inevitabilmente scelte, e di questo limite Ignazi fa una cifra distintiva e il punto di forza del suo lavoro, facendone una "mappa" del berlusconismo sulla quale, con precisione topografica, tappa dopo tappa, prende rilievo l'itinerario percorso.
Filo di Arianna alla base di questa mappatura è il rapporto fra il fenomeno-Berlusconi e le tensioni e trasformazioni della società italiana, al proprio interno e nel rapporto con il mondo politico e la cosa pubblica. Trasformazioni che Berlusconi cavalca, promuove e allo stesso tempo influenza, in parte facendosene interprete, in parte – come vedremo - imprimendo loro una piega e una declinazione per nulla scontate o inevitabili, e misurandovi il proprio successo in termini di potere politico e il proprio fallimento, a parere dell'autore, in termini di progetto e di obiettivi.
Ecco, allora, l'Italia degli anni Ottanta, la crisi del sistema dei partiti culminata con tangentopoli e le ragioni del successo di Berlusconi; il primo governo, con la particolare colorazione del progetto "azzurro" che lo caratterizzava, l'eterogeneità delle componenti e la caduta sotto l'urto delle tensioni esterne ed interne. E poi la "traversata del deserto" e il ritorno al potere dopo l'implosione dell'Ulivo, il consolidarsi dell'egemonia e assieme le prime incrinature strutturali, sia della compagine politica che della presa sulla società; infine, la terza e ultima fase: il ritorno al governo, il momento di massima popolarità e la rapida consunzione, fino alla crisi dell'intero sistema politico sotto l'urto della congiuntura economica e alle dimissioni, che segnano la chiusura di un intero ciclo nonostante la partecipazione ai governi successivi. Le pagine scorrono di capitolo in capitolo mettendo a fuoco aspetti e momenti diversi di una storia che pensiamo di conoscere bene e che acquista via via profondità prospettica in modi a volte inattesi; quasi non ci s'accorge, nella densità della narrazione, della ricchezza di dati su cui si appoggia.
Fra i momenti più interessanti del libro, l'acuta analisi del passaggio tra gli anni Settanta e il decennio successivo: non un "riflusso", come fu allora percepito da molti, ma – nota Ignazi con icastica concisione – l'uscita dalla radicalizzazione distruttiva degli anni di piombo, capace di aprire le porte a una società civile adulta, insofferente per la guida di chiese e partiti e post-ideologica ma non per questo disinteressata al "comune", anzi decisa a dire la sua. Troviamo qui la rappresentazione di quell'insieme instabile di individualismo, edonismo, animal spirits e desiderio di partecipazione che attraverserà sottotraccia l'intero volume. Una vera "mutazione antropologica" rispetto ai decenni precedenti che dà ragione del radicamento berlusconiano nella società e della sua capacità di interpretare in modo specifico e particolarissimo la "rivoluzione liberista" che prendeva piede in quegli anni, ma permette anche di delineare la torsione tutta volta all'individualismo acquisitivo e all'anti-politica che Berlusconi le ha dato, e che si risolve per Ignazi nel suo vero scacco. Quello che allontana, invece che avvicinare, il suo ventennio – e il paese che vi è immerso – dall'Europa. Così come troviamo, in pochi passaggi pacati ma nettissimi, la misura del peso di risorse mediatiche ingentissime e di un know-how comunicativo straordinario, per un lungo periodo forse il migliore d'Europa, nel consentire al Cavaliere di superare tutte le avversità e consolidarsi in un elettorato anche periferico, socialmente e geograficamente, ma tutto televisivizzato.
Altrettanto preciso e netto il bilancio riguardo agli obiettivi che Berlusconi stesso proponeva alla propria azione politica: la costituzione di un moderno partito conservatore, stabile e radicato, la "rivoluzione liberale" e la modernizzazione del paese. Tutte e tre si sono risolte in un secco fallimento, dice Ignazi in pagine che hanno l'asciuttezza di una diagnosi, la sintesi della valutazione operata da uno storico a molti anni dai fatti.
Se qualcosa manca, è forse soltanto – proprio per la scelta di evitare i momenti più divisivi – l'analisi della reattività di una parte della società italiana a questa egemonia: dalla manifestazione del 25 aprile 1994 che scosse una sinistra traumatizzata al peso delle mobilitazioni sociali e sindacali nel fare da contraltare alla visione del mondo proposta, fino al triennio 2001 – 2004, con manifestazioni di ampiezza mai vista per i diritti del lavoro e contro la guerra che per la prima volta, perfino visivamente – con le bandiere della pace che dichiarano pubblicamente "non ci sto" - ribaltano nei grandi numeri l'esito di una campagna comunicativa martellante.
Ovvero, i semi all'interno della società di quella perdita di presa del messaggio e del mezzo televisivo che porta, come l'autore sottolinea, al vero finale di partita: la caduta di Milano, "cuore" dell'immaginario berlusconiano, e i referendum sui "beni comuni" che, quasi completamente snobbati da forze politiche e mezzi di comunicazione, con il loro successo suonano un cambio di fase. Quando, nelle parole dell'autore, il reale, con la crisi, diventa troppo reale per essere mistificato con l'immaginario.
Ignazi conclude fissando le caratteristiche della svolta portata da Berlusconi nella comunicazione politica. Iper-personalizzazione stemperata dalla battuta scherzosa, promozione del sé fino ad occupare tutto lo spazio comunicativo, disinvoltura e decisionismo, insofferenza alle norme, alle critiche e alla competenza. "Mito del fare" e capacità di cavalcare l'antipolitica ponendosi, dal centro del sistema, come colui che lo rompe; sondaggi e "volontà del popolo" come fonte di legittimazione permanente in opposizione a leggi e Parlamento. Impiego programmatico di un linguaggio nel quale chiarezza e semplicità spinte all'estremo fanno aggio sulla sostanza e sulla reale portata dei problemi.
Ed è difficile, scorrendo questa analisi, non trovarvi la fotografia di uno standard non criticato ma pienamente assunto oggi anche dall'ex-opposizione, che aveva rappresentato a lungo, comunicativamente, un polo opposto. Una continuità che - sottolinea l'autore – incide non poco sulla possibilità per i cittadini di valutare razionalmente le scelte dei differenti governi.
Michele Ravagnolo