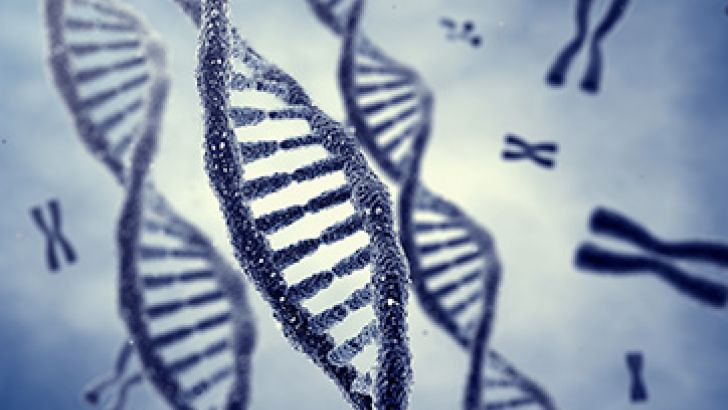Lombroso e Villella: la storia del dottore e del brigante

“Che una tesi sia contraria all'opinione di molti, non m'importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione”. Ad affermarlo cinque secoli fa Galileo che, primo degli scienziati contemporanei, indicò la strada da percorrere. Maria Teresa Milicia docente di antropologia culturale all’università di Padova, con lo stesso spirito, riscrive un capitolo importante e delicato della storia della scienza, quello della nascita dell’antropologia criminale, nel volume Lombroso e il brigante (Salerno editrice 2014). Con l’ostinazione di chi cerca “prove”, per tre anni, tra archivi storici e magazzini a dispetto della storia raccontata dai più.
Ma entriamo nel merito. I fatti, così come li divulgava Lombroso al grande pubblico, risalgono al 1870 quando lo scienziato durante l’autopsia del corpo di Villella fece la “sensazionale scoperta” della fossetta occipitale mediana, di un cervelletto a tre lobi e non due. Secondo lo scienziato sarebbe stata quella la prova “dell’atavismo criminale”, della presenza cioè di caratteri tipici dei primitivi scomparsi nell’uomo moderno. Era la teoria della predisposizione biologica al crimine che diede inizio all’antropologia criminale e vide la pubblicazione il 12 gennaio 1871.
Fin qui nulla di strano, se non fosse però che Villella, stando alle ricerche, morì nel 1864 e si suppone dunque che l’autopsia sia stata fatta quello stesso anno. I conti non tornano. Inoltre, si chiede Milicia, perché Lombroso attese più di sei anni prima di dare comunicazione della scoperta? Semplice: nella seconda metà degli anni Sessanta stava costruendo la sua carriera e il suo interesse principale era la pellagra con cui si conquistò una certa fama. Fino a quel momento non si era mai occupato né di origine dell’uomo né di razze. L’interesse per l’antropologia fu graduale, anche se l’ambizione era di affermarsi nel nuovo campo di studi e l’occasione parve venire proprio quando ebbe tra le mani il cranio di Villella. Solo quello perché in realtà, contrariamente a quanto Lombroso stesso affermò in più di qualche occasione, non fu lui a eseguire l’autopsia sul corpo. Alla comunità scientifica non poteva nasconderlo ma con il grande pubblico, con cui si potevano omettere i dettagli tecnici, cambiava registro e modificava anche la sostanza dei fatti “per inseguire la fama letteraria del suo personaggio”. Scrive Milicia: “Ecco l’invenzione mediatica ottocentesca dell’autopsia”. Di volta in volta Lombroso modificava la sua versione, aggiungendo o modificando dettagli sul “brigante”, data la sua scarsa conoscenza del profilo comportamentale e dei caratteri anatomo-patologici dell’uomo, cucendo insieme notizie di seconda mano. E sostenendo persino di aver incontrato Villella nel carcere di Pavia dove concluse i suoi giorni, anche questo poco plausibile. Le ricerche della studiosa padovana introducono qualche crepa nel “mito” lombrosiano, nel modello dello scienziato positivo che domina la morte e manipola i corpi creato dall’immaginario collettivo.
Con altrettanto scrupolo Milicia indaga la figura di Giuseppe Villella, il “famoso brigante”, “vissuto nell’Italia pre-unitaria [che] si è da sempre battuto per il bene della sua gente”. A Motta Santa Lucia dove nacque, Milicia si aspettava di trovare una tradizione orale, una memoria collettiva, ma le sue speranze rimasero disattese. Ciò che emerse furono i contorni di un semplice bracciante, un “pecoraro” nato nel 1802 da Pietro e Cecilia Rizzo. Ladro di “cinque ricotte, una forma di cacio, due pani… e due capretti” per cui subì un processo nel 1844. Trascorse gli ultimi anni della sua vita nel carcere di Pavia. Morì “affetto da tosse, tifo e diarrea scorbutica” il 16 Agosto 1864, si legge all’interno del suo cranio, trascritto con un lapis. Il 15 novembre, invece, secondo la trascrizione dell’atto di morte del segretario comunale di Motta.
A questo punto, però, sorge un’altra domanda: come si fa a essere sicuri che il cranio esposto al Museo di Torino sia proprio quello di Giuseppe Villella? E come si spiega la duplice data di morte? “I nodi problematici emersi – conclude Milicia – non possono sciogliere fino in fondo il dubbio su eventuali errori di attribuzione verificatesi al momento della prima catalogazione del reperto”. Rimangono dunque solo ipotesi: nel caso si ritenga che il cranio appartenga al bracciante di Motta Santa Lucia, l’unica spiegazione è un errore di trascrizione da parte di Lombroso o del segretario comunale nell’atto di morte (meno plausibile). In caso contrario, quel cranio potrebbe essere di qualsiasi malcapitato sottoposto ad autopsia. Del resto la storia insegna e non risparmia nessuno. Come nel caso di Francesco Petrarca e della ricognizione che sui suoi resti sepolti ad Arquà si fece nel 2003. Ebbene, gli studiosi dimostrarono che il cranio non apparteneva al poeta aretino, ma a una donna.
Milicia cala la storia, riscritta, di Lombroso e Villella nel periodo positivista ottocentesco in cui parlare di razze umane era cosa normale. “Oggi – spiega Pievani – ci siamo liberati dall’idea che evoluzione significhi necessariamente progresso. Significa certamente cambiamento, ma in quale direzione vada non si sa”. Per capirlo e superare, oltre all’errore lombrosiano, anche il concetto di razza umana è servito molto tempo. E ancora oggi c’è chi è convinto abbia senso parlarne.
Monica Panetto