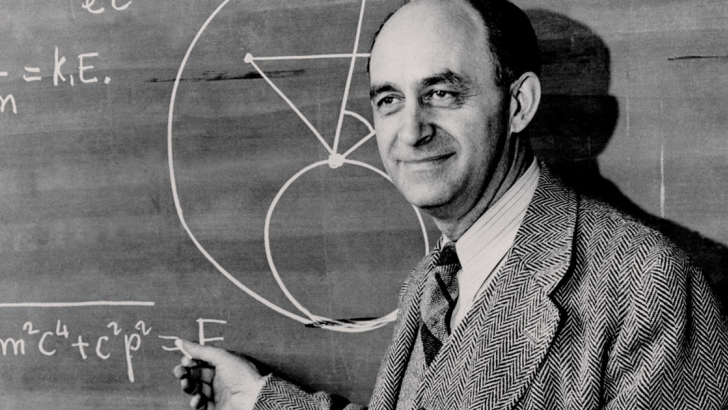SOCIETÀ
Made in Italy e sbocchi occupazionali

Anche l’università ha bisogno di dati, di capire cosa succede ai propri laureati: un passaggio inevitabile –nell’era dei Big Data- per adeguare contenuti e metodi del proprio insegnamento. Un primo test viene dai risultati di una ricerca realizzata insieme alla Fondazione Nordest sui laureati in scienze della comunicazione, risultati che (come sempre accade con le buone ricerche) sorprendono.
Esaminando i laureati 2004-2013 si scopre che il 90% è occupato stabilmente, con modalità contrattuali che hanno poco a che fare con il precariato. La maggioranza dei laureati è tutelata da forme strutturate (31% lavora a tempo indeterminato, il 35% a tempo determinato), solo una parte minoritaria (8%) ricade nei cosiddetti Co.Co.Co. Non sono scappati all’estero, il 95% lavora in Italia, né a Milano e Roma, capitali italiane della comunicazione, ma vivono e lavorano per l’80% in Veneto. Le modalità per trovare lavoro sono legate alle competenze, il 32% viene selezionato per il curriculum, mentre il ruolo delle italiche “raccomandazioni” è marginale (6%). Gli ambiti nei quali i laureati svolgono il proprio lavoro sono legati al marketing, la comunicazione, le vendite e il web. Pochi sono quelli che si occupano di media o fanno i giornalisti.
Sono risultati da far invidia a Ingegneria e che stupiscono se pensiamo che Scienze della comunicazione viene spesso indicata come uno dei fallimenti del nostro sistema universitario: un corso di laurea che produrrebbe giornalisti disoccupati o sottopagati. Al contrario, benché sia un corso nato negli anni Novanta, prima che nascessero Google, Facebook o Twitter, e quando i telefoni cellulari pesavano un chilo, il mix di competenze acquisite ha trovato spazio nel mercato del lavoro.
Comunicazione è internazionalizzazione. Stefano Micelli ha messo in evidenza come i laureati abbiano intercettato l’esigenza di crescita sui mercati internazionali della manifattura italiana di qualità. Si tratta di produzioni di nicchia, spesso sofisticate, che per essere apprezzate appieno dal consumatore internazionale richiedono una “narrazione” capace di metterne in luce dettagli costruttivi e tradizionali culturali. Siamo lontani dal modello di comunicazione urlata e banale del marketing della produzione di massa. Al contrario è richiesta sensibilità umanistica e capacità di dialogo con il consumatore. Lina Miletic, responsabile comunicazione di De Majo, storica azienda del distretto vetrario di Murano, spiega bene questa trasformazione: “Il nostro cliente è sofisticato, ricerca qualcosa di unico, ma non ha necessariamente una conoscenza approfondita del prodotto; a noi il compito di spiegare tutta la qualità e il lavoro che stanno dietro al made in Italy”.
Comunicazione è innovazione. La comunicazione è diventata parte integrante del processo di innovazione. Le nostre imprese realizzano prodotti personalizzati, su misura, non per una domanda indifferenziata. Da questo punto di vista, i comunicatori giocano un ruolo prezioso perché hanno le qualità per interpretare le richieste del consumatore e tradurle in indicazioni utili per designer e tecnici. Niccolò Ildos, responsabile comunicazione Fizik, un’azienda che produce selle e scarpe da ciclismo di fascia alta, racconta: “In azienda mi hanno assunto perché durante lo stage avevo dimostrato ottime capacità nel raccogliere le indicazioni degli atleti professionisti che testavano le nostre selle e nel trasferirle queste indicazioni al nostro reparto di ricerca e sviluppo”.
Comunicazione è uso intelligente della tecnologia digitale. Giorgio Soffiato di Marketing Arena, agenzia specializzata nella comunicazione digitale, ha sottolineato quanto siano importanti avere buona capacità analitiche nell’uso del digitale. Le nostre imprese non hanno bisogno di “applicatori”, ma di figure professionali in grado di capire, anche sporcandosi le mani con i numeri, quali sono le soluzioni più efficaci in relazione alle caratteristiche del prodotto e della nicchia di consumo. Di nuovo, rapporto con le imprese, visione umanistica delle cose, Big Data.
Marco Bettiol