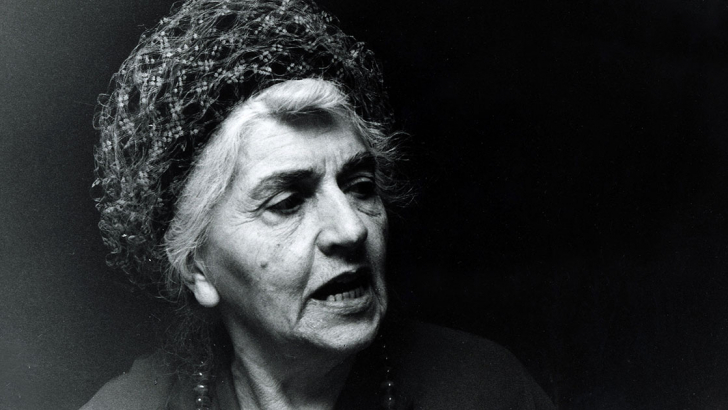SOCIETÀ
Partiti-dinosauro verso l’estinzione

Foto: Rocco-Rorandelli/TerraProject/co
Nella confusa discussione sulla politica italiana, sul “sorprendente” successo del Movimento 5 stelle e sulle ipotesi di governo porta un po’ di chiarezza il denso libretto di Marco Revelli, Finale di partito (Einaudi, 2013). Revelli, infatti, mette in relazione i pessimi risultati ottenuti sia dal Pd che dal Pdl nelle elezioni di febbraio con la crisi della forma partito, sia per ragioni strutturali (la trasformazione dell’economia che investe anche la politica) sia per ragioni contingenti (il progetto bipolare/egemonico perseguito da questi due partiti nelle elezioni del 2008).
Prima di tutto i dati: Revelli, a Bologna per presentare il suo libro, dice: “Dobbiamo guardare ai partiti e non alle coalizioni e al complesso del corpo elettorale, non ai soli voti validi. In quest’ottica, su 47 milioni di elettori, Pd e Pdl hanno raccolto insieme il consenso di circa 16 milioni di votanti, un terzo degli aventi diritto. Il Pd ha perso circa 3,5 milioni di voti rispetto al 2008, il Pdl addirittura 6,3 milioni, quindi il primo ha perso il 28% dei suoi consensi di cinque anni prima, il secondo il 47%, in pratica ha dimezzato i suoi voti. Cosa ci dice questo? Che i grandi contenitori concepiti qualche anno fa sono lesionati, pieni di buchi”.
I grandi partiti-contenitore concepiti da Veltroni e Berlusconi per alternarsi al governo grazie a una legge elettorale maggioritaria sono stati destrutturati e ridotti all’impotenza (nessuno dei due può governare, già dal novembre 2011) non dall’abilità di Grillo o dalla sola crisi economica ma da un processo di lungo periodo che Revelli nel libro descrive così: “In fondo il ‘partito di massa’ novecentesco – quello che ha contrassegnato per quasi un secolo la forma idealtipica della organizzazione politica e della democrazia rappresentativa – si era plasmato sulla matrice delle grandi burocrazie pubbliche: sulla forma di quello Stato nazionale di cui si candidava a costituire il cuore. E sulla struttura dei grandi sistemi produttivi nati a ridosso della seconda rivoluzione industriale. Fabbriche del consenso e della legittimazione, avevano assunto la stessa logica di funzionamento delle grandi fabbriche di prodotti e di servizi, centralizzate e burocratizzate, meccanizzate e standardizzate, rigide e rigorosamente territorializzate, pensate per la programmazione e la pianificazione di lungo periodo. Non poteva sopravvivere quel modello di partito – in quell’assetto – nell’epoca dell’interdipendenza globale e dell’esternalizzazione, dei sistemi reticolari a geometria variabile e della gestione sistematica dell’incertezza e dell’imprevedibilità. Nell’universo ‘liquido’ dell’ipermodernità post-industriale, per dirla con Zygmunt Bauman”.
Forme dell’economia e forme della politica vanno insieme, dice Carlo Galli: “Il neoliberismo crea una ‘democrazia liquida’, un’arena politica destrutturata dove si affermano offerte politiche occasionali, che profittano di zampilli improvvisi di energia politica”. Lo zampillo del Moviemento 5 stelle si è trasformato, nell’anno di governo Monti, in un fiume prima e in uno tsunami poi.
Il libro di Revelli aiuta a capire perché il progetto politico con cui Monti e Bersani si sono presentati alle elezioni, tenere fuori dal governo i due populismi rappresentati da Berlusconi a destra e da Grillo a sinistra sia fallito: in una crisi di sistema hanno successo i partiti antisistema. In quella che Bernard Manin ha definito già qualche anno fa “democrazia del pubblico” i politici si trovano a recitare su un palcoscenico dove le caratteristiche del leader e l’abilità nell’improvvisazione fanno premio su ogni altra dote.
Apparentemente questa situazione “riavvicina” i cittadini e i politici, prima separati dal burocratico funzionamento delle macchine di partito, ma in realtà la distanza fra rappresentati e rappresentanti in questa situazione è aumentata: a teatro non c’è terreno comune fra attori e spettatori, se non il diritto di questi ultimi di applaudire o di fischiare. Siamo in quella che Pierre Rosanvallon ha battezzato “controdemocrazia”: un sistema politico dove ci sono resistenze, veti, rivolte contro particolari progetti ma nessuna vera alternativa alle regole dettate dal neoliberismo e alle istituzioni che questo ha imposto.
Per concludere, Revelli non spera in un impossibile ritorno indietro ma ipotizza, con Michael Walzer, una nuova divisione del lavoro fra partiti e movimenti: ai primi che “raccolgono voti” si relazionano i secondi “che mobilitano potenziali elettori e cercano di modificare i termini della raccolta di voti”. L’esperimento Obama è nato così. Che esso sia replicabile in Italia, dove il dialogo fra i vecchi partiti e i movimenti sembra azzerato, sembra impossibile ma il politologo piemontese non vede altre strade per salvare le nostre “democrazie fragili”.
Fabrizio Tonello