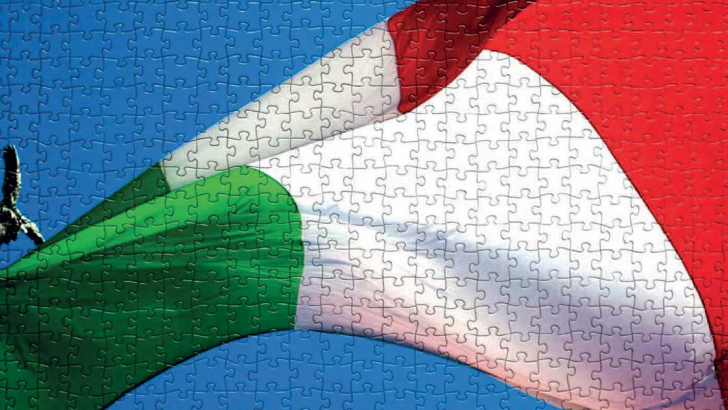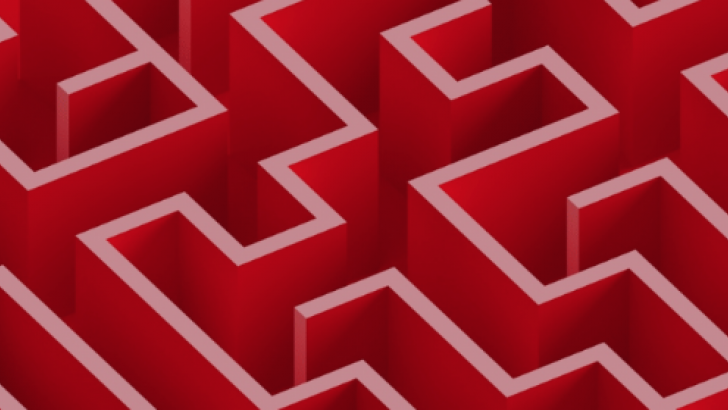UNIVERSITÀ E SCUOLA
La guerra attraverso il paesaggio

Paul Nash, We are Making a New World, 1918, olio su tela
“È in noi che i paesaggi hanno paesaggio”, scrive Pessoa nel Libro dell’inquietudine; “Se li immagino li creo; se li creo esistono; se esistono li vedo”. Nei dipinti come nei libri, nei racconti come nei post su Facebook, i paesaggi ci dicono sempre qualcosa di chi li osserva. Una comunicazione indiretta e inconsapevole ma non per questo meno spontanea e profonda: anzi. Soprattutto quando di mezzo c’è da raccontare un trauma, la voce rimane soffocata in gola e la penna si arresta di fronte all’indicibilità dell’orrore e della sofferenza. Per questo Matteo Giancotti, scrittore e ricercatore nell’ambito letteratura del Novecento presso l’università di Padova, nel recente libro Paesaggi del trauma (Bompiani 2017) raccoglie e analizza un vero e proprio corpus di descrizioni paesaggistiche per raccontare in maniera diversa la guerra del XX secolo, dal primo conflitto mondiale a quello della ex Jugoslavia.
Il libro riprende le pagine di autori noti e meno noti che hanno raccontato in prima persona il dramma del conflitto: da Ernst Jünger ed Erich Maria Remarque ai nostri Giovanni Comisso, Camillo Sbarbaro, Paolo Monelli, Ardengo Soffici e Giani Stuparich. Ripercorriamo così idealmente il Carso raccontato da Emilio Lussu e l’altopiano di Asiago descritto da Gadda, quest’ultimo così bello da sembrare quasi inadatto alla guerra, che poi però ha definitivamente ragione dell’amenità dei luoghi: “La nostra avanzata fin qui fu contristata dallo spettacolo delle orrende lacerazioni del monte e della foresta – scrive nel Giornale di guerra e di prigionia il gran Lombardo–, dalla vista di numerosi cadaveri in putrefazione, verdi, cerei, neri, paonazzi”.
Nella maggior parte dei casi è proprio la descrizione dell’ambiente circostante il modo in cui lo scrittore riesce a esprimere e a sfogare il proprio disagio e disorientamento. Certo, non per tutti la guerra è il male assoluto; Filippo Tommaso Marinetti, di fronte alle macerie di Gorizia distrutta, registra nei suoi taccuini un appunto eloquente: “Non ho mai visto tante rovine! Tanto per aumentar un poco il mio amore per il nuovo”. In un filone per certi versi analogo il Gabriele D’Annunzio del Notturno, mentre per Giuseppe Ungaretti il conflitto diventa quasi l’occasione per una rivelazione esistenziale e poetica che si rivelerà fondamentale per la sua opera. In Sono una creatura ad esempio è lo stesso animo del poeta ad essere associato all’arida natura carsica: “Come questa pietra / del S. Michele / cosi fredda / cosi dura / cosi prosciugata / cosi refrattaria / cosi totalmente / disanimata / come questa pietra / è il mio pianto / che non si vede”. La descrizione del paesaggio diviene allora l’occasione di un’analisi più profonda delle emozioni e delle sensazioni di un’epoca, anche quelle sotterranee e nascoste.
Attenzione però: se il paesaggio, in chi ha vissuto nella prima guerra mondiale, è quasi sempre espressione di un animo lacerato, il discorso in parte cambia per gli autori della Resistenza italiana al nazi-fascismo, trattati nella seconda parte del libro. Questo in parte accade a causa di un rapporto con il territorio – quindi con il paesaggio – profondamente diverso: il partigiano, secondo Carl Schmitt (autore di un fondamentale saggio sulla Teoria del partigiano), a differenza del soldato sembra emergere dal paesaggio che lo cela, lo protegge e, in un certo senso, è parte del suo armamento. “Se anche a volte il luogo di elezione del partigiano ha potuto trasformarsi in una orrenda trappola per rastrellamenti e agguati – spiega Giancotti –, nella maggior parte dei casi il partigiano ha avuto con i luoghi della propria azione, i luoghi che in un certo senso lo hanno protetto, una relazione quasi simbiotica”. Non è un caso che nella presentazione del 1964 alla seconda edizione del suo libro d’esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, Italo Calvino scriva che “La Resistenza rappresentò la fusione tra paesaggio e persone”: il paesaggio, divenuto protettivo e amico, può allora diventare, pur sempre nella drammaticità del conflitto, la metafora di un’umanità recuperata e di una futura società più pacifica e riconciliata.
Rispetto ad altre opere apparentemente analoghe (da Andare per i luoghi della Grande Guerra dello storico Marco Mondini, alla recente, ampia pubblicazione sulla Cartografia militare della prima guerra) quella di Giancotti si distingue per aver scelto un percorso letterario e filosofico piuttosto che storico e geografico. Perché certo, già in Stendhal e in Tolstoj tengono banco le descrizioni dei teatri bellici, ma è “soprattutto nella Prima guerra mondiale che la battaglia diventa un fenomeno con cui le forme ‘tradizionali’ della percezione umana stentano a combaciare” scrive ancora Giancotti, “a causa della potenza delle armi, della distanza tra i luoghi in cui si comanda e quelli in cui si combatte, del predominio – nel ‘bombardamento sensoriale’ cui il combattente e sottoposto – delle violente impressioni uditive che non si accordano con la vista”.
In questo senso la prima guerra mondiale segna davvero l’atto di nascita di un uomo confuso e malato, che non riesce più percepire l’unità dell’ambiente che lo circonda, i sensi perennemente saturati da lacerazioni e stimoli imposti da una tecnologia distruttiva e inumana. Un essere traumatizzato e diviso al suo interno, in cui l’esperienza del male cambia per sempre anche il modo di percepire e di rapportarsi con la realtà. Considerazione da tenere a mente anche oggi, in un’epoca che, come quella attuale, sembra segnare il ritorno della fascinazione per la guerra e il nazionalismo. Un’epoca che, al contrario di quelle descritte nel libro, apparentemente sembra bandire traumi e conflittualità, per poi celebrarli ed esporli quasi ad ogni occasione – film, libri, canzoni, serie tv…
Daniele Mont D’Arpizio