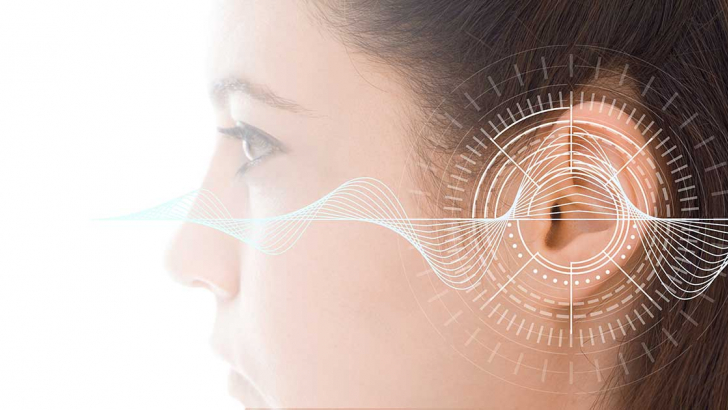Bambini agitati? Forse non ci sentono bene

Viene dalla Yeshiva University la notizia secondo cui esisterebbe un legame di causa effetto tra disfunzioni all’orecchio interno e iperattività. Lo studio, condotto per ora sui topi, sostiene che il deficit sensoriale causerebbe cambiamenti molecolari nelle zone cerebrali deputate al movimento.
“L’orecchio interno – spiegano gli autori nello studio – è formato dalla coclea, organo dell’udito, e dall’apparato vestibolare responsabile dell’equilibrio. Nei bambini con gravi perdite di udito si presentano disfunzioni nei due apparati in una percentuale che va dal 20 al 95% e, in questi casi, è stata verificata un’alta incidenza di disturbi del comportamento che vedono l’iperattività tra i principali sintomi”.
Per verificare la possibile esistenza di un nesso tra le due patologie i ricercatori hanno osservato il comportamento di alcuni topi di laboratorio nei quali si era notato un particolare stato di agitazione motoria. Gli autori hanno rilevato che i topi soffrivano di gravi danni cocleari e vestibolari che avevano compromesso l’apparato uditivo e hanno dimostrato che la causa risiedeva nella mutazione del gene Slc12a2. Il gene porta l’informazione per la sintesi della proteina SLC12A2 che media il trasporto del sodio, del potassio e del cloro in vari tessuti, tra cui l’orecchio interno e il sistema nervoso centrale. Neutralizzando il gene prima nelle cellule dell’orecchio interno e poi nelle aree del cervello e del sistema nervoso che controllano il movimento, gli autori hanno potuto verificare che solo nel primo caso si verificava iperattività nei topi. L’ipotesi era che le disfunzioni all’orecchio causassero un funzionamento anomalo del corpo striato, un’area centrale del cervello che partecipa al controllo del movimento e dunque che l’aumento dell’attività motoria non fosse immediatamente legata ai disturbi uditivi, ma a una interruzione delle funzioni del cervello deputate al movimento. La conferma venne dai test di laboratorio che dimostrarono un aumento dei livelli di due proteine, pCREB e pERK, nei circuiti di neurotrasmissione del corpo striato che usano la dopamina.
“Lo studio – sottolinea Carlo Semenza, docente del dipartimento di neuroscienze dell’università di Padova – arriva a un risultato importante e cioè che un deficit sensoriale può portare a cambiamenti molecolari a livello cerebrale, incoraggiando in questo caso la relazione tra sordità e iperattività”. Semenza ritiene che la ricerca dovrebbe proseguire anche sull’uomo, studiando ad esempio i sordi iperattivi e analizzando con sistemi di neuroimmagine cosa avviene nel cervello.
Secondo i ricercatori della Yeshiva University lo studio suggerisce anche che una causa neurobiologica, e non solo socio-ambientale, contribuisce all’insorgere di iperattività associata a disfunzioni dell’orecchio interno nei bambini e negli adolescenti. “Sarebbe interessante verificare – sottolineano gli autori dello studio – se esistano altri deficit sensoriali capaci di causare o contribuire all’insorgere di disturbi psichiatrici o motori tradizionalmente considerati di origine cerebrale”.
Cauto Pierantonio Battistella, docente del dipartimento di salute della donna e del bambino dell’università di Padova: “Lo studio in questione ipotizza che topi mutati spontaneamente e affetti geneticamente da sordità profonda manifestino maggiori livelli di iperattività rispetto ai topi che ci sentono normalmente e che questo deficit a livello di orecchio interno modifichi i livelli di dopamina in varie aree cerebrali tra cui lo striato”. Se è vero che i bambini e gli adolescenti sordi manifestano una maggiore incidenza di disturbi del comportamento, tra cui il deficit di attenzione e iperattività (Adhd), alcuni studi dimostrano che questa relazione è valida solo per la sordità acquisita e non per quella congenita. Battistella sottolinea inoltre che la maggioranza dei bambini con Adhd non è sorda né manifesta deficit uditivi e puntualizza che gli studi genetico-molecolari sui topi non sono assolutamente trasferibili tout court sull'uomo, ragion per cui appare necessario attendere altre conferme.
Monica Panetto