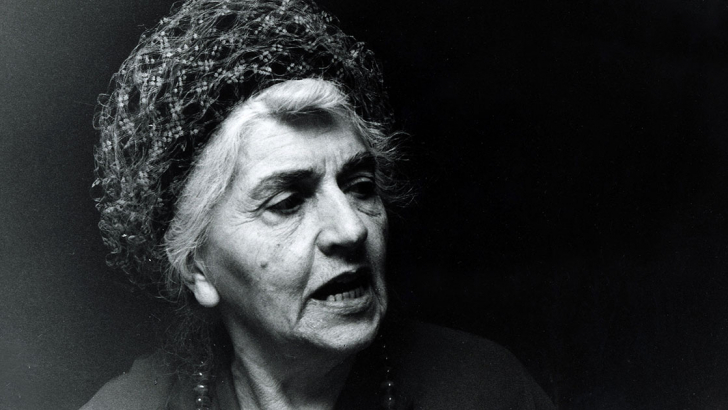Napolitano e quei discorsi veneziani inascoltati

Foto: Paolo Pellegrin/Magnum Photos
Mi ha fatto un particolare effetto leggere le pagine di questo libro alla luce dei recentissimi avvenimenti della nostra politica e delle nostre istituzioni. I due discorsi di Giorgio Napolitano qui riportati, ancorché relativi al 2008 e al 2012, potrebbero essere riprodotti oggi tali e quali, tanta è la loro freschezza e attualità. Ma proprio questo aspetto induce a una riflessione amara sul fatto che siano stati lasciati cadere entrambi nel vuoto, portando allo stallo che abbiamo vissuto nelle scorse settimane, e che ha di fatto costretto il presidente della Repubblica a tornare sui propri passi accettando suo malgrado di rimanere al proprio posto. Per due volte in poco più di un anno, le forze politiche si sono dimostrate incapaci di adempiere al proprio compito, e si sono presentate al Quirinale per chiedere di dare all’Italia prima un governo e poi un capo dello Stato; per giunta sprecando il tempo a disposizione senza riuscire a produrre la benché minima riforma, a partire da quella della legge elettorale, malgrado le autorevoli sollecitazioni dello stesso Napolitano e della Corte Costituzionale. I due discorsi riportati in questo libro risalgono a date recenti; e proprio questo breve lasso temporale non può farci dimenticare gli applausi e i consensi trasversali che avevano fatto loro seguito, sia per quanto riguarda l’esigenza di un assetto federale del Paese, sia per la sollecitazione a una visione alta della politica proiettandola sullo scenario europeo. Nulla di concreto è seguito a quel plauso generalizzato: e a ben vedere, è lo stesso sterile e per certi versi ipocrita atteggiamento che il giorno del giuramento si è colto in un’aula dove la stragrande maggioranza dei presenti batteva le mani alle durissime critiche che il capo dello Stato stava rivolgendo loro.
Non è vuota polemica richiamare questi aspetti. Essi segnalano in realtà un male profondo, che Massimo Cacciari bene mette in evidenza nella presentazione di questo libro: dalla caduta del muro di Berlino, un’intera generazione è passata senza che l’Italia vedesse realizzata nessuna delle riforme indispensabili per farne un Paese moderno. E la crisi economico-finanziaria di questi anni ha assestato il colpo di grazia a questa inerzia istituzionale, presentando un conto pesantissimo, che grava maggiormente sulle spalle delle categorie più deboli. In tal senso, i due discorsi di Napolitano riportati in queste pagine sono accomunati da un fil rouge che si potrebbe condensare nello slogan “più politica”. Più buona, più vera politica: perché quella cui abbiamo assistito ormai da troppi anni ha prodotto il mortificante risultato descritto ancora da Cacciari, fotografato in modo inequivocabile dalle elezioni del febbraio scorso: dove tre quarti degli italiani o non hanno votato, o hanno dato il proprio consenso a movimenti e leader estranei alle grandi culture politiche europee. E questo accentua ancora di più la lucida analisi di Napolitano nel discorso veneziano del 2012, quando segnalava il rischio di una politica che naviga sempre più a vista, che ha una dimensione sempre più asfittica, che si attacca a vecchie mappe ormai inservibili, mentre le nuove si rivelano ancora lontane da un disegno razionale e comprensibile.
Qui si inserisce una crisi non certo circoscritta alla sola Italia, che le parole del capo dello Stato tratteggiano con grande efficacia: si è logorata anche l’idea d’Europa dei padri fondatori, lasciando che la dimensione strettamente economica prevalesse su quella politica, finendo per oscurare completamente quest’ultima. La globalizzazione sembra aver disseminato una sorta di spavento in tutta la casa comune, alimentando la nascita di partiti anti-europeisti che dalla Gran Bretagna alla Finlandia, dall’Olanda al Belgio, dall’Austria all’Ungheria raccolgono crescenti consensi; e come hanno sottolineato autorevoli testate estere, da Le Monde a El Pais, a proposito delle elezioni italiane, in uno dei Paesi fondatori dell’Europa e fino a qualche anno fa tra i più europeisti come il nostro oltre metà dei voti sono andati a forze che contestano l’azione dell’Europa. Sono questioni da tenere assolutamente presenti anche in relazione al voto europeo dell’anno prossimo, perché i segnali di una profonda disaffezione vengono da lontano: nel 2009, l’affluenza è stata del 43%, venti punti in meno rispetto alla prima volta del 1979; e in 19 Paesi su 27 è rimasta sotto il 50%. Paul de Grauwe, capo dell'European institute dalla London school of economics e consulente del presidente della Commissione europea Barroso, paragona la casa comune a una bella villa senza tetto; ma c’è in realtà da chiedersi quanto consistente sia la calce utilizzata per le mura. Le parole di Napolitano pronunciate un anno fa a Venezia indicano in tal senso la strada maestra per l’uscita dalla crisi di consenso: dare alla politica un’anima europea, sintonizzando su di essa le singole politiche nazionali depurate dalle anguste visioni provinciali e settoriali che oggi ancora le contraddistinguono.
Ma qui entra in gioco una considerazione di fondo, che il capo dello Stato giustamente sottolinea: non può esserci democrazia senza i partiti. Un richiamo tanto più attuale oggi nel momento in cui emergono spinte verso la democrazia diretta, bypassando i corpi intermedi, e facendo leva sull’oggettivo discredito che troppi esponenti politici hanno alimentato con i loro comportamenti e con le loro omissioni. Naturalmente, perché ciò sia possibile è assolutamente indispensabile che i partiti si rinnovino, ribadisce ancora Napolitano. Un appello, il suo, ripetuto più volte prima e dopo il discorso di Venezia di un anno fa, e reiterato anche nel pronunciare il giuramento all’atto della riconferma del mandato presidenziale: la speranza è che non continui a cadere nel vuoto. Certo, non basteranno poche settimane né pochi mesi per riuscire a innescare un radicale rinnovamento; e in tal senso si rivela davvero un labor improbus, per ricorrere alle parole di Cacciari nell’introduzione al libro, quello che attende il presidente della Repubblica. Ma si può star certi che lo affronterà con quello spirito che tutti gli riconosciamo, e che fanno di lui un vero e proprio “patriota della Costituzione”, com’è stato giustamente definito.
In tal senso, credo vada sottolineato il forte messaggio che sale dal discorso del 2008, in cui il capo dello Stato pone la questione centrale di come far vivere la Costituzione in questa fase storica, in rapporto ad attese e domande della società che rimangono in larga parte inespresse. Qui si colloca a mio avviso un tema decisivo, che il Veneto ha ripetutamente posto (e non a caso Napolitano ne ha parlato proprio a Venezia), e che oggi sembra scivolato nell’oblio, e cioè quello del federalismo. La struttura delineata dal presidente nel suo intervento veneziano è chiarissima: un’unità nazionale che non può essere messa in discussione, ma che si rivela tanto più forte in quanto coniugata con un’articolazione territoriale pluralistica e autonomista. È un obiettivo inutilmente perseguito fin dal Risorgimento, e sul quale rimane tuttora troppa ignoranza istituzionale e storica, e troppa superficialità; ma che rimane centrale, magari rivisitando in profondità il ruolo e il pensiero di figure di federalisti esemplari, come quel Silvio Trentin che non a caso Napolitano ha voluto ricordare a Venezia.
Concludo con un passaggio strategico. Il presidente della Repubblica ha ripetutamente sollecitato il Paese a occuparsi e preoccuparsi delle giovani generazioni; e in uno dei suoi discorsi di fine anno ha giustamente sottolineato che un Paese che non lo faccia non può dirsi democratico. In questo libro c’è una sua frase che merita di essere richiamata: “Cercate, giovani, ogni varco per far sentire e valere le vostre ragioni, le vostre esigenze e per esprimere – ciascuno secondo le sue libere scelte – idee ricostruttive e innovatrici sulla politica”. Mi piace ricordare che si tratta di parole che riecheggiano singolarmente quelle pronunciate settant’anni fa da un grande umanista, Concetto Marchesi, nell’inaugurare da rettore l’anno accademico 1943-44 dell’università di Padova, in un momento certo molto più drammatico per il Paese di quanto non lo sia quello di oggi: “In nessuno di noi manchi, o giovani, lo spirito della salvazione. Quando questo ci sia, tutto risorgerà quello che fu malamente distrutto, tutto si compirà quello che fu giustamente sperato”. Due voci in piena sintonia, capaci di guardare al futuro anche quando il presente sembra restringere e immiserire gli orizzonti.
Giuseppe Zaccaria
Giorgio Napolitano. I discorsi veneziani. Venezia, Marsilio, 2013