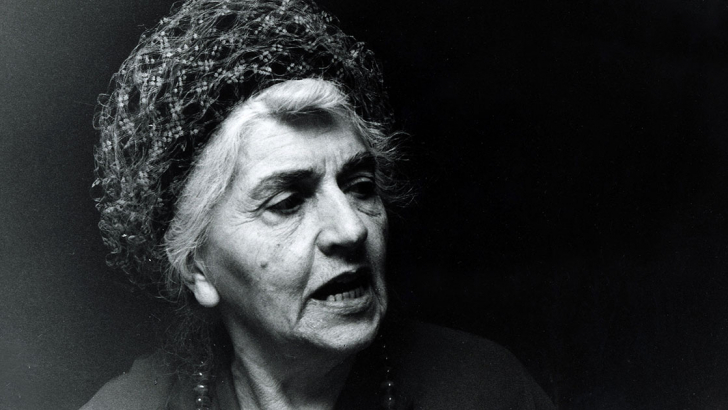SOCIETÀ
Il ritorno di Napolitano

Roma, Palazzo del Quirinale. Reuters/Alessandro Bianchi
La scelta di ripiegare nuovamente su Giorgio Napolitano come presidente della Repubblica attesta la crisi dei partiti italiani e in particolare quella del Pd, che non è riuscito a eleggere né un proprio candidato condiviso con il centro-destra, Franco Marini, né uno che avrebbe dovuto ricompattare il centro-sinistra e le diverse anime dei democratici, Romano Prodi, che ha invece prodotto la frattura del partito con il voltafaccia di oltre 100 grandi elettori.
Questa disfatta sancisce la fine o quantomeno la radicale trasformazione di un partito nato da una “fusione fredda” e che con ogni evidenza resta “un amalgama mal riuscito” (D'Alema). Se la leadership di Bersani è fallita, il problema più acuto è quello del rapporto con il proprio elettorato e con l’organizzazione nel territorio, molto disomogenea: l'establishment mai è parso così fortemente scollegato dalla propria base.
Il problema del Pd è stato quello di voler alleggerire la propria organizzazione rincorrendo il modello di un non ben precisato “partito liquido” senza capire al contempo che rafforzare la propria leadership era un passaggio ineliminabile in ogni società mediatizzata. I molti partiti personali proliferati sotto il cielo della seconda Repubblica, di cui quello di Berlusconi è solo l'esempio più chiaramente riuscito, non fanno che dimostrare quanto la capacità di entrare in sintonia con i mass media sia assolutamente necessaria per rimanere nell'agone politico.
Se il Pd è apparso privo di un leader riconosciuto e ben poco capace di rispondere a un progetto condiviso, la crisi riguarda però tutti gli attori coinvolti. Dopo oltre 50 giorni di completo stallo istituzionale in cui non sono riusciti a trovare un accordo per formare un governo, né hanno consentito al presidente di procedere a formarne uno con qualsiasi possibile etichetta: tecnico, di scopo, del presidente ecc., i partiti tradizionali si sono trovati nella paradossale situazione di dover chiedere a quello stesso presidente uscente di rimanere, quando aveva già precedentemente rifiutato, perché incapaci di convergere su un qualunque altro candidato.
Tra le forze che hanno fatto questa richiesta a Napolitano, oltre al Pd e il Pdl c’è persino la Lega Nord, che più volte ha dimostrato la sua insofferenza verso gli atti e le decisioni del primo presidente ex comunista. La conseguenza logica di questa richiesta è l'ammissione di non riuscire a decidere. Questa crisi colpisce non solo il partito democratico, forse destinato a scomparire come forza unitaria, ma anche gli altri partiti che non possono più definirsi i veri protagonisti della scena politica.
Il nocciolo del problema va ricercato qui, e non solo e non tanto in qualche modifica istituzionale o in generale delle regole del gioco. Che piaccia o meno, infatti, in ogni democrazia rappresentativa - con buona pace di Grillo, poiché non esistono le condizioni per una democrazia diretta e di sicuro non lo è la sua personale versione di e-democracy – sono i partiti a costituire l'unità di base della vita politica.
La maggior parte degli analisti parla di un necessario cambiamento in senso semipresidenziale; c'è però da chiedersi se cambiare le regole del gioco possa produrre ciò di cui il paese ha davvero bisogno. Le forme di governo non sono in sé giuste o sbagliate, positive o negative, ma devono rispondere alle esigenze di un paese. Se il problema italiano è quello di conseguire maggiore capacità decisionale e maggiore durata dei governi, allora la riforma in senso semipresidenziale può apparire una buona soluzione. Che, però, non garantisce necessariamente la capacità di attuare decisioni responsabili e utili al paese, soprattutto in un momento di forte crisi economica.
Che cosa accadrebbe se un'elezione diretta sancisse la vittoria di un leader populista, antieuropeista e con una capacità decisionale rafforzata in una situazione, come quella attuale, dove i meccanismi di accountability orizzontale (i vecchi checks and balances) sembrano non funzionare in maniera efficace?
Se negli ultimi tempi il peso della presidenza della Repubblica è stato sempre più determinante, questo è accaduto proprio perché i partiti hanno dimostrato la loro debolezza; di conseguenza, il problema prioritario rimane quello di rafforzare i partiti, che rappresentano il cuore della democrazia rappresentativa, piuttosto che la Presidenza della Repubblica, che in quest’ottica non può che essere il secondo passo di un rinnovamento complessivo.
A struttura istituzionale invariata (repubblica parlamentare), il profilo migliore per ricoprire la carica di presidente sarebbe dovuto essere quello di una persona con una esperienza politico-istituzionale di rilievo, capace di impegnarsi efficacemente nel difficile gioco di mediazione tra i partiti; che vantasse un riconoscimento internazionale perlomeno a livello europeo, dato che la gran parte delle politiche pubbliche sono decise in quella sede; in grado di far convergere il voto di più forze, quindi senza eccessiva caratterizzazione di parte; preferibilmente più giovane dell'attuale presidente, infine, e magari anche di genere diverso. Molti dei nomi proposti avevano almeno in parte queste caratteristiche: Marini, Rodotà, lo stesso Prodi, Bonino, Cancellieri; ma sono stati bruciati.
Se la forma delle istituzioni cambiasse, sicuramente queste caratteristiche non sarebbero più fondamentali e il presidente potrebbe essere una figura molto più divisiva di quelle proposte, con minore esperienza politica, quasi certamente euroscettico o peggio con l'intenzione di lasciare l'Ue, poiché questo atteggiamento al momento paga di più a livello elettorale. Tra le caratteristiche auspicate rimarrebbe forse la più giovane età; quanto al cambiamento di genere, non scommetterei.
Non si vuole negare che ci sia bisogno di riformare le istituzioni, anzi; ma è indispensabile capire come riformarle, poiché senza una chiara visione o pasticciando tra un esempio straniero e l'altro non si produrrà alcun esito positivo.
Per fare un esempio, è forse utile ricordare che in caso di elezione diretta, le tre forze politiche maggiori avrebbero presentato per la presidenza i rispettivi leader, nell’impossibilità di avanzare candidati più neutrali. Ed è molto probabile che in elezioni di quel tipo risulterebbero decisive la capacità di gestire i mass media e la campagna elettorale piuttosto che il progetto offerto al paese.
Una repubblica semipresidenziale, infine, se da un lato potrebbe garantire maggiore capacità decisionale nel caso di un presidente con una maggioranza parlamentare consonante, dall’altro rappresenterebbe indubbiamente un’incognita riguardo l'esito di una possibile coabitazione, perché i partiti (e l’elettorato) polarizzati che abbiamo resterebbero. O pensiamo di importare anche quelli dalla Francia?
Selena Grimaldi