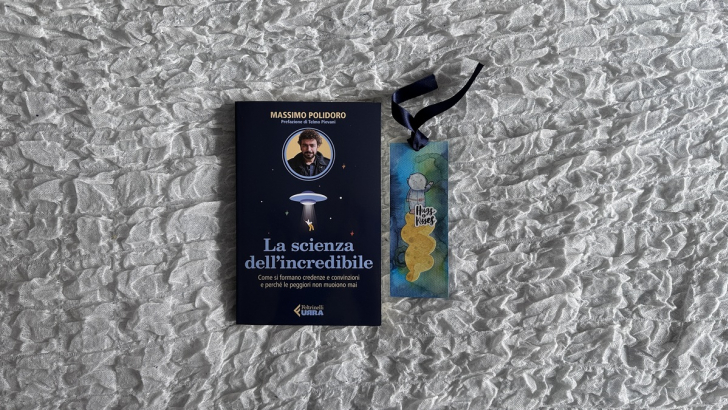SOCIETÀ
Le teorie del complotto hanno origini antiche

“Le vaccinazioni causano l'autismo, il cambiamento climatico è una bufala, il tabacco fa bene, l'Aids è un'invenzione del governo degli Stati Uniti e ora la Terra è piatta di nuovo. Molte affermazioni scientifiche accettate come dato di fatto da parte della comunità degli esperti sono soggette a controversie pubbliche e, a volte, al completo rifiuto. Quando fette consistenti della popolazione rifiutano i risultati della ricerca in campo medico ad esempio, si rischiano conseguenze negative per la salute, come nel caso dei movimenti antivaccinisti”. Stephan Lewandowsky, recentemente ospite all’università di Padova, in un articolo su Psychological Science mette in guardia dai pericoli che possono derivare dalle teorie del complotto. Un fenomeno che ha origini lontane, ma ancora particolarmente attuale a giudicare dai numerosi blog e bufale che circolano in rete e non solo.
La prima volta che si parla di complotto, spiega lo storico Paolo Preto, è nel 1614, anno in cui si accreditò l’idea di una cospirazione dei Gesuiti in tutta Europa per impadronirsi del potere nella Chiesa e nella società. Fu una convinzione, quella del complotto generale contro i poteri costituiti, che galoppò molto velocemente e che a distanza di circa 70 anni fu riferita anche alla massoneria nelle sue varie declinazioni. Accanto ai massoni fu poi la volta degli ebrei. L’abate Augustine Barruel (1741-1820), tra gli altri, imputava la causa della rivoluzione francese a “un’occulta e diabolica cospirazione massonico-ebraica contro la fede e il potere politico”.
Gli esempi da citare potrebbero essere molti. Si pensi, in ambito scientifico, all’ingegnere e astronomo austriaco Hanns Hörbiger (1860-1931) noto per la “teoria del ghiaccio cosmico” secondo cui la via Lattea sarebbe stata un blocco di ghiaccio frammentato. Un’ipotesi (ovviamente falsa) che non fu priva tuttavia di conseguenze, se si considera che nella Germania nazista alcuni scienziati appoggiarono le idee di Hörbiger imputando la posizione dei suoi detrattori a un complotto della scienza democratica e laica contro le teorie innovative della scienza germanica. C’è poi la vicenda del biologo austriaco Paul Kammerer (1880-1926), sostenitore della teoria della ereditarietà dei caratteri acquisiti, che fu tacciato di aver contraffatto i risultati di alcune ricerche con cui dimostrava i suoi assunti. Kammerer si suicidò professando la sua innocenza (i dati in realtà erano stati effettivamente falsati) e, spiega Preto, ci fu chi considerò la vicenda come una congiura degli aristocratici e degli ambienti conservatori reazionari per stroncare le teorie di Kammerer.
Le ragioni che alimentano le teorie del complotto e il rifiuto di determinati paradigmi scientifici possono essere molteplici. Secondo Preto i complotti sono per definizione autoreferenziali. “L’individuo si autoassolve dall’impegno civico, sociale, politico perché la teoria del complotto è di per sé consolatoria, deresponsabilizza i singoli dagli eventi socio-politici e scientifici della storia”. Le teorie del complotto, secondo Lewandowsky, rassicurano gli individui che le sostengono, danno la sensazione che esista qualcuno che controlla gli eventi.
In molte circostanze è la disinformazione a fare da padrona, come nel caso della presunta relazione tra vaccino trivalente (morbillo, parotite e rosolia) e autismo. Nonostante sia stata ormai ampiamente dimostrata l’inesistenza della relazione, frutto in realtà di una frode imbastita nel 1998 dal medico Andrew Wakefield, ancora oggi c’è chi crede alla teoria. Anche i media del resto fecero la loro parte, dando largo spazio allo studio fasullo pubblicato su The Lancet e in seguito ritirato. “Intanto – sottolinea Pietro Greco – i buoi sono scappati dalla stalla: molte mamme e molti papà hanno deciso di non vaccinare i loro figli. La cattiva informazione ha generato un rischio per l’intera società, oltre che per i singoli”. La conseguenza immediata fu un calo delle vaccinazioni nel Regno Unito e in molti altri Paesi.
In alcune altre situazioni determinate scoperte scientifiche possono essere in contrasto con la visione del mondo delle persone o con la loro ideologia politica e religiosa e questo può determinarne il rifiuto. “Molti processi cognitivi – scrive Lewandowsky in The debunking handbook, tradotto anche in lingua italiana: Il manuale della demistificazione. Come sfatare i miti della disinformazione – possono fare in modo che le persone elaborino inconsciamente le informazioni in modo non obiettivo. Per coloro che hanno opinioni ben radicate, l’affrontare controargomentazioni può indurre a rafforzare il proprio punto di vista”. In pratica può accadere che le persone scelgano selettivamente le informazioni che sostengono i loro punti di vista (processo cognitivo noto come “bias di conferma”). Da non trascurare è anche la propensione di alcuni a credere nel paranormale, atteggiamento che recenti studi mettono in relazione con la tendenza ad assecondare teorie di tipo complottistico e affermazioni pseudoscientifiche.
Infine possono avere un peso motivazioni di tipo economico o politico. Sembra, ad esempio, che i sostenitori del libero mercato siano meno inclini ad accettare le teorie sui cambiamenti climatici, dovuti invece secondo la comunità scientifica internazionale alle attività umane e in particolare all’uso dei combustibili fossili. Si tratta evidentemente di un settore più politicizzato di altri e l’eventuale volontà politica di contrastare il climate change potrebbe costituire una minaccia per l’economia del lassaiz-faire. Se dunque i processi cognitivi influiscono sulle posizioni dei singoli nei confronti della scienza, anche i fattori politici, ideologici ed economici possono avere un peso non trascurabile.
Monica Panetto