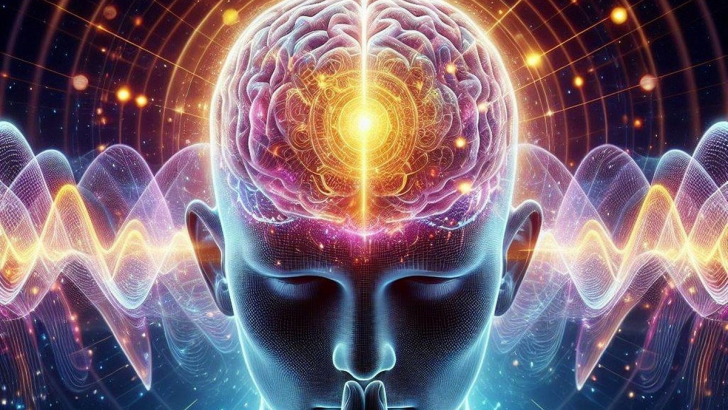SCIENZA E RICERCA
Contro l'Aids, correggiamo le cellule

Foto: Reuters/Wolfgang Rattay
Lo scorso 6 marzo il New England Journal of Medicine pubblica un articolo, Gene Editing of CCR5 in Autologous CD4 T Cells of Persons Infected with HIV in cui Pablo Tebas, docente della University of Pennsylvania di Philadelphia e direttore dell’Adult AIDS Clinical Trials Unite, e venti suoi collaboratori annunciano che una opportuna “correzione” del gene CCR5 sembra rendere le cellule immunitarie CD4 resistenti all’attacco del virus HIV. E soprattutto che le infusioni delle cellule “corrette” si è dimostrata sicura, nei limiti dello studio. Lo studio ha riguardato 12 diversi pazienti cui sono state infuse miliardi di cellule CD4 modificate. La “terapia genica”, dunque, non solo funziona nel prevenire l’Aids, ma sembra non avere effetti collaterali. È sicura, appunto.
Il 19 febbraio scorso il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York annuncia che un gruppo di suoi collaboratori ha portato a termine il più esteso studio mai effettuato su pazienti con leucemia avanzata, ottenendo una percentuale di remissione completa pari all’88% grazie all’impiego di una versione modificata geneticamente delle loro stesse cellule immunitarie. Lo studio è stato pubblicato quel medesimo giorno sulla rivista Science Translational Medicine e indica (sembra indicare) che la terapia genica funziona anche contro questo specifico tumore.
Il 16 gennaio 2014 la rivista The Lancet pubblica un articolo di Robert McLaren, in forze al Nuffield Laboratory of Ophthalmology, dipartimento di meuroscienze cliniche della University of Oxford in Inghilterra, e di un gruppo di suoi collaboratori in cui già nel titolo annunciano che la terapia genica sembra funzionare in pazienti ammalati di coroidermia, una rara malattia agli occhi di origine, appunto, genetica.
Potremmo continuare a lungo con questo elenco. Perché non passa mese, ormai, che non vengano annunciati i risultati promettenti di studi clinici sull’efficacia della lotta alle malattie attraverso tecniche di intervento sui geni. Insomma, attraverso la terapia genica. Tanto che, lo scorso mese di ottobre, in seguito a un ennesimo successo, questa colta contro l’ADA-SCID, il deficit dell’enzima adenosina deaminasi che genera una delle immunodeficienze combinate gravi, nota come la “bubble kid disease”, la malattia dei bambini nella bolla (i pargoli che ne sono affetti devono vivere in una bolla per evitare le infezioni) la più nota rivista inglese di divulgazione, The New Scientist, titolava: il successo contro la “bubble kid desease” riporta la terapia genica sulla giusta rotta. E lo scorso marzo, Ricki Lewis ha scritto un articolo sulla rivista di divulgazione più nota al mondo, The American Scientific, dal titolo ancor più significativo: terapia genica, atto secondo.
Il prologo della terapia genica risale agli anni Settanta del secolo scorso, quando Theodor Friedmann e Richard Roblin pubblicarono su Science un articolo il cui titolo, più che una domanda, era un suggerimento: una terapia genica per le malattie genetiche umane? Lo sviluppo delle prime tecniche di ingegneria genetica sembrava rendere possibile un approccio risolutore alle malattie genetiche: sostituire il gene malato con il gene buono. Le speranze erano moltissime. Ma ci vollero 20 anni per passare dal prologo al primo atto, che inizia il 14 settembre del 1990, quando William French Anderson tenta di curare con una terapia genica una bambina di quattro anni ammalata proprio di SCID. La tecnica ebbe successo. Ma solo per un breve lasso di tempo.
Nel 1992 le speranze si riaccendono quando l’italiano Claudio Bordignon, all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, realizzò il promo esperimento di terapia su cellule staminali (ematopoietiche, per la precisione). Ci vollero ancora dieci anni perché la tecnica potesse essere applicata contro l’ADA-SCID. Ancora una volta si accese la speranza. Ma ancora una volta dopo il successo la parziale delusione. Su dieci bambini trattati a Parigi con questo metodo, due si ammalarono di leucemia. Divenne chiaro a tutti che lo strumento è potente, ma difficile da controllare. Fine del primo atto.
Difficile dire quando il secondo atto è iniziato. Forse nel 2006, quando Luigi Naldini e Brian Brown dell’Istituto Telethon per la terapia genica del San Raffaele, sempre a Milano, misero a punto una tecnica capace di prevenire il rigetto dei “geni buoni” ma estranei da parte del sistema immunitario. O forse la data giusta è il 2012, quando la FDA (Food and Drug Administration) degli Stati Uniti approva la prima cura con terapia genica della talassemia e l’EMA (l’agenzia medica europea) raccomanda l’utilizzo del Glybera, un trattamento della LPLD, la deficienza della lipoproteina lipasi, una malattia che compromette il funzionamento del pancreas. La Commissione europea ha fatto propria la raccomandazione e così da qualche mese Glybera è diventato il primo farmaco di terapia genica utilizzato al mondo.
Ora siamo nel pieno del secondo atto. Alla fine del 2013 erano in corso 2.000 sperimentazioni cliniche, di cui 100 in fase III: ovvero una fase di studio che coinvolge molti centri e molti pazienti. Alcuni di queste sperimentazioni cliniche dimostrano che, 30 anni dopo, possiamo iniziare a rispondere con un cauto sì alla domanda di Theodor Friedmann e Richard Roblin: la terapia genica può funzionare, senza causare danni. Tuttavia esistono ancora molti problemi non risolti. Alcuni di carattere biomedico. Ma altri di carattere economico. Come dimostra il caso Glybera, che non è solo il primo farmaco di terapia genica, ma è anche il farmaco più caro al mondo. Un trattamento di cinque anni costa oltre un milione di euro. Chi se lo potrà permettere? E, più in generale, chi pagherà il conto della terapia genica?
Pietro Greco