SOCIETÀ
Tecnologia e nuove schiavitù
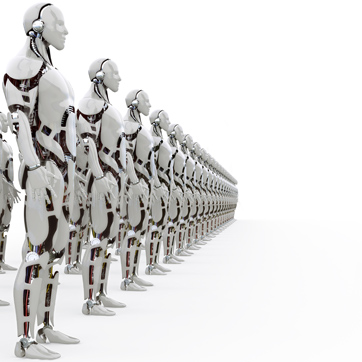
Un albergo californiano ha cominciato l’estate scorsa a testare il maggiordomo elettronico, capace di consegnare articoli di natura varia, dalla lametta per il rasoio allo shampoo, direttamente nelle camere dei clienti. In un ospedale di Seattle, è un robot a somministrare sedativi ai pazienti. Più di recente, Amazon ha annunciato lo schieramento nei propri magazzini di oltre 15.000 nuove macchine, in grado di caricare, depositare e spostare merci più rapidamente dei colleghi umani. Sono questi solo alcuni esempi di come le nuove tecnologie stanno eliminando sempre più posti di lavoro in settori dell’economia anche molto diversi l’uno dall’altro. Ma l’innovazione sta trasformando la vita dei lavoratori americani, in particolare quelli più giovani, anche in una seconda maniera, meno visibile al pubblico. Ne sta riorganizzando gli orari – rendendo loro la vita impossibile – nel tentativo di rendere i grandi business più efficienti e redditizi.
Uno studio pubblicato recentemente dalla University of Chicago rivela che il 41% di lavoratori tra i 26 e i 32 anni di età viene informato dei propri orari lavorativi con appena una settimana d’anticipo, se non meno. L’analisi stima inoltre che, nel corso di un mese, le ore fatte da questi lavoratori subiscono variazioni del 37% in media rispetto a quelle che essi considerano abituali. Infine, oltre la metà di essi non viene minimamente consultata in merito dal proprio datore di lavoro (per la precisione, lo studio riguarda in particolare i dipendenti pagati a ore, che negli Stati Uniti rappresentano il 56% dei lavoratori e il 62% delle lavoratrici). Un fenomeno questo che interessa le professioni più diverse e colpisce il 90% di chi lavora nella ristorazione, la metà circa di chi è impiegato nella vendita al dettaglio, e un terzo di professionisti, inclusi gli avvocati, gli esperti di risorse umane, i programmatori e via dicendo. A soffrirne in particolare sono i lavoratori con figli piccoli, tra cui il 69% delle madri e l’80% dei padri vedono le proprie ore lavorative ondeggiare regolarmente del 40% rispetto a quella che sarebbe la norma.
“Solitamente si pensa che questo problema riguardi solo i lavoratori meno qualificati – dice Susan Lambert, docente della School for Social Service Administration di University of Chicago e autrice principale dello studio – Invece la conclusione più importante della nostra ricerca è che questa pratica è molto diffusa”. Secondo Lambert, che si occupa della questione da ormai oltre quindici anni, non si tratta necessariamente di una nuova realtà. Ma le tecnologie l’hanno senz’altro estremizzata. “I software permettono ai datori di lavoro e ai manager di controllare le performance dei propri dipendenti e il ritmo delle vendite di minuto in minuto, e questo fa sì che si possano continuamente ritoccare gli orari lavorativi”, dice Lambert.
In agosto, il New York Times ha dedicato al tema un lungo articolo, in cui si raccontava in particolare la storia di Janette Navarro, ventiduenne, madre single di un bimbo di quattro anni e barista per Starbucks, una delle aziende che impiegano questo sistema. In un tipico weekend estivo, a Navarro veniva chiesto di rimanere fino alle 23 di sabato sera e di fare poi anche l’apertura alle quattro della mattina dopo. Inoltre, Navarro raramente veniva a conoscenza dei propri orari lavorativi con più di tre giorni di anticipo, cosa che la gettava ogni volta nel panico dovendo trovare qualcuno che fosse disponibile all’ultimo minuto a badare al figlio. Il continuo fluttuare delle sue ore, oltre a non darle nessuna garanzia sulla paga complessiva che avrebbe racimolato in un mese, l’aveva costretta infine a mettere in pausa le proprie aspirazioni universitarie, giacché Navarro non sapeva mai se avrebbe potuto recarsi a lezione o meno.
Se la tecnologia consente ora a Starbucks di misurare esattamente l’andamento delle vendite in tempo reale e in ognuno dei propri punti vendita, e di dispiegare di conseguenza i propri dipendenti, organizzandoli in squadre più o meno numerose e produttive sulla base dei dati e modificandone continuamente gli orari per massimizzare il profitto, è difficile immaginare che questo sistema produca una forza lavoro particolarmente soddisfatta e entusiasta. Il che significa che, oltre che a rovinare la quotidianità dei lavoratori, questo approccio rischia anche di diventare controproducente. “Non mi sembra che abbia un gran senso, se non per quelle occupazioni in cui la performance dell’individuo è pressoché irrilevante, come nel caso dei cassieri dei supermercati – dice Lambert – Abbiamo decenni di studi alle spalle che ci dicono che quando la gente è impiegata in ruoli ben strutturati e stabili, si impegna di più nel proprio lavoro e diventa più produttiva”.
Cosa fare dunque? Secondo Lambert bisogna innanzitutto coinvolgere in questo dibattito tutte quelle aziende, e ce ne sono tante, che vogliono trovare il modo di soddisfare sia i propri impegni commerciali sia il bisogno di stabilità dei propri dipendenti, sviluppando assieme a esse nuove soluzioni che mettano le nuove tecnologie al servizio di questo obiettivo. “È vero però che ci sono altre imprese il cui modello operativo si scontra direttamente con i diritti di base dei dipendenti – conclude Lambert – Il fatto è che negli Stati Uniti è dal 1938 che non rafforziamo le protezioni dei lavoratori e quindi c’è bisogno di nuove leggi”.
Valentina Pasquali




