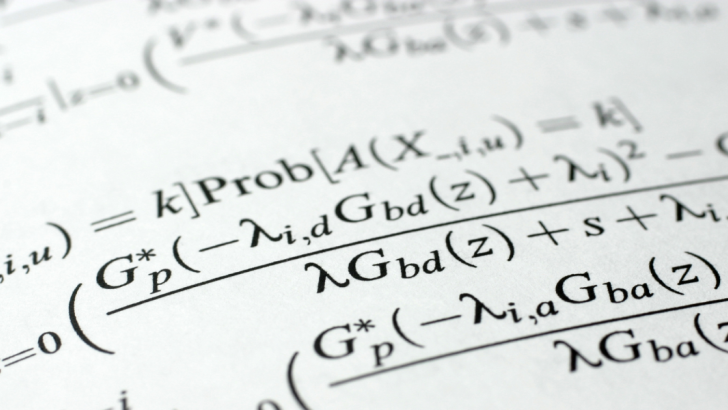Con la legge 17 luglio 1919 sulla capacità giuridica della donna, nota come legge Sacchi (dal nome del ministro di Grazia e Giustizia, Ettore Sacchi, che ne fu artefice), fu finalmente abolito nel nostro paese quell’istituto dell’autorizzazione maritale contro cui il movimento femminista per cinquant’anni aveva cercato invano di promuovere un’iniziativa politica. Con la cancellazione dell’autorizzazione maritale e l’accesso femminile a molte professioni, la legge Sacchi rappresentava nei fatti per le italiane una forma di ricostituzione di cittadinanza, anche se non ancora paritaria. Il regolamento dispositivo (R. D. 4 gennaio 1920) introdusse una serie di limitazioni all’accesso femminile alle professioni (in particolare quelle collegate al potere d’imperium), su cui si innestò successivamente l’intervento discriminante del fascismo.
“ Ma che cos’era precisamente l’autorizzazione maritale?
In sintesi si può dire che era la norma che sanciva la minorità femminile dentro la famiglia, prevista esplicitamente dall’articolo 134 del Codice civile unitario del 1866: «La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l’autorizzazione del marito».
Nel 1866, infatti, era entrato in vigore il primo Codice civile del Regno d’Italia, conosciuto col nome del ministro Giuseppe Pisanelli che lo promulgò. Sul modello del codice sabaudo (1837) e del Codice napoleonico (1804), in materia di cittadinanza femminile esso introduceva una costruzione giuridica che può essere definita come una sostituzione dell’autorità maritale a quella patriarcale propria delle società d’ancien régime. La subordinazione femminile alla potestà del marito era appunto fissata dall’autorizzazione maritale che, in nome dell’unità della famiglia, vincolava alla volontà del coniuge la possibilità delle mogli di gestire il patrimonio familiare e gli stessi beni personali (detti parafernali), e (fino al 1877) anche di tutelare per via giudiziaria i propri interessi. La disparità veniva poi confermata dalla disuguaglianza prevista per la richiesta di separazione (non ammesso il divorzio) e per la facoltà, riconosciuta al solo marito, di dare prescrizioni in sede testamentaria sull’educazione dei figli e la gestione patrimoniale. Si trattava di una pesante limitazione imposta all’autonomia femminile, avvertita oltre la sfera economica come una decurtazione della capacità civilistica delle donne sposate, e si collegava a una condizione generale di cittadinanza debole: la cittadinanza femminile nell’Italia liberale risultava debole perché le donne non trasmettevano il nome ai loro figli, perché solo il figlio di cittadino maschio godeva della cittadinanza italiana, perché, appunto, equiparate a dei minori una volta sposate, perché escluse dalle libere professioni e dai gradi superiori dell’istruzione.
“ D’altra parte sul piano della cittadinanza politica le disposizioni normative dello stato liberale non erano meno discriminatorie (e contraddittorie)
Da una parte, l’esclusione femminile dal voto amministrativo era contemplata esplicitamente nella legge per le elezioni locali (sia del 1865 che del 1888), cancellando il diritto che, per l’influenza della tradizione giuridica austriaca, era assicurato alle possidenti nei territori della Toscana e del Lombardo-Veneto; dall’altra, di tale esclusione non si riteneva di dover fare neppure menzione nelle leggi elettorali a livello politico.
Fu durante la Prima guerra mondiale che la classe dirigente liberale avvertì sempre più l’insostenibilità delle norme limitative della cittadinanza femminile, davanti alla straordinaria mobilitazione delle italiane sul ‘fronte interno’. Un primo progetto per superare l’autorizzazione maritale fu presentato alla Camera dal deputato liberale Amedeo Sandrini, che nel giugno 1916 sarebbe confluito in un unico progetto di legge con l’analoga proposta del socialista Giuseppe Canepa. Nella richiesta di abolizione dell’articolo 134 del Codice civile il ruolo svolto dalle italiane durante la guerra aveva un notevole rilievo, così come lo avrà nei dibattiti e nelle proposte sull’ammissione femminile al suffragio. Non a caso l’onorevole Sandrini nella sua relazione al progetto sosteneva che il riconoscimento dell’uguaglianza giuridica costituiva «un doveroso atto di gratitudine per quanto la donna italiana ha fatto e fa in questi terribili momenti», oltre che una più generale apertura all’evoluzione storica. Un ulteriore fattore, inoltre, contribuiva ad accelerare l’iniziativa politica in questa direzione: nelle terre ancora in mano agli austriaci, infatti, la condizione giuridica delle donne era notoriamente più liberale che in Italia e quindi –ammetteva Sandrini- non sarebbe stato possibile «togliere alle donne delle popolazioni redente una situazione giuridica favorevole, che già avevano».