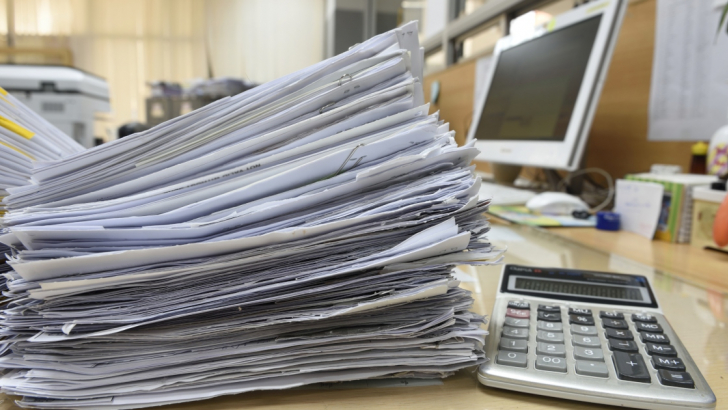SOCIETÀ
Alle origini delle smart cities c’è la burocrazia creativa

Una sosta di lettura e relax all'interno dell'High Line park di New York, realizzato lungo un ex percorso ferroviario. Foto: Reuters/Lucas Jackson
“Where are we going?” Esordisce così Charles Landry, ospite a Padova, durante una delle molte conferenze che l’urbanista, profeta delle "città creative", tiene in tutto il mondo per propagandare un modo diverso (il suo, in particolare) di guardare all’ambiente urbano postindustriale. Un’idea non a caso maturata nell’Inghilterra degli anni Ottanta, all’epoca della Thatcher e delle sue riforme “lacrime e sangue”. Da allora il verbo delle great cities si è diffuso, anche grazie al contributo degli epigoni di Landry, come l’economista americano Richard Florida, autore del bestseller The Rise of the Creative Class.
Dove stiamo andando? Che strumenti si possono adottare per sopravvivere all’involuzione urbana? come impiegare diversamente le risorse in nostro possesso per creare spazi produttivi vivibili, fluidi e attraenti? Landry parte dalle domande che tormentano politici e imprenditori nella ricerca di una via d’uscita all’attuale situazione di crisi per spiegare la “città 2.0”. Una sorta di urbanità civile che si sovrappone e supera la 1.0 definita solo dalla componente ingegneristica, dall’hardware fatto diedifici e strade. Nella città creativa, vero guscio delle ammiccanti smart cities di oggi, lo spazio assume infatti una dimensione emotiva. Ingredienti? La comunicazione, l’accessibilità, la creazione di opportunità, lo sviluppo di una coscienza collettiva, l’espressione personale, la connessione agli ampi network, l’interculturalità.
La città creativa non è il dominio dell’artista, ma l’ambiente in cui chiunque può trovare la strada per esprimersi, grazie a un ampliamento semantico del termine che comprende creatività in ogni settore: politico, amministrativo, sociale, imprenditoriale. E si compone anche di una "burocrazia creativa" capace di guardare non solo al rispetto delle regole formali ma anche di progettare interventi sul lungo periodo, con obiettivi chiari da condividere con i cittadini. Uno scenario come quello che si è realizzato a Washington, con il progetto Apps for democracy, o in Olanda attraverso il network Civil Servants 2.0, che apre alla collettività la discussione sull’uso dei social media nei servizi pubblici.
“Anche Helsinki, dove ho lavorato, era una città molto burocratica, ma ha trovato nuovi modi per governarsi, diventando vivace e fluida”. La capitale finlandese, infatti, si appoggiò all'urbanista per studiare una soluzione alla propria mancanza di attrattività verso investitori, uomini d'affari e turisti. La città, si constatò, era del tutto assente dal panorama culturale europeo. Bastava però mettere l'accento sull'alto livello dei servizi, delle infrastrutture e della qualità della vita, e Helsinki ottenne di diventare nel 2000 Capitale europea della cultura e luogo di vasti investimenti.
Il più delle volte le amministrazioni non sono in grado di fare questi passi agilmente. Ancorate a modelli passati cercano spesso soluzioni a problemi non più attuali. Per Landry meglio cambiare strategia. Nella direzione di città che si “autoregolano”, contando sulla creatività di soluzioni capaci di renderle magnetiche, polo di attrazione di persone di talento, a loro volta ispiratrici per altri. “Sempre più francesi, ad esempio”, spiega, “aprono nuove attività a Londra, contribuendo così a vivacizzare una scena economica già vitale. Questo perché la capitale inglese è meno rigidamente burocratica, e consente di avviare imprese economiche in tempi ridotti”. Sul magnetismo londinese si allungano però anche delle ombre: perché gli investitori stranieri (tra i quali, nelle prime posizioni gli italiani) hanno anche interessi molto hard, nel settore del mattone in particolare, esercitando una pressione crescente sul mercato delle case londinesi e sulla popolazione cittadina.
Attrarre persone di talento, persone che poi sono in grado di influire sui luoghi in cui vivono, non è certo una questione burocratica . “Le persone di talento vogliono posti belli in cui vivere”. Posti in cui riconoscersi, luoghi distintivi che rifuggano dall’uniformità e che siano in grado di costruire ponti fra le persone della comunità e fra questa e l’esterno. Senza però rinunciare all’esclusività.
“Il mondo sta cambiando giorno dopo giorno in modo sconvolgente. Agire secondo criteri creativi è una questione di sopravvivenza, altrimenti si rischia di fallire. Siamo di fronte a grandi cambiamenti, soprattutto economici, anche in virtù dello spostamento a Oriente dei poli di produzione mondiali”. Secondo Landry, dunque, la città del futuro non è l’avveniristica Dubai, troppo ancorata a modelli ingegneristici 1.0. Il futuro è in luoghi che hanno il coraggio di ripensare se stessi, in cittadini e governanti in grado di dare vita a un approccio diverso alla città; in iniziative come quelle di “Chicago, che ha cancellato l’autostrada e rivitalizzato la zona del fiume. O di New York, dove chilometri di rotaie sopraelevate sono state convertite in parco”.
In Italia Landry è sbarcato a Mantova, con la sua società di consulenza, per lavorare sull’identità della città: a partire dalle radici legate alla stampa, si è puntato su una serie di iniziative in cui i libri sono i protagonisti. Elementi che ne hanno accreditato il ruolo centro editoriale di qualità e attirato imprenditori, stampatori, designer e commercianti. È a Bilbao, invece, che l’urbanista ha misurato per la prima volta, attraverso l’elaborazione di dieci indicatori, l’“indice di creatività” di una città consapevole del proprio carico innovativo, ma fino a quel momento estranea alle logiche della città 2.0.
Nelle parole di Landry c’è spazio anche per Padova: dall’esempio negativo di piazzale Stanga (“la città creativa è l’opposto di questo”, commenta) alle azioni che la rendono più vivibile e più “mobile”, come la pedonalizzazione del centro storico e l’uso del bike sharing, che rappresenta una condivisione di risorse collettive. Si sbilancia anche sul progetto per l’auditorium: “Quante persone lo utilizzeranno: 3.000? 5.000? Per valutare bisogna considerare se sarà più utile quella struttura o invece potrebbe muovere più energie dare ai giovani spazi condivisibili e flessibili, dei veri contenitori di opportunità”.
Certo i progetti dei grandi architetti contribuiscono a dare qualità alla città, ma rappresentano singoli episodi. Il passo in avanti sta nel considerare la città non come un aggregato di elementi isolati, ma come un unico grande progetto. Alla fine, è il risultato di operazioni semplici ma attentamente progettate a dover rendere la città migliore della somma delle sue parti. Facile, almeno a parole.
Chiara Mezzalira
Carlo Calore