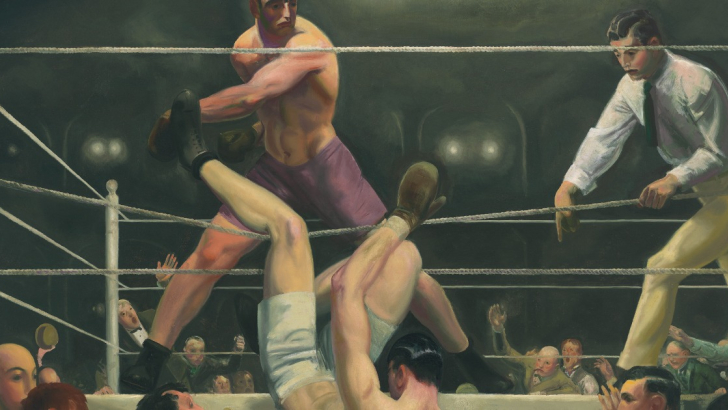Come cambia l'immaginario cinematografico in tempi di globalizzazione

Che ci si trovi a New York sulla Quarantaduesima Strada, in un amorfo vialetto suburbano di St Paul, Minnesota, o su una spiaggia californiana, capita abitualmente a un forestiero in visita negli Stati Uniti, di avere la sensazione di essere capitato sul set di un film. Allo sguardo di chi viene da fuori, l’America (leggi: gli Usa) è prima di tutto il suo cinema, quei paesaggi metropolitani o rurali che, pellicola dopo pellicola, hanno costruito agli occhi di miliardi di persone in tutto il mondo un paese immaginario e al tempo stesso reale, a volte piacevole, più spesso violento e a tratti perfino sordido, eppure sempre in qualche modo stranamente desiderabile perché bigger than life.
Hollywood, ovvero una delle più potenti “armi di distrazione di massa” che si siano mai viste: così l’ha definita il giornalista canadese Matthew Fraser in un saggio – Weapons of Mass Distraction il suo titolo, appunto – troppo incline a sostenere la bontà dell’impero americano portatore di democrazia nel mondo (tanto per dire, “Sì, decisamente le cose vanno meglio quando c’è Coca Cola” è la frase finale), ma acuto nel cogliere l’importanza della parallela affermazione, nell’arco di un secolo, del cinema americano e degli Stati Uniti come superpotenza mondiale e nell’insinuare il dubbio che la forza trainante degli Usa nel pianeta sia stato proprio il grande schermo, e non viceversa, come di solito si crede.
Fraser è, però, in ritardo sui tempi: nel 2003, quando il suo libro esce per la casa editrice di Toronto Key Porter, sembra non accorgersi che quell’epoca è finita, travolta dalla globalizzazione – chi di spada ferisce di spada perirà – e sepolta dall’11 settembre. Eppure l’indicatore, l’anno prima, era stato fin troppo evidente: il taglio, in fase di postproduzione, di alcune sequenze dello Spider Man diretto da Sam Raimi, dove si vedeva una enorme ragnatela intessuta dal supereroe tra le due Twin Towers, segnalava in modo chiaro la debolezza di un paese ferito, che temeva di esporre i propri traumi. Traumi che, complice (o causa prima) la crisi infinita che stiamo attraversando, non sono più guariti. Tanto che adesso – scrive il critico cinematografico Tom Shone su “Slate” in un articolo intitolato Un-American Activities – l’ America come location è quasi scomparsa dai film hollywoodiani.
Ricordate – riflette Shone – i tempi in cui John Ford girò un tale numero di film nella Monument Valley (sette in 25 anni) che l’area al confine fra Utah e Arizona divenne famosa con il nome stesso del regista, la John Ford Country? E sapete che Hitchcock usava addebitare agli studios i conti delle sue vacanze in giro per gli Stati Uniti, tanto era sicuro che in questo modo avrebbe trovato nuove location per le sue pellicole? E più vicino a noi, che ne dite della Manhattan di Woody Allen, della Little Italy di Scorsese, della Los Angeles di Michael Mann? Oggi, sostiene il critico, nessun regista giovane potrebbe eguagliare quel livello di embeddedness e anche i “vecchi” (Allen o Scorsese, appunto) sembrano fin troppo desiderosi di spostarsi verso altri lidi: l’Europa o, magari, quello che Shone definisce il movieverse, l’universo fittizio e digitale di film come Avatar o Batman.
Soltanto pochi autori coraggiosi continuano a pensare le loro storie sullo sfondo di luoghi conosciuti e – a volte, non sempre – amati: come i fratelli Coen, fedeli nella loro rappresentazione di un’America profonda e comunque straniata, il contrario della homeland, o come l’assai meno famoso James Gray (tre film ambientati a Brighton Beach) che, interpellato dal critico, attribuisce questa fuga generalizzata dagli States all’avidità degli studios pronti a tutto pur di ingraziarsi il pubblico globale e quindi ostili a qualsiasi specificità. Teoria non nuova e forse non del tutto campata per aria, se è vero che dal 1993, anno fatidico nel quale Jurassic Park ricavò più soldi dall’estero che dal mercato interno, i produttori americani hanno cercato di replicare più e più volte il miracolo. Ma, anche, teoria monca, dal momento che la omogeneizzazione dei prodotti culturali non è un fenomeno solo americano o solo circoscritto al cinema, basti pensare ai tristi effetti editoriali del successo planetario di Harry Potter. Senza contare che, forse, si potrebbe azzardare un’altra ipotesi, non opposta ma complementare: che cioè ancora la globalizzazione –preceduta, peraltro, dai cultural studies – abbia di fatto imposto all’immaginario (cinematografico) americano di non vedersi più come “il” mondo, bensì come uno tra i tanti mondi possibili. E questo spiegherebbe da un lato il senso di lutto che pervade una quantità di blockbusters (Deep Impact, Independence Day…) dove i più celebri monumenti degli Stati Uniti vengono mostrati travolti e distrutti, dall’altro il recente successo negli Usa di “piccoli” – e peraltro piuttosto mediocri – film stranieri come The Artist o Il discorso del re. Forse, dunque, non è un caso che, proprio adesso, soprattutto tra i cineasti indipendenti, si torni a girare “dalle parti di casa”, con film – Frozen River, Winter’s Bone per non citarne che due – la cui ambientazione insolita (province di confine, terre significativamente inospitali) può sembrare esotica non solo al pubblico globale, ma anche a quello americano.
Come scrive Shone, “c’è tutto un mondo là fuori: ci sarebbe di che farne un film”.
Maria Teresa Carbone