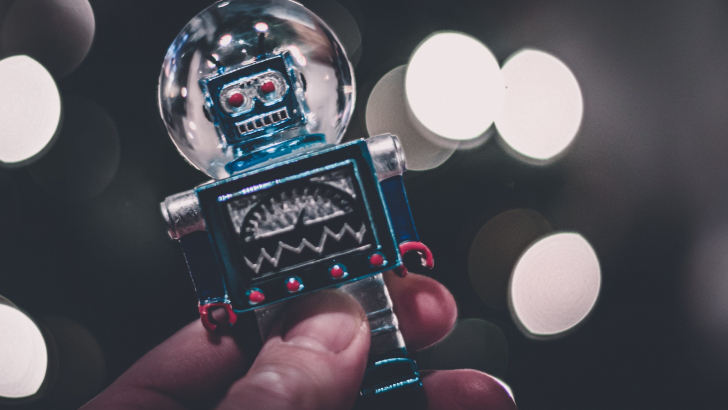Fattelo spiegare da uno “bravo”

Brava! Brava! Sono tanto brava! Brava! Sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, faccio quasi tutto con la voce sembro un usignolo, sì!, cantava Mina, dimostrando di essere una fuoriclasse. È bravo chi è particolarmente capace in un’attività, ma anche chi è buono e onesto. Ed è bravo! proprio quell’artista a cui rivolgiamo il nostro convinto applauso, sostenendolo a gran voce dopo una esibizione perfetta. Una formula esclamativa di approvazione che, a partire dalla seconda metà del Settecento, anche grazie a Carlo Goldoni, fece il giro dei teatri di tutta Europa fino a raggiungere i libretti delle opere in lingua italiana, tra cui spicca Largo al factotum, la cavatina cantata dal baritono ne Il barbiere di Siviglia di Rossini (“Oh, bravo Figaro! Bravo, bravissimo! Bravo!”), diventando una esclamazione di plauso in diversi contesti e lingue, invariabile nel genere e nel numero: dall’albanese all’arabo egiziano, dal coreano all’indonesiano, dal francese al polacco, passando per l’inglese (australiano, britannico, statunitense), il tigrino, il turco, l’islandese, solo per citarne alcune.
Se oggi mi definisci bravo dovrei, dunque, offendermi? No, perché “nella lingua attuale bravo è, in primo luogo, chi è abile”. Bravo in, bravo a fare qualcosa. Da bravo. Brava persona. Fare il bravo. Bravo! sono tutti significati positivi; ma allora come mai non vale lo stesso per la parola bravata? Come la mettiamo con notte brava? E i bravi di Manzoni come li possiamo definire? Certamente non delle persone buone e oneste. Nel suo recente libro Bravo! (Il Mulino), Giuseppe Patota, professore di linguistica italiana all’università di Siena-Arezzo, propone un viaggio alla scoperta delle radici e “della diffusione internazionale di una piccola parola dalla grande storia”. Ed ecco svelato il mistero: all’origine di bravata c’è il bravo negativo dell’italiano di ieri. Ma come mai bravo originariamente ha avuto significati negativi? Quando, come e perché si è passati a quelli positivi? “Il termine ha il suo antecedente nel latino barbarus, straniero, (che a sua volta riflette il greco βάρβαρος: straniero, incivile) e naturalmente ha dato origine anche a barbaro – spiega l’autore - Bravo e barbaro, dunque, sono parole sorelle sicché non meraviglia che la prima, nella sua storia remota, abbia condiviso con la seconda la valenza negativa dell’antecedente greco e latino”. E continua, rivelando la storia fonetica delle due parole: “Bravo è una parola popolare presente nel latino parlato che ha subìto trasformazioni tipiche di una parola passata di bocca in bocca, di luogo in luogo, di generazione in generazione. Barbaro è invece una voce cosiddetta dotta, assente dal latino parlato, rimasta depositata per secoli nei soli testi latini scritti e assunta direttamente nei testi italiani antichi ad opera di scriventi che l’avevano trovata nei testi latini. La storia fonetica di barbaro è trasparente: passando dal latino scritto all’italiano, la parola ha mantenuto la forma originaria, adattando semplicemente la sua parte finale alla morfologia dell’italiano. Come si è arrivati, invece, da barbarus a bravo?”. Per rispondere a questa domanda, Patota propone l’ipotesi ricostruttiva di Jules Cornu, accolta da quasi tutti i filologi romanzi. Semplificando: da barbarum si è passati a barbru, da barbru a babru, da babru a brabu. Poi, il passaggio dalla b alla v. Infine, la –u è diventata o.
Il viaggio di questa piccola (ma assai diffusa) parola inizia, dunque, molto tempo fa. Dal primo Trecento al primo Quattrocento, l’aggettivo bravo ha un significato in cui si confondono crudeltà e ferocia, coraggio spinto fino alla spavalderia e indole selvaggia. Nella seconda metà del Quattrocento raggiunge, poi, i campi di battaglia: la valenza resta negativa ma, nell’Italia tra la fine del Quattrocento e la metà del Cinquecento, “quando lo scontro non è invenzione di poeti ma memoria e narrazione di fatti reali, essere bravi è una virtù necessaria nel senso machiavelliano del termine […] Nel Cinquecento quello dei bravi era un mestiere, un brutto mestiere nato quando le compagnie di ventura italiane si dissolsero, travolte dalla superiorità degli eserciti europei. I congedati e gli sbandati, incapaci di adattarsi a una professione civile presero altre strade, alcuni divennero sgherri al servizio di privati potenti altri presero a vivere di espedienti e truffe”. C’erano i bravi veri, quelli pericolosi che menavano le mani e commettevano soprusi - categoria ben rappresentata nel dipinto del 1522 di Tiziano Vecellio, Il bravo - e c’eran quelli ‘a credenza’, chiamati così da Pietro Aretino nella commedia La Talanta del 1542, spaventosi solo nell’aspetto, delinquenti da quattro soldi.
Quando si arriva, infine, al bravo moderno e positivo? “La vera prima attestazione è quella tratta dal Saggiatore del toscano Galileo Galilei, pubblicato nel 1623”, scrive Patota, ma in realtà “è possibile risalire parecchio più indietro nel tempo […] Nel sonetto che fa da proemio alla Priapea, un’oscena raccolta di versi pubblicata nel 1541 e intitolata a Priapo, dio pagano famoso per le spropositate misure del pene, il beneventano Niccolò Franco invoca le Muse così come i bravi poeti soglion fare”. Nel corso del Seicento, come aggettivo, viene sempre più utilizzato in senso positivo e tra Seicento e Settecento inizia ad assumere il significato di buono e onesto. E questo anche grazie a Carlo Goldoni che costella di bravo e brava le sue opere. Così ne Il cavaliere giocondo: “Avrete accanto sì bravo figliuolino”. Nella commedia I malcontenti: “Ella ha un bravo nipote”. Ne L’uomo di mondo: “Bon! Gh’avè una brava sorella”. Infine, ne La donna di garbo, Goldoni fa descrivere al Dottore le virtù di Rosaura: “Florindo mio figlio, che poco può tardar a venire, si stupirà nel sentire una donna virtuosa a tal segno, e chi sa, se con tutto il suo studio di tanti anni a Pavia, sia egli arrivato a sapere la metà di quello che sa questa brava ragazza. Per lo più gli scolari non imparano che a fare l’amore”. Se l’amore si impara in fretta, per essere giudicati bravi – e non barbari - ci vuole tempo.
Francesca Boccaletto