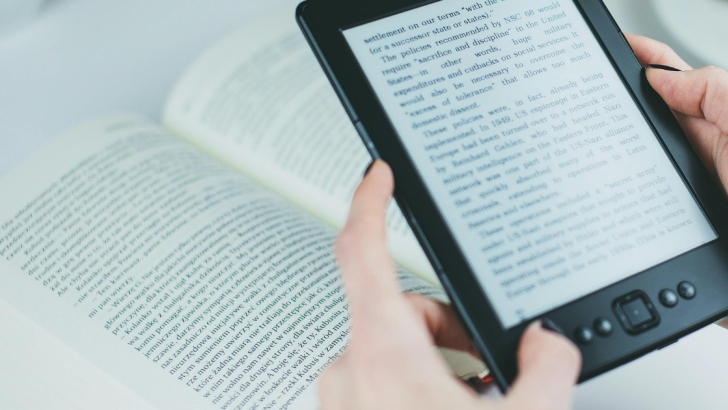SCIENZA E RICERCA
Apple vs Samsung. Se il brevetto diventa un'arma impropria
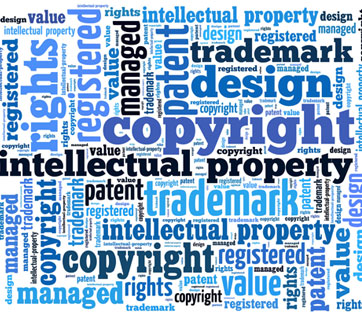
La battaglia legale tra Apple e Samsung sta suscitando grande clamore a livello internazionale con sentenze che si rimpallano da una parte all’altra del mondo. Pochi giorni dopo il verdetto del tribunale Californiano di San Josè, che ha condannato Samsung ad un risarcimento di circa 1 miliardo di dollari per aver copiato alcune caratteristiche dell’iPhone e dell’iPad, è arrivata la sentenza diametralmente opposta del tribunale di Tokyo, che ha sostenuto che l’azienda coreana non ha violato i brevetti della Apple.
Difficile capire ragioni e torti di ciascuno degli attori coinvolti e soprattutto ipotizzare quale sarà l’esito finale di questo scontro che ha come obiettivo finale il controllo mondiale del ricco mercato degli smarthpone e dei tablet. È forse più interessante riflettere sulle questioni che questo caso solleva in merito all’istituto del brevetto industriale e più in generale ai processi di innovazione.
Il brevetto industriale nasce proprio per garantire all’inventore la possibilità di un utilizzo esclusivo (per un consistente numero di anni) della propria idea. Questo strumento ha avuto in passato un ruolo molto importante per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo e favorire il progresso tecnologico, offrendo alle aziende la garanzia di un adeguato ritorno economico. Tuttavia, oggi, sono in molti a sollevare dubbi sulla reale utilità del brevetto come meccanismo di incentivo all’innovazione e anzi a sottolinearne le possibili implicazioni negative.
L’impressione, infatti, che si ricava dalla causa Apple contro Samsung e da altri casi simili è che il brevetto stia diventando un’arma impropria, uno strumento più utile come deterrente per bloccare possibili competitor sul nascere e come autodifesa tra grandi colossi industriali. Jonathan Schwartz, ex amministratore delegato di Sun Microsystems (oggi di proprietà di Oracle), ha dettagliatamente raccontato gli incontri, non proprio piacevoli, avuti sia con Steve Jobs che con Bill Gates che accusavano Sun di aver copiato i loro brevetti. In entrambi i casi, le riunioni si chiusero con un nulla di fatto solo perché Schwartz potè dimostrare agevolmente quanto Apple e Microsoft infrangessero altrettanti brevetti di Sun e di altri.
In sostanza tra le corporation americane soprattutto nel settore high-tech, questi scontri iniziano ad essere una prassi (si ricordi ad esempio l'altra lotta tra giganti, che ha opposto Apple ai costruttori del telefonino Google) e molte volte si chiudono in pareggio proprio perché chi accusa di copiare non ha magari un curriculum proprio immacolato e nel passato ha lui stesso “tratto ispirazione” da idee di altri.
Vivek Wadhwa, ex-imprenditore della Silicon Valley e oggi editorialista del Washington Post, sostiene che la questione è ancora più critica quando ci sono in gioco le piccole start-up innovative che non hanno le risorse finanziarie per poter sostenere un confronto legale con i giganti dell’industria informatica. In questi casi semplicemente la bilancia pende tutta a favore delle corporation che possono bloccare sul nascere una piccola impresa semplicemente con un’accusa, che si può dimostrare, poi, anche infondata.
In realtà se andiamo ad analizzare con attenzione l’origine e l’evoluzione delle innovazioni che hanno fatto la storia nel settore dell’informatica possiamo trovare molti situazioni nelle quali meccanismi di “copiatura migliorativa” hanno avuto un ruolo cruciale. Malcom Gladwell, in un articolo che ricostruisce magistralmente la storia dell’invenzione del personal computer, ha ben chiarito che cosa è accaduto per il mouse. L’idea originaria è di Douglas Engelbart che negli anni '60 ebbe l’intuizione di muovere il cursore dello schermo con un dispositivo esterno: una grossa scatola con al centro una pallina metallica che assomigliava ad una rotella di un pattino. Questa idea è poi stata ripresa dai ricercatori di Xerox negli anni 70 che l’hanno utilizzata per il progetto di computer con interfaccia grafica (il papà dell’attuale personal computer) e che, rispetto al progetto di Engelbart, vi hanno aggiunto dei tasti per poter compiere delle “azioni”. Tuttavia questa versione era molto costosa (300 dollari) e delicata (si rompeva in circa due settimane). Quando Steve Jobs visitò i laboratori di Xerox e vidi tutto il lavoro svolto, ne rimase affascinato. Tornato a casa incaricò Dean Hovey (che poi avrebbe fondato IDEO, una design firm di livello internazionale) di ridisegnare completamente il mouse trasformandolo in un oggetto molto più semplice da utilizzare (un solo pulsante), resistente e producibile industrialmente al costo di 15 dollari. Da qui in poi la storia è nota. Naturalmente nessuno dei soggetti coinvolti ha servilmente copiato il lavoro precedente: ognuno ha dato un contributo che è stato fondamentale per l’evoluzione del concetto di mouse e per la sua trasformazione in un prodotto utilizzabile dal consumatore finale.
Queste cose non accadono solo per i prodotti High-Tech. Anche guardando in casa nostra, molte delle innovazioni realizzate all’interno dei distretti industriali si basano su questa capacità di trasformare e migliorare idee e soluzioni proposte da altri. Basti ricordare ad esempio l’introduzione della plastica ad iniezione nel mondo dello scarpone da sci, che deve l’idea iniziale all’americano Bob Lange ma la sua effettiva applicazione alla produzione di scarponi da sci deve tutto agli imprenditori del distretto dello sport system di Montebelluna, che furono in grado di migliorare di molto la prima soluzione messa a punto da Lange.
Oggi, questi processi di “copiatura migliorativa” sono l’enzima fondamentale che favorisce la trasformazione di una invenzione (idea) in una innovazione (un prodotto utilizzabile del consumatore). La necessità di proteggere la proprietà intellettuale in modo rigoroso, alla base dell’idea del brevetto, rischia di diventare oggi un vero e proprio ostacolo all’innovazione e quindi alla crescita economica. Da questo punto di vista, appare sempre più urgente una revisione dell’istituto del brevetto in grado di tenere conto di questa complessa natura dell’innovazione.
Marco Bettiol