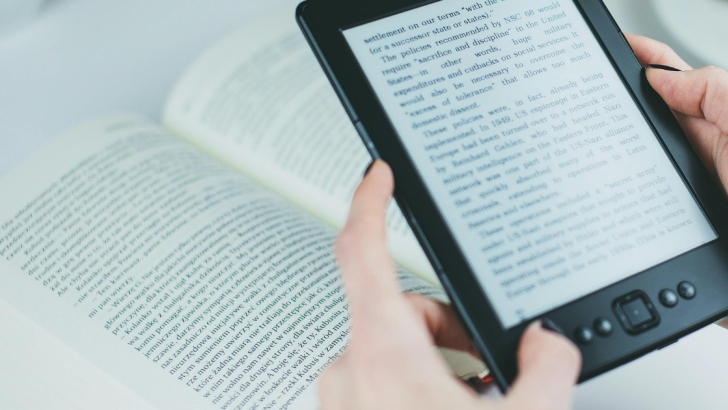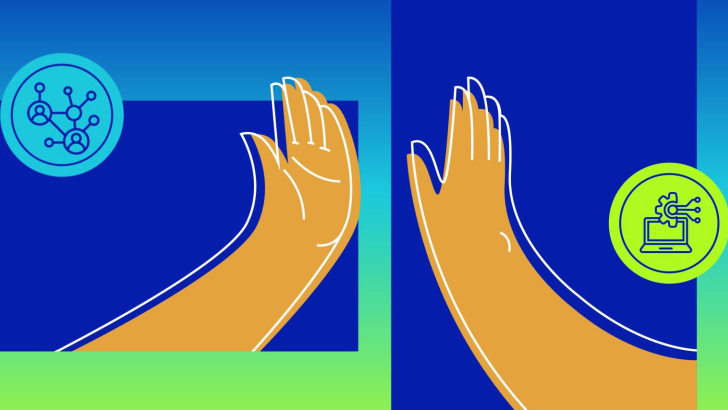SCIENZA E RICERCA
Volete l'innovazione? Serve la mano pubblica

La Apple non ha fatto in tempo a lanciare i suoi nuovi tablet, che già i rumors dalla rete annunciano l’uscita prossima ventura di una nuova meraviglia ultrasottile, l’iPad Pro, con uno schermo da 12,2 pollici e uno spessore di appena 7 millimetri. E i fan della casa della mela tirano un sospiro di sollievo: con la morte di Steve Jobs la Apple non ha perso i suoi geni creativi. L’industria privata resta l’interprete più efficiente dell’economia della conoscenza.
Ma è proprio così? La capacità di innovazione si concentra tutta e sola nei laboratori di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico di imprese private che sanno come scatenare gli animal spirits della creatività? Se la pensate così, chiedetevi perché, qualche tempo fa, la Pfizer, una grande azienda del farmaco, ha lasciato a sorpresa la tradizionale sede di Sandwich, nel Kent, Inghilterra, per trasferirsi a Boston, nel Massachusetts, Stati Uniti.
Questa domanda se l’è posta Mariana Mazzucato in un libro, The Entrepreneurial State, pubblicato di recente anche in italiano da Laterza con il titolo Lo stato innovatore. L’economista italiana che insegna politica della scienza e della tecnologia presso la University of Sussex, in Gran Bretagna, ha avuto un grande e forse inatteso successo in tutto il mondo per la risposta in assoluta controtendenza che ha dato a questa e ad altre domande. La Pfizer ha traslocato non perché a Boston paga meno tasse e combatte con meno norme e leggi restrittive, ma perché trova un “ambiente adatto all’innovazione”, alimentato dagli investimenti pubblici in ricerca biomedica da parte di un’agenzia del governo federale, i National Institutes of Health (NIH), che ammontano, ogni anno, a circa 31 miliardi di dollari.
Allo stesso modo, ricorda Mariana Mazzucato, nulla avrebbero potuto il genio di Steve Jobs e i geni dei suoi collaboratori ed eredi alla Apple senza la scoperta della magnetoresistenza gigante realizzata in laboratori pubblici con fondi pubblici dal francese Albert Fert e dal tedesco Peter Grünberg, insigniti per questo del premio Nobel per la Fisica 2007.
Se vogliamo capire cosa ci vuole dire Mariana Mazzucato con le sue risposte alle impertinenti domande che lei stessa si è posta ci conviene fare un passo indietro nel tempo e risalire al luglio 1945, mentre la guerra in Europa è finita e quella nel Pacifico ancora continua. Fu allora che il matematico Vannevar Bush – un conservatore illuminato – consegnò al Presidente degli Stati Uniti un rapporto destinato a diventare famoso: Science, the Endless Frontier. Scienza, la frontiera senza limiti. Con quel documento, pensato per il democratico Franklin D. Roosevelt (morto ad aprile) e consegnato al suo successore, Harry Truman, Vannevar Bush inaugurò la moderna politica della ricerca. E, forse, la moderna politica economica, che il consigliere di Roosevelt immaginava fondata su un’innovazione tecnologica costante che attinge in maniera sistematica alla produzione di nuova conoscenza scientifica. Il conservatore Vannevar Bush non pone solo la scienza al centro della dinamica economica, ma vi pone anche lo Stato: l'unico, autentico innovatore.
Science, the Endless Frontier è la risposta al problema che Franklin Delano Roosevelt, il “presidente keynesiano”, aveva posto alcuni mesi prima al suo consigliere scientifico: Vannevar Bush, appunto. Il problema era semplice e chiaro: come assicurare agli Stati Uniti la leadership culturale, sociale ed economica oltre che militare nel nuovo ordine mondiale che si sta prefigurando?
La risposta di Bush è altrettanto semplice e chiara. Gli Stati Uniti devono cambiare la loro antica specializzazione produttiva e puntare su beni e servizi molto innovativi. Il consigliere scientifico così come lo stesso Presidente Roosevelt sanno che da solo il mercato non è in grado di modificare la specializzazione produttiva di un intero paese. Occorre che intervenga lo Stato. E non solo con una politica di indirizzo. Occorre che lo Stato si faccia imprenditore. E innovatore. E poiché la scienza – in particolare la scienza di base, quella prodotta per rispondere solo alla curiosità dei ricercatori – è di gran lunga la fonte più munifica di innovazione continua, occorre che lo Stato, se vuole essere innovatore, finanzi in maniera massiccia e continua la scienza, in particolare la scienza di base.
A ben vedere il conservatore illuminato Vannevar Bush è andato ben oltre John Maynard Keynes, l’economista inglese che aveva influenzato Roosevelt e il suo New Deal teorizzando la necessità di investimenti pubblici in funzione anticiclica, ovvero quando l’economia di mercato va male. Bush sostiene che il finanziamento pubblico della ricerca scientifica deve assumere una dimensione macroeconomica (almeno un punto di Pil) ed essere continuo. In altri termini, lo Stato deve investire in ricerca scientifica sia quando le vacche sono magre, sia quando sono grasse. Deve essere un imprenditore lucido e visionario. L’unico imprenditore capace di modificare il presente e di progettare il futuro non solo e non tanto perché ha i mezzi economici, ma anche e soprattutto perché ha un obiettivo generale e la capacità di elaborare un piano per realizzarlo. Una visione, appunto.
La ricetta di Vannevar Bush – gli investimenti pubblici per la ricerca come motore dell’economia della conoscenza – è da settant’anni alla base della politica economica degli Stati Uniti, autentico Stato imprenditore. Con quali risultati?
Il libro di Mariana Mazzucato è la risposta, fatti empirici alla mano, a questa domanda. Lo Stato imprenditore che investe nella ricerca scientifica ha avuto grande successo e da settant’anni consente agli Usa di detenere la leadership economica del pianeta: si calcola, infatti, che almeno il 75% della nuova ricchezza prodotta dal 1945 a oggi negli Stati Uniti derivi da beni e servizi che hanno incorporato la nuova conoscenza scientifica creata nei laboratori finanziati con fondi pubblici.
Ed eccoci a Steve Jobs, la bandiera della nuova industria hi-tech. Cos’ha fatto il fondatore di Apple – si è chiesta Mariana Mazzucato senza tema di infrangere un’icona dei tempi (e del pensiero) presenti – se non appropriarsi della conoscenza informatica prodotta da ricercatori pubblici e finanziata dallo Stato? Allo stesso modo: cosa fa Big Pharma, la costellazione delle grandi aziende multinazionali del farmaco, se non appropriarsi delle conoscenze prodotte con i fondi dello Stato distribuiti tanto saggiamente (con procedure rigorose) quanto generosamente (oltre 30 miliardi di dollari l’anno) dai National Institutes of Health, un’agenzia pubblica di finanziamento alla ricerca biomedica?
Mariana Mazzucato non è né la prima a porsi queste domande (retoriche) e a fornire queste risposte, ben documentate. Pochi anni fa, per esempio, un’altra studiosa, Marcia Angell, al termine di dieci anni di direzione della rivista scientifica The New England Journal of Medicine, tra le più autorevoli al mondo, ha calcolato che negli ultimi decenni almeno tre su quattro dei nuovi principi attivi utilizzati in farmacologia sono stati ottenuti in laboratori pubblici.
I successi del passato sono alla base della politica per il futuro. Lo Stato federale americano finanzia da una dozzina di anni con generosità la National Nanotechnology Initiative e da qualche mese il Brain Project, due progetti di ricerca tra i maggiori che promettono grandi ricadute in termini di conoscenza di base così come delle innovazioni tecnologiche che costituiranno i le fondamenta dell’economia del futuro.
Gli Stati Uniti sono un grande Stato innovatore. E l’economia Usa è – che i liberisti lo vogliano o no – centrata sullo Stato: sull’innovazione prodotta con fondi pubblici e sulle commesse pubbliche che evocano alta tecnologia.
Ma non sono solo gli Stati Uniti a comportarsi da grande Stato innovatore e a fondare la propria economia sulla conoscenza generata da laboratori finanziati con fondi pubblici. Usano il medesimo modello, con qualche correzione, sia i paesi europei più innovativi, Germania in testa, sia i paesi a economia emergente più brillanti – dalla Corea del Sud alla stessa Cina. La Cina è oggi il massimo esportatore al mondo di beni hi-tech e la Corea del Sud è leader, tra l’altro, della cosiddetta “green economy”, l’economia fondata sulle tecnologie innovative a basso impatto ambientale.
A supportare le tesi secondo cui non c’è innovazione senza Stato ci sono anche esempi controfattuali. Primi fra tutti, sostiene Mariana Mazzucato, il Portogallo e l’Italia, che devono le loro difficoltà economiche al settore pubblico che ristagna e alla mancanza di quegli investimenti strategici che solo lo Stato sa e può realizzare.
Non vale l’obiezione che in Italia la spesa pubblica è già alta. Quello che conta è la qualità della spesa. L’economia italiana è da lungo tempo debole non perché la spesa pubblica è alta e il debito dello Stato altissimo, ma perché – da almeno 15 anni, sostiene Mazzucato, ma in realtà è facile dimostrare che gli anni di mano tirata sono almeno 60 e forse più – l’Italia investe troppo poco in formazione, capitale umano e ricerca scientifica. È vero che la carenza riguarda soprattutto gli investimenti privati (per intensità sono fino all’80% in meno, rispetto agli Stati Uniti o al Giappone). Ma anche l’intensità dell’investimento pubblico è inferiore del 30% a quella dei grandi paesi europei. La verità è, sostiene Mazzucato, che l’Italia annaspa perché non ha realizzato quegli investimenti strategici nel settore della conoscenza che ha effettuato invece la Germania.
"Per molti lo 'Stato imprenditore' (o lo Stato innovatore, come è Stato tradotto in italiano) è una contraddizione in termini», commenta Dani Rodrik, economista della Harvard University, sulla quarta di copertina della versione inglese del libro. Ma "per Mazzucato è sia una realtà sia una necessità per la futura prosperità". Un messaggio da meditare.
Pietro Greco