L'e-book non è un libro, è una licenza
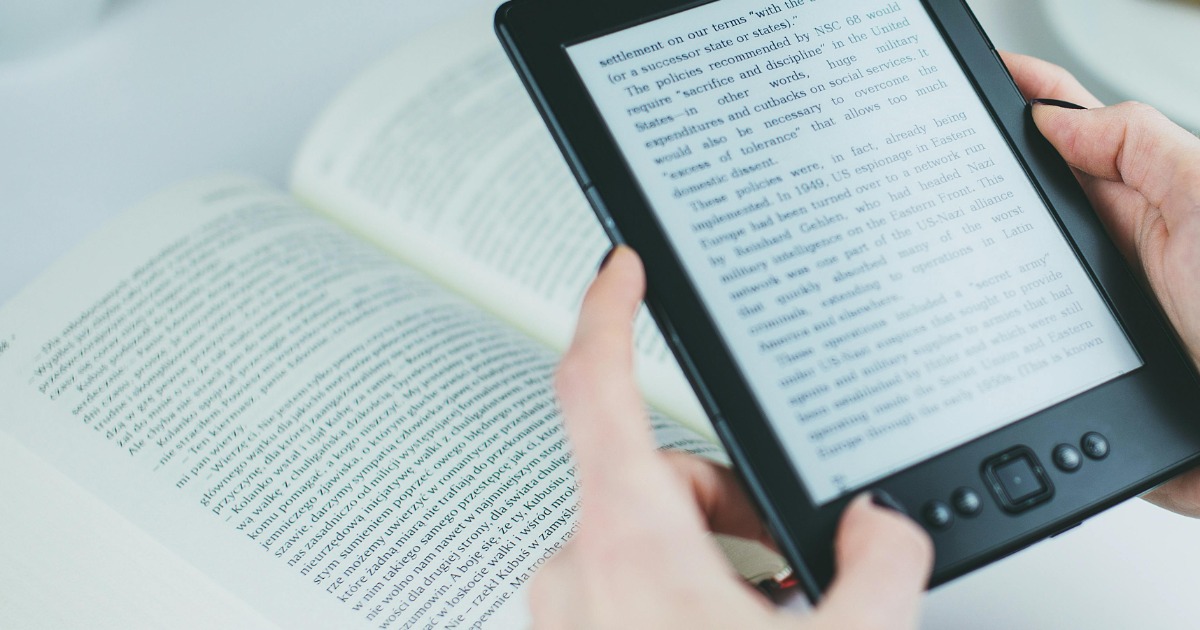
Nel panorama europeo dell’accesso alla conoscenza, il programma Knowledge Rights 21 (KR21) si distingue per l’impegno a favore di una riforma delle normative sul diritto d’autore, con l’obiettivo di garantire che biblioteche, archivi e istituzioni educative possano continuare a svolgere il loro ruolo anche nell’era digitale. Sostenuto dall’olandese Stichting IFLA Foundation, KR21 interviene su tematiche cruciali come copyright, scienza aperta, patrimonio culturale e intelligenza artificiale, promuovendo un accesso equo e sostenibile alla conoscenza.
Il prestito digitale degli e-book
Il tema del prestito digitale di e-book da parte delle biblioteche si inserisce in una cornice europea ancora segnata da incertezze normative, vincoli contrattuali e barriere tecnologiche. Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-174/15 – VOB vs Stichting Leenrecht, 2016) ha aperto alla possibilità di assimilare il prestito digitale di un e-book a quello fisico, a condizione che vi sia un numero limitato di copie in circolazione e adeguati sistemi di gestione dei diritti digitali – digital rights management o DRM. Tuttavia la concretizzazione di questo principio nelle legislazioni e nei modelli contrattuali dei singoli Stati risulta ancora disomogenea e spesso sfavorevole a un modello equo di diritto alla conoscenza. In questo contesto KR21 non si limita a fotografare lo stato dell’arte, ma contribuisce a delineare un futuro in cui l’accesso alla conoscenza sia garantito come diritto fondamentale, senza barriere normative o commerciali.
Per gli e-book infatti non opera il principio dell'esaurimento del diritto, pietra angolare sia nel diritto d’autore europeo che nel copyright statunitense, dove è conosciuto come first-sale doctrine, codificato nella Sezione 109 del Copyright Act degli Stati Uniti (17 U.S.C. § 109). Negli Stati Uniti, la Camera dei rappresentanti del Connecticut ha approvato recentemente il Bill 1234, una proposta di legge che mira a limitare le clausole contrattuali onerose imposte dagli editori per la concessione in licenza di e-book e audiolibri alle biblioteche pubbliche. La norma intende contrastare costi elevati e restrizioni temporali o quantitative che obbligano le biblioteche a riacquistare continuamente gli stessi titoli, in un sistema simile a un abbonamento oneroso e limitato. La legge entrerà però in vigore solo se altri Stati, per un totale di almeno 7 milioni di abitanti, adotteranno misure simili. Il raggiungimento di questa soglia sarà verificato trimestralmente dal bibliotecario statale.
Nel mondo cartaceo il principio dell’esaurimento del diritto (sancito in Italia dall’art. 17 della legge 633/1941) consente il prestito o la rivendita di un libro senza ulteriori costi o permessi. Tuttavia nel caso degli e-book questo principio non trova applicazione, non trattandosi di “opere incorporate in un supporto tangibile”: è quanto conclude la Corte di Giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2019, causa C-263/18. Le biblioteche non acquisiscono la piena proprietà della copia digitale, ma solo licenze d’uso soggette a termini e condizioni stabiliti dagli editori o dai fornitori, che ne definiscono accesso e durata: anche nei casi in cui si parla di "accesso perpetuo" per un e-book accademico si intende un diritto di accesso continuativo, non la proprietà del file. Il contenuto rimane di norma ospitato sulla piattaforma dell’editore o di un intermediario, e l’accesso è disciplinato da clausole specifiche.
Questa dipendenza strutturale dalle licenze genera significative asimmetrie nell’accesso alla conoscenza digitale. Le biblioteche perdono il controllo sul ciclo di vita delle risorse, a differenza di quanto avviene con il cartaceo, e sono costrette a rinegoziare continuamente costi, condizioni e disponibilità. Ciò penalizza in particolare gli atenei con risorse economiche limitate e le biblioteche pubbliche, che non possono permettersi un’offerta ampia e aggiornata di titoli digitali.
Il risultato è una distribuzione della conoscenza digitale più diseguale rispetto a quella garantita dai libri cartacei, dove l’acquisto di una copia assicurava un accesso duraturo e incondizionato. L’indagine KR21 ha mostrato che il prestito di e-book non è regolato da una norma esplicita nel diritto d’autore europeo, lasciando ampio spazio alla contrattualizzazione privata, spesso a scapito del principio di equità di accesso.
L'analisi di Stephen Wyber
Nel maggio scorso, Stephen Wyber dell’IFLA ha pubblicato sul blog Copyright against culture uno studio condotto in ambito KR21, che ha analizzato 36 leggi bibliotecarie in 20 paesi europei. La ricerca mette in luce un marcato disallineamento tra le missioni istituzionali assegnate alle biblioteche dalle normative nazionali e le limitazioni imposte dal mercato degli e-book. Molti ordinamenti attribuiscono alle biblioteche un ruolo essenziale nella garanzia dei diritti costituzionali all’informazione, all’inclusione e alla promozione culturale, ma questi obiettivi rischiano di essere vanificati nel contesto digitale.
L’Italia, pur riconoscendo a livello normativo e regionale il ruolo sociale delle biblioteche e la necessità di collezioni pluralistiche, si trova oggi in una situazione critica: l’accesso agli e-book è ostacolato da vincoli contrattuali, prezzi insostenibili e, in alcuni casi, indisponibilità dei titoli. Le indagini comparative promosse da KR21, come quella sul prestito bibliotecario digitale sicuro in Italia, Polonia e Spagna, offrono spunti preziosi per una riflessione su possibili evoluzioni legislative orientate alla tutela dell’interesse pubblico nell’ecosistema digitale.
Wyber ha evidenziato tre funzioni chiave assegnate alle biblioteche dalle leggi europee: la costruzione di collezioni pluriformi, che includano esplicitamente le risorse digitali (come previsto in Croazia, Francia, Slovenia e Moldavia); il prestito di libri fisici e digitali come servizio essenziale, accessibile a tutti, inclusi i gruppi svantaggiati (Estonia, Inghilterra, Finlandia, Spagna); il prestito interbibliotecario, promosso per ampliare l’accesso in Paesi come Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca. Inoltre, le biblioteche pubbliche sono riconosciute come custodi della memoria culturale locale. Finalità tuttavia attualmente compromesse dalle attuali limitazioni contrattuali sugli e-book.
Per questo sta destando interessa le citata proposta legislativa del Connecticut, la quale va oltre la questione dei costi vietando le clausole di riservatezza che impediscono il confronto tra biblioteche sui termini contrattuali, imponendo che le licenze consentano il prestito interbibliotecario e stabilendo che esse non possano essere a tempo determinato, salvo che prevedano modelli a consumo o garantiscano un uso pubblico perpetuo.
La proposta ha ricevuto ampio sostegno da bibliotecari, utenti e organizzazioni civiche. Ellen Paul, direttrice del Connecticut Library Consortium, ha denunciato che le biblioteche sono spesso costrette a pagare da quattro a cinque volte il prezzo di copertina per un e-book, con lunghi tempi di attesa che vanificano l’accesso per molti lettori. Il deputato democratico Matt Blumenthal ha definito l’attuale modello un peso finanziario per i contribuenti e un ostacolo alla missione pubblica delle biblioteche. Tuttavia, l’Authors Guild, che rappresenta gli scrittori statunitensi, ha espresso preoccupazione: secondo il direttore Umair Kazi la legge potrebbe portare gli editori a ritirarsi dal mercato bibliotecario, danneggiando proprio le istituzioni che si vogliono tutelare.
In Italia manca al momento un confronto sistematico tra editori, biblioteche e decisori pubblici per ridefinire un equilibrio sostenibile. Nonostante alcuni tavoli tecnici promossi dalla Direzione generale biblioteche del Ministero della Cultura, non si è giunti a una riforma strutturale. La questione del prestito digitale non è stata inoltre inclusa nei recenti programmi di finanziamento alla cultura digitale. A ciò si aggiungono resistenze culturali verso l’e-book, sia tra i lettori che tra gli operatori, e la fragilità del mercato editoriale italiano, che contribuiscono a mantenere la questione in secondo piano.
Il fatto che gli e-book non siano realmente acquistati ma “affittati” tramite piattaforme esterne ostacola la creazione di collezioni stabili e accessibili, frustrando le finalità educative, inclusive e democratiche delle biblioteche. Senza un accesso libero e garantito agli e-book, le biblioteche rischiano di non poter più assolvere pienamente al proprio ruolo nella società. È dunque urgente un intervento normativo che riconosca e tuteli esplicitamente il diritto delle biblioteche all’accesso e al prestito digitale, nel rispetto dei principi fondamentali di libertà culturale e informativa sanciti dalla legislazione europea.









