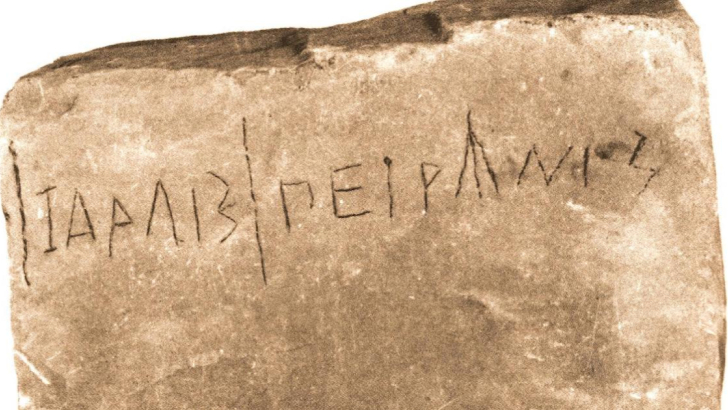Quando al museo rifilano un COBRA

L'ingresso del Moma, il Museum of Modern Art di New York. Foto: Jason Kempin/Redux/contrasto
Quando Umberto Eco elargì ai lettori 40 consigli per esprimersi bene in italiano, ognuno dei suggerimenti conteneva in sé l’errore da schivare: “Evita le frasi fatte: è minestra riscaldata”; “C’è davvero bisogno di domande retoriche?”; “Non usare mai il plurale majestatis. Siamo convinti che faccia una pessima impressione”. Il consiglio numero 5 andrebbe incorniciato come il meno seguito nella storia della lingua italiana: “Non usare sigle commerciali & abbreviazioni etc.”. E invece, non solo in Italia ma in tutto il mondo, da decenni il marketing museale ha imposto un’usanza cui nessun direttore artistico ha oggi l’ardire di sottrarsi: la dittatura dell’acronimo.
La radice di ogni male ha un nome, anzi una sigla: MOMA. Si deve al moderno dilagare della popolarità dell’acronimo del Museum of Modern Arts di New York, sorto a Manhattan nel 1929, il progressivo contagio globale di manager e operatori culturali, politici, galleristi, critici, concordi nello stringersi intorno a un dogma che nessuno più mette in discussione: per un’immagine “vincente”, un museo che si rispetti deve possedere un acronimo che colpisca, generi immagini, rimanga impresso. Ed ecco quindi che i polverosi “museo storico dei Granatieri di Sardegna” o “museo numismatico della Zecca italiana” vengono sepolti, e al loro posto scaturisce un fiotto di sigle: che non hanno più la funzione di sintetizzare una lunga denominazione, ma diventano nome esse stesse, divorando l’espressione di cui erano originariamente al servizio. Non è un fenomeno solo italiano: l’acronimite affligge istituzioni (non solo museali) di tutto il mondo. La differenza con l’Italia sta in una questione di misura, o di motivazioni. Ad Amsterdam, per esempio, chi volesse farsi una scorpacciata di arte moderna centroeuropea deve andare al COBRA: ma la direzione del museo non è un covo di erpetologi. L’acronimo corrisponde alle iniziali delle città d’origine (COpenhagen, BRuxelles, Amsterdam) degli artisti del movimento di avanguardia fondato a Parigi nel 1948, alla base del nucleo fondamentale della collezione del museo. Decisamente più ironica (una qualità non troppo diffusa tra i guru dell’arte) la genesi di OBAMA, il bar-antigalleria d’arte di Seattle (Usa) che si qualifica come Official Bad Arts Museum of Art, e che fa il verso tanto al presidente degli Stati Uniti quanto, soprattutto, alla mania abbreviativa in voga.
Venendo a casa nostra, è impossibile non notare che nella pirotecnia di acronimi museali prevale, più che il senso dell’umorismo, il narcisismo di un pugno di creativi stanchi. È difficile scegliere tra le perle che gli ultimi vent’anni di lambiccamenti modaioli hanno scovato. Per i golosi non si resiste al fascino di GNAM, com’è stata ribattezzata la galleria nazionale d’arte moderna di Roma (a quando un logo con dei bucatini serviti su una tela?). A Torino sono frequenti, tra i coniatori di etichette museali, gli amanti dei felini: si va dal MAO (museo d’arte orientale) al MAU (museo di arte urbana) al MIAAO (“museo internazionale delle arti applicate oggi”: ottimo esempio di come una denominazione demenziale nasca solo in funzione dell’acronimo). Meno delicate le preferenze a Biella, dove impera il MACIST, “museo d’arte contemporanea internazionale senza tendenze” (commento: vedi MIAAO). A Bologna, per non smentire gli stereotipi di città godereccia e danzante, trionfa il MAMBO (museo di arte moderna di Bologna). Più raffinata la scelta di Lucca: il suo museo di memoria urbana storia e territorio è il MUST, che tradotto dall’inglese significa più o meno “imperdibile”. Tornando a Roma, è nota la mania di grandezza del MACRO (museo d’arte contemporanea di Roma) e del MAXXI (che almeno gioca con la grafia di XXI, il “ventuno” in numeri romani che ricorda il ventunesimo secolo cui il museo è dedicato); più poetico il MADRE (museo d’arte contemporanea Donnaregina), a Napoli. E se siete stufi di tutta quest’arte, non si rinuncia all’acronimo nemmeno per celebrare la gastronomia nazionale: il MIP è il museo napoletano del pane e della pizza, mentre il MUSA è il museo della salumeria, ovviamente in provincia di Modena.
Ai veneti amanti dell’arte è impossibile, infine, non segnalare l’involontaria comicità dell’acronimo del museo di Hobart, in Tasmania. L’acronimo (che non sciogliamo) del Museum Of New and old Art corrisponde al più diffuso e tradizionale insulto nella lingua di Goldoni: ed è complicato, per un nativo di Venezia o Belluno, scorrere le pagine web del museo senza sogghignare di fronte ai volti ispirati di maestri contemporanei sopra i quali si stagliano le quattro lettere che bollano, nel lessico lagunare, le persone dotate di sguardo ebete e scarso comprendonio.
La tendenza, dunque, è inarrestabile: i dandy creativi si rincorrono, risucchiati in un gorgo senza fondo. Ma si rassegnino i geni del male, i forgiatori dei MACIST e dei MIAAO: in materia di acronimi il sublime è già stato toccato, e non teme imitazioni. Nel 1985 i responsabili di un servizio di ambulanze californiano furono costretti a cambiare la propria sigla, perché gli autisti incontravano difficoltà nei rapporti con la popolazione. Sulle fiancate dei mezzi di soccorso campeggiavano le iniziali di quattro parole, il motto coniato trent’anni prima dalla fondatrice Joan Woehrmann: “Attitude, Integrity, Dependability, Service”. Un capolavoro, irripetibile, di autosabotaggio differito.
Martino Periti