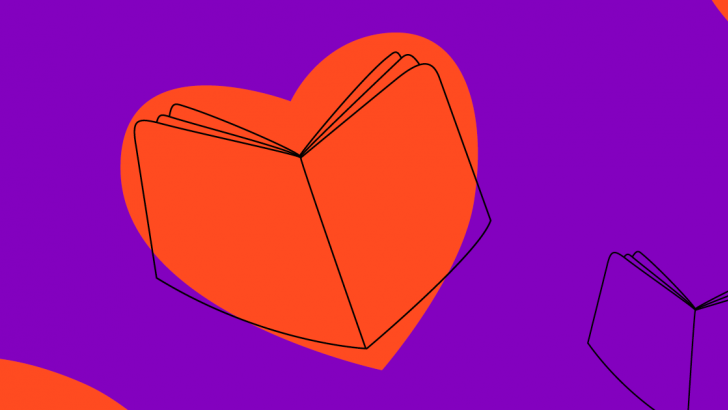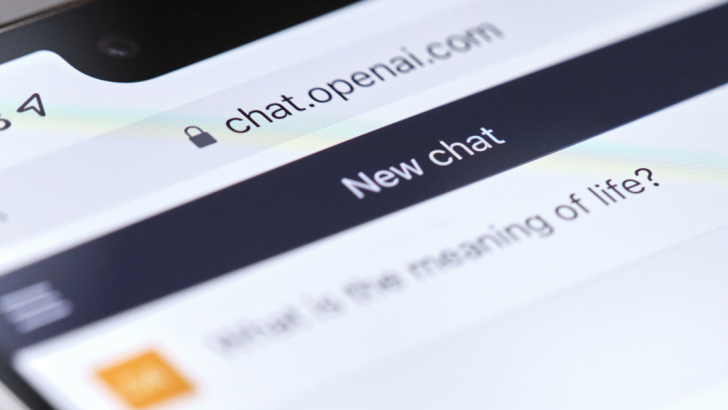SOCIETÀ
Lezioni di latino e di filosofia per l'ingegnere e il fisico

A che serve tradurre una poesia dal latino, oppure sapere la data della Rivoluzione Francese, se oggi il mondo del lavoro richiede soprattutto conoscenze informatiche e un inglese perfetto? Una domanda che ha alimentato le insicurezze di generazioni di liceali, oggi trova spazio anche sulle pagine dei giornali e nelle stesse aule delle università; soprattutto in una realtà che, come quella italiana, è perennemente sotto la piaga dalla disoccupazione giovanile. Secondo il rapporto OCSE Education at a Glance 2017 la cosiddetta Stem education (dalle iniziali di Science, Technology, Engineering e Mathematics) dà ai laureati maggiori prospettive di lavoro, eppure in Italia una buona parte degli studenti continua a preferire le cosiddette ‘lauree deboli’.
In un mondo in cui tutto sembra cambiare a velocità folle, sono in molti a chiedersi se possiamo ancora considerare necessari e fondanti saperi non immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Se però stessimo sbagliando bersaglio? Se dovessimo tutti fermarci e riflettere prima di buttare irrimediabilmente a mare la cultura umanistica? È soprattutto un invito a un’analisi attenta e priva di pregiudizi, quello che emerge dalla lettura de L’impronta digitale. Cultura umanistica e tecnologia (Carocci 2017), il libro appena pubblicato da Lorenzo Tomasin, attualmente docente di filologia romanza all'università di Losanna.
Siamo innanzitutto sicuri che un’educazione umanistica non abbia più nulla da dire nell’era di internet? Per contrastare il fenomeno della fake news è ad esempio più utile conoscere come funziona un server oppure gli strumenti base dell’analisi di un testo? Tanto più che “il deficit critico – scrive nel libro Tomasin – è ipso facto culturale”.
Al di là di tutto il dibattito sull’utilità e sulla stessa sopravvivenza degli studi umanistici è tanto antico da risultare quasi sospetto, come ad esempio ricorda la docente di letteratura classica a Cambridge Mary Beard (Fare i conti con i classici, appena tradotto da Mondadori). Se già nel 1782 Thomas Jefferson giustificava il ruolo preminente dato all’insegnamento del greco e del latino, d’altra parte Max Weber (ne L'etica protestante e lo spirito del capitalismo) all’inizio del Novecento individuava nell’insegnamento tecnico l’elemento decisivo per la nascita della società moderna industriale, verso la quale l’educazione classica avrebbe al contrario esercitato un’azione frenante. Certo oggi di nuovo c’è che, con l’incredibile sviluppo delle tecnologie dell’informazione, più di qualcuno si spinge a prefigurare o ad auspicare un completo cambiamento di paradigma, paventando ad esempio l’estinzione del libro stampato – questo relitto culturale anti-ecologico e ingombrante – e la sostituzione delle classiche biblioteche a scaffali con attrezzati Data Center virtuali.
Nell’epoca attuale anzi una visione esclusivamente utilitaristica e tecnocratica sembra contagiare dall’interno persino la stessa ricerca umanistica, che “in troppi casi – denuncia Tomasin – stenta a credere all’autonoma dignità e alla vitale importanza dei suoi contenuti [e] si attacca al carro della tecnologia, tentando così di affermare la propria attualità e spendibilità”. Sempre più vengono infatti privilegiati, anche in termini di finanziamenti, insegnamenti e ricerche che si presentino come integrati con le nuove tecnologie. Con il rischio però di confondere uno strumento prezioso con l’oggetto stesso dello studio, alla perenne ricerca di improbabili scorciatoie.
Un esempio viene dalla cosiddetta Venice Time Machine: il progetto di un’équipe di ricercatori del Politecnico di Losanna che si propone non solo di digitalizzare una mole sterminata di documenti provenienti dalla città lagunare, ma addirittura di costruire l’embrione di una specie di social network degli archivi mondiali, dove studiosi e semplici curiosi possano navigare e incrociare i dati, magari taggandosi e mettendo ogni tanto qualche commento o like. Idea sicuramente affascinate per molti, ma che secondo il veneziano Tomasin, che ha partecipato alle fasi iniziali del programma per poi lasciarlo, “può balenare oggi solo a chi non abbia mai letto un manoscritto antico”.
La tecnologia digitale insomma, che già oggi è un imprescindibile strumento per indagare anche il campo umanistico (cosa che nessuno mette seriamente in discussione), rischia se malintesa di provocare una mutazione genetica del nostro modo di essere e di apprendere. Perché un modo di percepire il rapporto tra conoscenza e tecnologia, che sia schiacciato esclusivamente su quest’ultimo, non si limita a minacciare la fine dello studio umanistico – caratterizzato, ricorda l’autore del libro, da una lettura “lenta, meditata, esitante e ricorsiva” – ma rischia alla lunga di insidiare anche le cosiddette scienze ‘dure’ o ‘esatte’. Già nel 2008 l’allora direttore di Wired USA Chris Anderson scriveva provocatoriamente (smentito dal filosofo della biologia Massimo Pigliucci) che i Big Data avrebbero addirittura reso inutile il metodo scientifico: presto infatti simulazioni computerizzate sempre più complesse ci avrebbero descritto il mondo semplicemente com’è, senza inutili ipotesi e verifiche sperimentali.
Proprio per evitare queste derive tecnicistiche Tomasin, interpellato dal Bo, lancia una provocazione: perché non comprendere veri corsi umanistici anche nei piani di studio delle facoltà tecnologiche? “Oggi test ed esami di informatica sono ritenuti necessari anche per gli studenti di lettere e di filosofia – conclude lo studioso –; credo dunque che una ‘vaccinazione filosofica’ non potrebbe che essere utile anche a chi si occuperà un domani soprattutto di macchine o computer”.
Daniele Mont D’Arpizio