La verità vi prego sull'amore. I romanzi d'amore piacciono a tutti
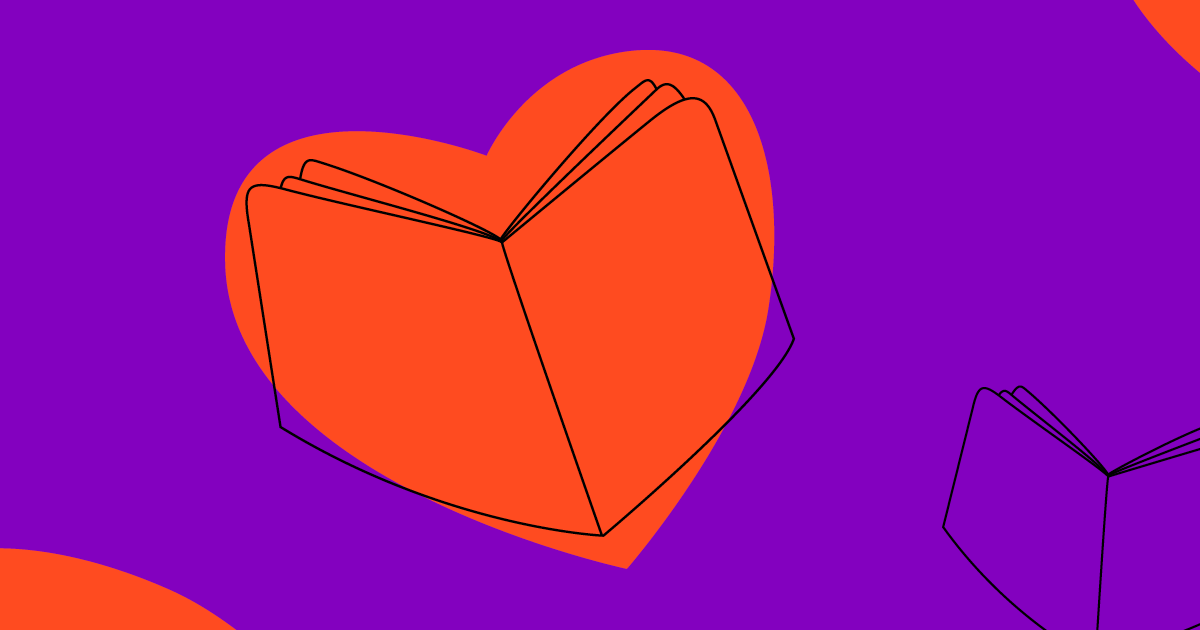
“La verità, vi prego, sull’amore” è una poesia di W.H. Auden del 1930 in cui chi la scrive si pone, con una certa spigliatezza, la domanda delle domande. Che cos’è l’amore? Pile di carta sono state ammonticchiate, e fiumi d’inchiostro versati, per rispondere, fin dalla notte dei tempi.
L’ultima strofa del componimento del poeta inglese recita così:
“Quando viene, verrà senza avvisare,
proprio mentre mi sto frugando il naso?
Busserà la mattina alla mia porta,
o là sul bus mi pesterà un piede?
Accadrà come quando cambia il tempo?
Sarà cortese o spiccio il suo saluto?
Darà una svolta a tutta la mia vita?
La verità, vi prego, sull’amore.”
e certo si sente che non c’è affettazione sdolcinata nelle sue parole, ma vera curiosità e anche una certa dose di ironia.
L’amore non è una faccenda derubricabile con i bigliettini nascosti nei Baci Perugina. Tantomeno artisticamente. Così, quando, circa un anno fa, usciva sulle pagine della rivista online “Doppiozero” un pezzo che analizzava le uscite recenti di narrativa contemporanea italiana dando a intendere che oramai le scrittrici italiane non scrivessero altro che romanzi d’amore, o meglio “contemporary romance” – cioè narrativa di genere non di livello eccelso –, è montata una polemica che, come tutte le polemiche, non ha ragione di esistere però diventa l’occasione per riflettere.
Da “la verità, vi prego, sull’amore” l’invocazione può tradursi in “la verità, vi prego, sui romanzi d’amore” perché c’è la necessità di dissipare un equivoco.
I romanzi d’amore non sono letteratura di genere circoscritta a un pubblico femminile con una spiccata attitudine alle situazioni melense e amanti di quella che una volta si chiamava “soap opera”, per una serie infinita di ragioni. Vale la pena evidenziarne almeno due.
La prima: l’amore costella la vita di tutti e le sue forme d’espressione, anche nella realtà non solo nella finzione letteraria, sono le più disparate, perciò partire dal presupposto che l’amore sia affare “da donne” e ricalchi stilemi prefissati è estremamente riduttivo. Questo vale sia per il pubblico che per gli artisti, nel caso di specie gli scrittori e le scrittrici: “Madame Bovary c’est moi” scriveva Flaubert, a dire che uno dei romanzi d’amore e sul desiderio femminile più noti dell’Ottocento, dai tratti estremamente contemporanei, l’ha scritto un uomo e nessuno si sognerebbe mai di dire che è un “romanzo rosa”. La questione di genere non può essere applicata all’arte (sempre che abbia un senso tout court), e non c’è ragione per riaprire l’annosa quaestio della scrittura femminile in contrapposizione a quella maschile.
In secondo luogo non è il tema a definire la caratura di un romanzo. Romanzi d’amore sono I promessi sposi, Romeo e Giulietta (in realtà è una pièce teatrale, ma per affinità può essere fatta rientrare tra gli esempi chiave di questo ragionamento), L’amore ai tempi del colera del Premio Nobel Marquez, Una questione privata di Beppe Fenoglio, Il museo dell’innocenza di un altro Premio Nobel, Orhan Pamuk, e ancora Tenera è la notte di Fitzgerald, Addio alle armi di Hemingway, ma anche Anna Karenina di Tolstoj, Cime tempestose di Emily Brontë … e potrei andare avanti per pagine e pagine: nessuno di questi è un romanzo rosa. Sono solo una manciata di titoli scelti tra i classici e i classici moderni che tutti conosciamo: la letteratura tutta è vastissima e i romanzi d’amore letterari sono innumerevoli.
Nel podcast “La verità vi prego sull’amore” ne raccontiamo sei, scritti da uomini, da donne, di recentissima uscita come vecchi di un secolo: uno a puntata a partire dal 14 febbraio, per sei settimane, scandagliandone curiosità, aspetti linguistici, aneddoti sulla vita e l’arte degli autori e dimostrando, anche tracciando un possibile “identikit” del lettore ideale di ciascun libro, che vale l’adagio secondo cui “i romanzi d’amore piacciono a tutti”.
L'amante senza fissa dimora
La prima puntata racconta L’amante senza fissa dimora di Fruttero&Lucentini (Mondadori), uscito nel 1986 dalla penna di due grandi intellettuali dell’epoca che avevano però l’immensa capacità di non prendersi troppo sul serio. È per questa ragione che sono riusciti a scrivere un romanzo capace di scavalcare i generi e intercettare un pubblico molto vasto e che ben si presta a inaugurare un podcast che vuole sfatare il mito del romanzo d’amore come “romanzo rosa”.
Si tratta infatti dell’ennesimo mistero (Carlo Fruttero e Franco Lucentini sono stati i signori del romanzo giallo a partire da La donna della domenica del 1972) che stavolta però riguarda l’incontro tra una bella gallerista e un misterioso uomo venuto da chissà dove che di mestiere fa la guida turistica. Si svolge tutto in tre giorni, in una Venezia sconosciuta popolata anche da comprimari piuttosto comici. Perché, però, in definitiva i due protagonisti non possono amarsi? F&L non potevano che trovare una spiegazione colta e affascinante, perfetta per un podcast che ha la pretesa di non essere affatto banale.
Ascolta la prima puntata:
Le ho mai raccontato del vento del Nord
Daniel Glattauer con Le ho mai raccontato del vento del Nord (uscito in Italia per Feltrinelli) firma un successo che diventa immediatamente un best seller e poi un cosiddetto “long seller”. Nei primi anni Duemila racconta infatti la storia d’amore, antesignana per l’epoca, di due persone che si conoscono via mail, per una disdetta a un abbonamento mandata all’indirizzo sbagliato.
E se oggi non ci pare poi così strano intrattenere rapporti virtuali senza mai aver incontrato l’interlocutore, Glattauer ha, in questo modo, coraggiosamente attualizzato una forma letteraria vecchia come il genere umano: il romanzo epistolare.
Le domande che lo scambio brillante tra Emmi Rothner e Leo Leike fa sorgere nella mente del lettore, oltre a procuragli un sorriso divertito, sono quelle immortali: ci si innamora dell’anima? è possibile scegliersi senza essersi mai visti? l’amore è destinato a realizzarsi?
Glattauer mostra anche una freschezza di stile che nulla toglie alla bontà del romanzo e fa di questo libro un romanzo trasversale, con la classica caratteristica del “turning page”: il lettore vuole sapere come va a finire…
Ascolta la seconda puntata:
Lieto fine
Come apparirebbe una storia d'amore riletta al contrario? A partire dalla fine, cioè? Varrebbe la pena viverla di nuovo, già sapendo come va a finire? E ancora, riavvolgendo il nastro, diventerebbero più evidenti le ragioni di alcune scelte? l'origine di alcuni sbagli?
Lo spagnolo Isaac Rosa, in Lieto fine (Einaudi) procede esattamente in questo modo: racconta la storia d'amore di Antonio e Angela (che è già un secondo matrimonio) a ritroso, di modo che il "lieto fine" non possa essere altro che l'inizio. Raccontando "risalendo il torrente", il lettore non conosce mai quello che sta per succedere, ma che in realtà nell'ordine cronologico dei fatti è già accaduto, e l'alterazione del nesso di causa-effetto diventa per lo scrittore un modo sperimentare. Anche se Rosa non si ferma qui, quanto a sperimentazioni, perché cerca spesso di sovrapporre o di accostare il punto di vista femminile e maschile del suo ragionare, a volte proprio dividendo fisicamente la pagina in due.
La domanda delle domande resta comunque: anche a rovescio gli amori finiscono?
Ascolta la terza puntata:
L'amore ai tempi del colera
Iconico, irresistibile, mitizzato (e oggi, forse, un po' vituperato) è l'amore senza tempo: quello, cioè, che dura per sempre. Che esista o meno poco importa, quello che interessa è trovare un romanzo capace di raccontarlo senza fronzoli e senza cadere nel cliché. Istintivo viene di rivolgersi ai classici, perché ai giorni nostri questa possibilità viene guardata con sospetto e con un certo sarcasmo. Ma di romanzi capaci, di fondo, di sostenere la tesi senza romanticherie, non ce ne sono poi molti.
Senz'altro lo fa L'amore ai tempi del colera di Gabriel Garcia Marquez, un classico moderno, come si usa dire, uscito dalla penna del Premio Nobel nel 1985, tre anni dopo che l'aveva vinto. In questo romanzo la voce è fortemente ironica e non c'è poi molto del realismo magico per cui Marquez è entrato nella storia della letteratura, men che meno di romanticismo, nell'accezione sdilinquita che spesso attribuiamo al termine. Florentino Ariza e Fermina Daza, però, i protagonisti della storia, continuano ad amarsi, pur conducendo vite lontane, per ben cinquantatré anni, sette mesi e undici giorni. Se non è amore romantico questo...
Ascolta la quarta puntata:
Una scrittura femminile azzurro pallido
Siamo tutti convinti che il fenomeno del narcisismo patologico e del ghosting siano ascrivibili alla nostra contemporaneità: ai nuovi mezzi di comunicazione, sui quali scomparire equivale a premere un bottone, alle relazioni mordi-e-fuggi che seguono la fine (oramai diffusissima) del matrimonio, a nuovi schemi comportamentali identificati solo di recente dalla psicologia.
Se invece leggerete Una scrittura femminile azzurro pallido di Franz Werfel (Adelphi, 1991) vi accorgerete che già negli anni Quaranta questi modi d'agire erano in uso, esattamente come oggi: lui promette, a gran voce, mette in piedi una "vita verosimile" e poi scompare. Il romanzo si serve anche del cosiddetto "stratagemma del manoscritto", che qui è una lettera, anzi due, che cambiano il corso degli eventi creando una voluta suspense.
Infine, un aspetto affascinante della "voce" del romanzo è prodotto dal fatto che lo scrittore sceglie, in alcuni tratti, di far rivolgere il protagonista a un tribunale ideale nel tentativo di discolparsi. Ma, Vostro Onore, è possibile sparire e poi solo chiedere scusa?
Ascolta la quinta puntata:
Un oceano senza sponde
Una delle forme letterariamente più intense d'amore, è l'amore impossibile, di cui sono maestri indiscussi Romeo e Giulietta, e gli epigoni tantissimi. All'interno di questo sottoinsieme ce n'è a sua volta un altro: quello degli amori non corrisposti, in cui c'è qualcuno che ama incondizionatamente, e soffre, e qualcun altro che a volte non si rende neppure conto di cosa stia succedendo o vuole darlo a credere.
Una storia di questo tipo è raccontata da Scott Spencer in Un oceano senza sponde (Sellerio, 2022) che racconta le vicende di Kip, impiegato una società di finanziamenti, e Thaddeus, sceneggiatore in declino, ormai in un matrimonio tiepido, che aveva avuto con Kip un avvicinamento all'università che però non aveva portato a nulla di più, e il rapporto si era cristallizzato in un'apparente amicizia fraterna. Ma un certo punto, si sa, qualcosa si spezza sempre. Un oceano senza sponde è un romanzo sul lato più puro, e insieme ossessivo, delle relazioni umane e al contempo sulla difficoltà di accettare che un sogno possa non realizzarsi.
È possibile amare qualcuno senza essere mai ricambiati e non sviluppare una forma di ossessione rancorosa?
Ascolta la sesta puntata:
Intermezzo
L'irlandese Sally Rooney, classe 1991, autrice del romanzo da cui è stata tratta la serie TV "Persone normali", è considerata la voce più interessante tra gli scrittori della generazione dei Millennials e senza ombra di dubbio ha del talento. E parecchio. Questo suo nuovo romanzo, Intermezzo, il cui titolo rievoca una mossa degli scacchi, fa riecheggiare nella mente il suo titolo d'esordio, Parlarne tra amici, in cui si indagavano i meccanismi interni a una doppia coppia: due giovani ragazze e due ultratrentenni, ormai stanchi del loro matrimonio.
Anche stavolta ci sono due coppie, perché, in origine, ci sono due fratelli, di una decina d'anni l'uno più dell'altro, diversi quanto non si può immaginare. Uno, un po' Asperger, è un campione di scacchi poco più che ventenne e s'innamora di una donna separata di oltre trenta, e l'altro, un avvocato in carriera, si barcamena tra una relazione ormai bianca con la sua fidanzata storica imprigionata dentro se stessa dopo aver subito un incidente e il rapporto apparentemente solo fisico con una ragazza giovane...
Rooney anche in questa prova ci mostra quanto sia difficile avere a che fare con gli altri e in definitiva con noi stessi. Lo fa con gli strumenti della comunicazione contemporanea e le armi della letteratura.
Ascolta la settima puntata:
Leggi gli altri articoli della serie "La verità vi prego sull'amore":
- La verità vi prego sull'amore. I romanzi d'amore piacciono a tutti
- La verità vi prego sull'amore: Tutto quello che so dell’amore di Dolly Alderton
- La verità vi prego sull'amore: Il coltello sul vassoio di Veronica Chiossi
- La verità vi prego sull’amore: I mariti di Holly Gramazio
- La verità vi prego sull'amore: Ricompense di Jem Calder









