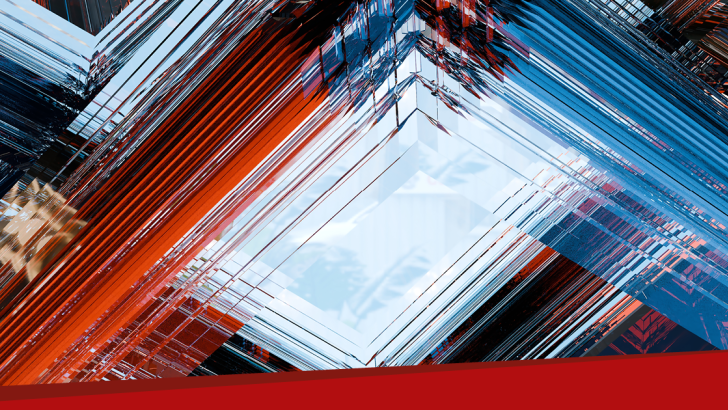Il servizio pubblico in un mondo di TV commerciali

Una parte della storia della televisione italiana è quella che riguarda la comparsa delle prime emittenti private cinquant'anni fa e il loro rapporto con la televisione pubblica. Era il 1970 quando venne fondata la società Telenapoli Telediffusione italiana, seguita da Telebiella l'anno successivo. Nel corso degli anni successivi, le tv private iniziarono a diffondersi sempre di più nel nostro Paese. Quali sono state le tappe principali di questo processo e com'è cambiata la loro missione da allora fino ad oggi?
Lo abbiamo chiesto a Renato Parascandolo, giornalista, saggista, già direttore di Rai education e autore del libro La televisione oltre la televisione (2000).
“Fino alla metà degli anni settanta, in Italia, c'erano solo tre canali radiofonici e due televisivi: il canale Nazionale e il secondo canale: quindi, il monopolio da parte dello Stato sulle trasmissioni radiotelevisive.
Nel 1969 le lotte sindacali dell'autunno caldo si sposano con il movimento studentesco; da questo inedito incontro nasce, tra l’altro, una riflessione sul mondo dell'informazione e sulla necessità di avere una Rai che garantisca il pluralismo e l'accesso alla programmazione alle minoranze politiche e alle opposizioni in generale. Dalla mobilitazione che ne seguì cominciò a prendere forma il progetto di riforma della Rai che vide la luce nel 1975 con il passaggio, invocato dalla corte Costituzionale un anno prima, dal controllo dell’esecutivo a quello del Parlamento: il Partito comunista entra, per la prima volta, a far parte del Consiglio d’amministrazione mentre viene garantito il diritto di accesso alle associazioni rappresentative della società civile.
Nascono, contestualmente, le prime radio libere animate anch’esse da un analogo desiderio di partecipazione e di ampliamento del discorso pubblico. Ma, per quanto apprezzabili fossero le loro intenzioni, queste radio aprono un varco nel monopolio che consentirà poi ai grandi gruppi di approfittarne per creare un'alternativa commerciale alla televisione di servizio pubblico. Queste eterogenesi dei fini fu lucidamente annunciata dal libro “L’antenna dei padroni” di Francesco Siliato, del gruppo Index, nel 1977. La nascita e la proliferazione delle Tv locali spalancarono le porte alla Fininvest (poi Mediaset), di Berlusconi.
Poiché la sentenza della Corte non consentiva emittenti a livello nazionale, Mediaset, che aveva acquistato molte tv locali, trasmetteva a livello regionale mandando in onda, simultaneamente, la videocassetta del medesimo programma realizzando, di fatto, un’emittente nazionale. In seguito, grazie anche ad alcune leggi compiacenti, la “libertà di antenna” di trasformò in un duopolio blindato (Rai - Mediaset) che oltre a impedire un regime di libera concorrenza, ha costretto il servizio pubblico a mantenere gli ascolti al livello del suo concorrente per evitare che quest’ultimo fosse accusato di abuso di posizione dominante. Questo stato di cose, di cui i governi che si sono succeduti negli ultimi trent’anni portano grandi responsabilità, ha provocato un impoverimento progressivo della qualità dei programmi della Rai in favore di una spettacolarizzazione improntata alla banalità e alla ripetitività: un danno gravissimo per un paese arretrato culturalmente, con decine di milioni di analfabeti funzionali”, commenta Parascandolo.
L'intervista completa a Renato Parascandolo sulla nascita delle emittenti private e sulla missione della televisione pubblica. Servizio di Federica D'Auria e montaggio di Elisa Speronello.
Qual è il valore della televisione pubblica in uno stato democratico e perché è importante che rimanga il più possibile indipendente dalle agenzie pubblicitarie e che non venga privatizzata?
"Il servizio pubblico radiotelevisivo è una caratteristica del welfare europeo come il diritto alla salute e all’istruzione", risponde Parascandolo. "Tuttavia, bisogna chiedersi: con quale motivazione si legittima l’esclusiva alla Rai di questo servizio pagato dai cittadini? Prima dell’introduzione del digitale terrestre, le frequenze analogiche disponibili erano molto limitate e questa impossibilità di assicurare un ampio pluralismo di offerta televisiva giustificava l’esistenza di un servizio pubblico controllato dal Parlamento. Ma con la rivoluzione digitale, la motivazione della rarità delle frequenze non era più sostenibile.
Da parte mia, in un libro edito nel 2000, “La televisione oltre la televisione” motivai la fondatezza del servizio pubblico con la necessità di temperare gli effetti negativi prodotti dal modello di televisione commerciale fondato sulla pubblicità, un modello fortemente pervasivo in quanto gratuito (apparentemente) per il telespettatore.
Nella televisione commerciale il modello di business è diverso da quello classico (dal produttore al consumatore). In questo caso il commercio avviene tra l’emittente televisiva e l’agenzia di pubblicità. L'emittente vende degli spazi di palinsesto all’inserzionista quotandoli in base al numero di telespettatori che mediamente guardano la tv a quella data ora. Di conseguenza, il telespettatore non è più un cittadino-consumatore bensì l'oggetto del commercio; in altre parole, la merce: una merce che viene contata con l’Auditel, impacchettata e venduta alle agenzie di pubblicità. La Tv commerciale, quindi, produce telespettatori-merce e i programmi sono solo l’esca per produrne quanti più possibile. In aggiunta, possiamo anche dire che lo sguardo di ciascun telespettatore produce valore poiché fa aumentare di una piccolissima quota il prezzo di quello spazio di programmazione. Portando fino in fondo il ragionamento possiamo arrivare alla conclusione che, producendo valore, il telespettatore della Tv commerciale, di fatto, lavora. La massimizzazione degli ascolti è il fine ultimo di ogni programma della Tv commerciale; pertanto la qualità non è determinata dal contenuto delle trasmissioni ma esclusivamente dalla quantità di telespettatori che il programma-esca produce. Qui sta l’aspetto oggettivamente “non educativo” della Tv commerciale che, essendo gratuita, entra nelle case di tutti senza chiedere permesso e fa di tutto per far “morire dal ridere”.
Ecco che cosa legittima, ancora oggi, l’esistenza della Rai, quindi di un forte servizio pubblico in grado di competere con quel modello di televisione che, finanziandosi con la pubblicità, mercifica il telespettatore.
Naturalmente, la televisione pubblica ha diritto di esistere finché rispetta la missione che ha ricevuto dal Parlamento: aiutare la crescita civile e culturale dei cittadini, sollecitare la formazione di una coscienza critica e di una facoltà di giudizio fondata sulla ragione piuttosto che sulla suggestione. La televisione commerciale, legittimamente, non è tenuta a perseguire questi obiettivi; al contrario questa mission per la Rai è un obbligo: se non fosse rispettata, la legittimazione a esistere come servizio pubblico, verrebbe a cadere”.

"Diamo ora uno sguardo ai tratti che assume su Internet il modello della Tv commerciale fondato sulla pubblicità, un modello che è diventato dominante e determinante soprattutto dopo la nascita dei social network. Su Internet questa “economia del gratis” assume caratteri prodigiosi innanzitutto per il fatto che mentre “l’annuncio per gli acquisti” televisivo è indirizzato a un utente generico, lo spot su Internet, grazie alla profilazione degli utenti, colpisce il suo bersaglio (target) senza disperdere colpi", continua Parascandolo.
"Qui, il modello del profitto conseguito vendendo utenti-merce alle concessionarie di pubblicità raggiunge la perfezione: una sorta di grado zero dell’economia. Infatti, mentre nell’universo televisivo la produzione di telespettatori richiede notevoli investimenti (bisogna pur produrre o acquistare programmi che massimizzino l’audience in una data fascia oraria), nello sconfinato mondo del Web i contenuti sono in gran parte prodotti (questi sì, gratuitamente) dagli utenti stessi (user-generated-content). Qui, la mercificazione assume caratteri paradossali. Infatti, il navigatore, che “posta” un contenuto autoprodotto su una delle piattaforme on-line che raccolgono video, foto, testi e messaggi, esonera queste ultime dal sobbarcarsi il costo dell’esca necessaria per catturare gli utenti-merce. Quindi, l’utente-merce produce gratuitamente contenuti che, a loro volta, produrranno altri utenti-merce. Prendendo scherzosamente a prestito la famosa formula di Sraffa, potremmo dire che il modello di business dominante su Internet è basato sulla produzione di utenti-merci a mezzo di utenti-merci, un meccanismo che genera profitti a ritmo esponenziale soprattutto ai grandi marchi, detentori di hardware e software proprietari, ma anche di raffinati algoritmi di profilazione degli utenti. Così funziona l'economia del gratis, una teoria compendiata da Chris Anderson, il suo più autorevole sostenitore, nei seguenti termini: “Coloro che comprendono il nuovo Gratis padroneggeranno i mercati di domani e sconvolgeranno quelli di oggi: anzi già lo stanno facendo”.
E’ diffuso un sentimento di rassegnazione nei confronti di una rete dominata da cinque colossi dell’hi-tech e in cui proliferano fenomeni come le fake news e gli odiatori da tastiera. Anche lei pensa che non vi sia un futuro migliore per internet?
"Certo, il modo in cui funziona e prospera il modello di business basato sulla creazione di utenti-merce, è certamente un motivo in più per giustificare atteggiamenti catastrofisti; tuttavia, piuttosto che lasciarsi andare alla rassegnazione, varrebbe la pena immaginare un’azione politica di contrasto allo strapotere dei social network e dei motori di ricerca privati che si ispiri agli stessi valori e motivazioni che legittimano i servizi pubblici radiotelevisivi.
Penso alla creazione di un’internet bene comune, un organismo internazionale che raccolga non solo le TV pubbliche europee ma anche tutte quelle realtà che da anni svolgono un‘attività di promozione della cultura e del dibattito pubblico; penso alle più importanti università del mondo che da anni rendono pubblici i loro papers e le loro lezioni; penso al mondo dell’Open source, a Wikipedia, al progetto Gutenberg a tutte quelle entità che operano sulla rete senza pubblicità e senza chiedere remunerazioni. Ebbene, quest’organismo oltre a coordinare questa gigantesca “intelligenza collettiva” potrebbe assegnare, a chi dimostra di essere ispirato all’idea di “internet bene pubblico”, un marchio, un segno di riconoscimento".
Quale dovrebbe essere la mission di un Internet bene comune?
"Ci sono 4 miliardi di persone che per la prima volta nella storia dell'umanità hanno avuto, nel giro di 15 anni, per la prima volta la possibilità di prendere la parola e accedere al dibattito pubblico con tutti i limiti e le esasperazioni che questo può significare su un territorio dominato da interessi privati colossali, privo di una reale regolamentazione, in cui le autorità statuali (magistratura, polizia, ecc.) fanno ancora molta fatica a presidiare.
E’ possibile che ancora non ci si renda conto di quanto sia gigantesca questa mutazione antropologia legata al passaggio dalla comunicazione da “uno a molti” a una comunicazione da “molti a molti”?
Il problema che si pone è il seguente: che cosa farne di questi 4 miliardi di persone entrate a far parte discorso pubblico? C’è chi, con eccesso di snobismo, considera i terrapiattisti, complottisti, i no vax ecc. come barbari, nuova plebe o “una massa resa insicura e guidata dall’angoscia, che facilmente si fa monopolizzare dalle forze nazionaliste e razziste” (Byung-Chul-Han), tant’è che non resterebbe altro da fare, per salvare la propria dignità, che “disconnettersi e cancellare le tracce” (Jaron Lanier).
La mancanza di un progetto di rete, alternativo a quello attuale, dominato da un oligopolio che fattura più del Pil della Germania induce, comprensibilmente, alla rassegnazione; ma la sfida imposta da questo tumultuoso ingresso sulla scena pubblica di miliardi di persone che fino a ieri potevano esprimere le loro opinioni solo in ambiti privati e comunque circoscritti, non ha giustificazioni. I partiti e le organizzazioni politiche di massa del XXI secolo devono necessariamente confrontarsi con questa nuova dimensione del discorso pubblico”, conclude Parascandolo.