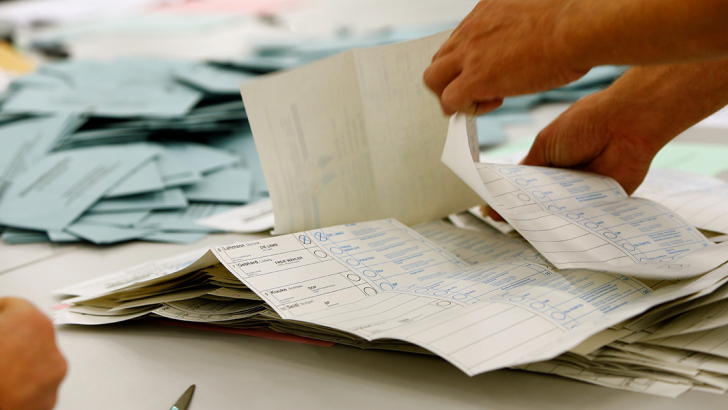SOCIETÀ
Italia-Germania, quando gli stereotipi contano

Foto: Reuters/Daniel Dal Zennaro/Pool
Tedeschi prepotenti e rigidi, italiani fin troppo creativi e inaffidabili: quanto contano ancora gli stereotipi? “Abbastanza, e sono tornati in auge con la crisi – risponde Filippo Focardi, docente di storia contemporanea presso l’università di Padova – Oggi ad esempio l’opinione pubblica italiana è attraversata da forti impulsi antitedeschi, dato che molti vedono nella Germania di Angela Merkel la principale responsabile delle politiche di austerità economica imposte all’Italia dall’Unione europea, in linea del resto con quanto emerge negli altri paesi europei afflitti dalla crisi”. E sul versante opposto? “Certo non mancano nemmeno in Germania stereotipi sulla scarsa affidabilità, la furbizia e il pressappochismo degli italiani. Emblematico è il caso del naufragio della nave da crociera Costa Concordia: all’epoca del disastro il settimanale Der Spiegel scrisse che una cosa del genere poteva succedere solo in Italia, attirando la reazione di parte della nostra stampa, che non ha esitato a tirare in ballo il nazismo o addirittura Auschwitz. Il tutto poi ulteriorimente amplificato dalla polemica sui social network, con abbondanza di commenti germanofobi”.
Anche di questo si è parlato nel recente convegno di studi, I rapporti tra Italia e Germania dalla riunificazione tedesca alla crisi dell’euro. Una reciproca diffidenza che talvolta sfocia in un’antipatia ostentata, e che negli ultimi tempi ha anche iniziato ad essere cavalcata dalla politica, oggi soprattutto dalla destra e dal Movimento 5 stelle. Un malessere e una diffidenza comunque crescente e soprattutto trasversale a tutte le forze politiche. “Allo stesso modo però crescono nel dibattito pubblico italiano anche i riferimenti ad un presunto modello tedesco – puntualizza Focardi – da seguire ad esempio sul piano della legislazione inerente i rapporti di lavoro (Jobs Act), i diritti civili (unioni di fatto), la scuola e la formazione dei giovani per il mercato di lavoro (il sistema duale nella scuola superiore)”.
Un rapporto complesso e ambivalente, non esente da una certa dose di ammirazione da parte italiana, quando di non malcelata invidia. Continua Focardi: “Sembra insomma riproporsi un sentimento di attrazione-repulsione, ammirazione-rifiuto nei confronti dei tedeschi e della Germania che Enzo Collotti ha descritto come caratterizzante l’atteggiamento italiano dal Risorgimento in poi” (vedi la voce I Tedeschi ne I luoghi della memoria, a cura di M. Isnenghi, Laterza 2011, ndr). Un rapporto soggetto a periodiche oscillazioni: dalla collaborazione militare in seno alla Triplice alleanza alla prima guerra mondiale, che vede invece i due paesi contrapposti; dall’asse d’acciaio nazi-fascista all’armistizio separato e al cambio di fronte del governo Badoglio. Con un periodo, quello dell’occupazione nazista del Nord Italia, destinato a lasciare ferite profonde nel rapporto tra i due paesi, come dimostrano le recenti polemiche sulle stragi naziste e sul trattamento degli Internati Militari Italiani.
Successivamente alla seconda guerra mondiale sembra seguire un ‘momento magico’ di armonia tra i due stati, entrambi accomunati dal ruolo di ex potenze sconfitte, occupate soprattutto nella rinascita economica e nella costruzione europea, tanto che lo storico Hans Woller arriva a scrivere di una sorta di special relationship italo-tedesca. Negli anni Cinquanta e Sessanta, come ha messo in evidenza durante il convegno padovano lo storico contemporaneo Christian Jansen, soprattutto la sinistra tedesca diffonde una visione molto positiva dell’Italia, percepita all’inizio come una sorta di felice “connubio di umanesimo e comunismo”.
L’incanto però si rompe già negli anni Settanta con la crisi economica e il terrorismo. Dopo la caduta del Muro la Germania si emancipa progressivamente dalla condizione di ‘nano politico’ a cui era condannata durante la guerra fredda, e i rapporti con l’Italia (ma non solo) diventano sempre più squilibrati. “Oggi fra Italia e Germania permane un’asimmetria politico-istituzionale già rilevata da Gian Enrico Rusconi a partire dal 2007 nella stabilità e nell’efficacia dei governi e nella credibilità in genere della classe dirigente (vedi il volume Estraniazione strisciante tra Italia e Germania?, Il Mulino 2008, ndr). A questa si è aggiunta dopo la crisi anche un’asimmetria economica sempre più marcata, con un’Italia che oggi fronteggia un processo di deindustrializzazione e una disoccupazione giovanile superiore al 44%, contro il 7,4% tedesco”.
E per il futuro? “Negli ultimi anni processo di allontanamento delle élites dirigenti italiane e tedesche forse si è accentuato dopo il fallimento dell’esperienza del governo Monti e la nascita di nuovi soggetti come il Movimento Cinque stelle, percepito come populista” conclude Focardi. “Un sfiducia che si aggiunge all’allerta vissuta per fenomeni come l’ascesa politica di Silvio Berlusconi, la Lega Nord e lo spettro della destra neofascista dopo l’arrivo al governo di Alleanza nazionale. Oggi verso il governo Renzi c’è attenzione, ma anche parecchio disincanto”.
Daniele Mont D’Arpizio