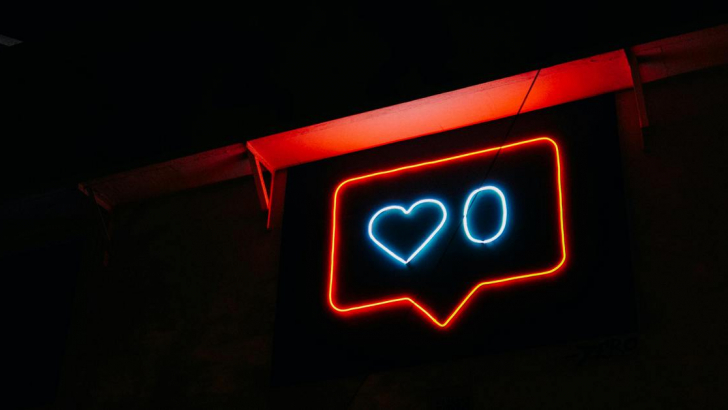SOCIETÀ
Un tag ci seppellirà

Foto: Daniel Biskup/laif/contrasto
Con notevole lungimiranza, nel 2008 i curatori del più celebre dizionario di lingua inglese del mondo, il Merriam-Webster, hanno proclamato "neologismo dell'anno" la parola overshare, che in italiano si potrebbe tradurre con “ipercondivisione” e che, come nota un articolo uscito all'epoca su PRWeb, equivale a una piccola sigla estremamente chiara: TMI, too much information. Poco conta se le “informazioni eccessive” siano state deliberatamente lanciate in pubblico o se siano sfuggite per uno di quei lapsus che già Freud ci insegnava a non considerare accidentali: la vera novità di un concetto probabilmente antico come il mondo è che oggi, grazie ai social network, il flusso di parole e di immagini che non avrebbero motivo di circolare, se non in una cerchia di pochi intimi, travolge sia chi, con molta fatica, cerca di starsene alla larga, sia chi invece “ipercondivide” allegramente, nella convinzione di aver mostrato al mondo qualcosa di importante o, al contrario, che tutto alla fine passa e scompare senza lasciare traccia. Non è così, spiegano adesso, a cinque anni di distanza dalla consacrazione del Merriam-Webster, numerosi articoli allarmatissimi sulle conseguenze individuali e collettive dell'oversharing, che dal 2008 a oggi ha assunto dimensioni spropositate.
Tutto quello che lanciamo, senza troppo pensarci, a disposizione dei nostri invisibili lettori – il commento acido dopo un litigio, la fotografia scattata nel corso di una festa molto alcolica – si deposita infatti all'interno di un serbatoio da cui chiunque potrà pescare a suo piacimento. E non si tratta solo dei Grandi Fratelli Governativi che, come ci ha confermato Edward Snowden, ben poco si lasciano sfuggire dei nostri movimenti, ma anche di figure assai più vicine a noi: mariti e mogli, colleghi e datori di lavoro, (ex) amici... In un articolo pubblicato ad agosto su reputation.com, The consequences of oversharing on social networks, la canadese Shelly Wutke scrive che in America, su cinque richieste di divorzio presentate online, una cita Facebook fra le cause della decisione. E How oversharing on social networks can hurt your career (“Come l'ipercondivisione sui social network può danneggiare la tua carriera”) è il titolo di un intervento della giornalista newyorkese Donna Fuscaldo, che avverte: “Quando una persona cerca impiego, è normale che il potenziale datore di lavoro vada a vedere le sue pagine sui social network prima di fissare l'intervista e che, a torto o a ragione, escluda a priori i candidati che esibiscono contenuti inappropriati”. Insomma, anche senza contare altri rischi connessi a una esagerata esposizione di sé (Wutke, per esempio, afferma che anche i ladri oggi tengono d'occhio le pagine dei social network per sapere se le vittime designate sono andate in vacanza), sarebbe utile contare fino a dieci prima di rendere pubblici materiali che riguardano personalmente noi e chi ci sta vicino. A questa semplice regola, in fondo, si riducono molti dei consigli rivolti agli oversharersche in questa estate 2013 si rimbalzano da un sito all'altro.
Più interessante, e probabilmente più proficuo, sarebbe però capire come mai anche persone non particolarmente esibizioniste scelgano di mettersi ogni giorno in vetrina. In una ricerca intitolata Extended Self in a Digital World , “Il sé esteso in un mondo digitale”, che uscirà sul Journal of Consumer Research a ottobre (la anticipa Paul Hiebert su “Slate”: The Real Reason Why So Many People Overshare on Facebook), Russell W. Belk, docente di marketing alla York University di Toronto, prova a rispondere, affermando che i social network producono una sorta di “effetto disinibizione”: “Quando guardiamo lo schermo, non ci confrontiamo fisicamente con qualcuno che può reagire subito ai nostri stimoli, per cui è più facile lasciarsi andare. È come se fossimo invisibili, ma il paradosso è che, invece di una sola persona, ci sono potenzialmente migliaia o centinaia di migliaia di persone che ricevono quello che noi mettiamo là fuori”.
Secondo Belk, questa linea sempre più impalpabile che ci separa dagli altri rende gradualmente più complessa la nostra idea di noi stessi in quanto individui. Ribatte Veronica Agard su policymic.com che non necessariamente un simile cambiamento porta maggiore comprensione o empatia, al contrario. Mettere sulla propria pagina Facebook il logo di una campagna per i diritti umani è un segno di solidarietà, certo, ma non equivale a un'azione concreta: “Il bello e il brutto dei social media è che, sebbene possano unire tante persone e dare avvio a rivolte e movimenti, spesso si riducono a una ipercondivisione fine a se stessa. Con il risultato di una progressiva desensibilizzazione verso quello che abbiamo di fronte, virtualmente e fisicamente”.
Maria Teresa Carbone