Vuoi bere? Paga!
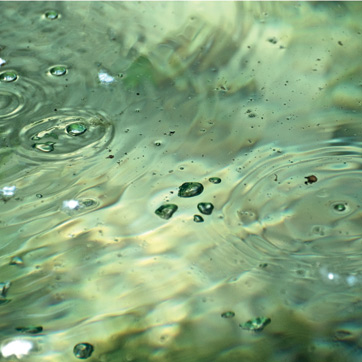
Foto di Carlo Calore
L’acqua, come impariamo fin dai primi anni sui banchi di scuola, e come la più semplice delle osservazioni ci conferma, è alla base della vita sulla terra. È quindi facile comprendere come questa risorsa sia così preziosa da generare, oggi come in passato, spinte politiche e sociali tali da sfociare in conflitti, e sollevare non pochi problemi riguardo al suo sfruttamento e utilizzo. La scala degli interessi in gioco può essere vista in chiave locale, dove carenza o abbondanza sono immediatamente evidenti, ma appare in tutta la sua portata soprattutto in un'ottica globale: la “sfida” dell’acqua non è infatti solo quella di cui si parla nei casi di siccità estiva in Italia o in altri Paesi.
Alcuni concetti possono aiutare a comprendere il fenomeno nella sua interezza: quelli dell’impronta idrica e della virtual water, l’acqua virtuale: ovvero il consumo di acqua necessario alla produzione di un qualsiasi bene, agricolo o industriale, e il suo utilizzo per portare un determinato prodotto al suo consumatore finale. “Un chilogrammo di pomodoro - spiega il professor Carlo Giupponi, economista all’università Ca’ Foscari – “contiene” 180 litri di acqua”, uno di carne 15.500 litri, mentre un singolo hamburger richiede 2.400 litri di acqua. Anche il solo buttare del cibo comporta uno spreco di questa risorsa e se le previsioni di crescita della popolazione e di fabbisogno alimentare “saranno confermate - conclude Giupponi - sarà necessaria una gestione efficiente su scala globale di questa risorsa”.
Ma proprio questa gestione glocal, dal globale al locale, pone molti interrogativi sui metodi per raggiungere questo scopo. L’acqua è una risorsa primaria, indispensabile, e il suo sfruttamento, nei diversi ambiti, deve essere pensato nell’ottica di non creare squilibri nel suo utilizzo. In Italia il referendum per l’acqua del 12 giugno 2011 ha sancito la volontà degli italiani di rifiutare le diverse forme di privatizzazione dell’acqua e dei servizi pubblici locali ad essa connessi messe in atto in questi anni. Nonostante il voto, il dibattito resta comunque aperto tra chi ritiene impossibile garantire una gestione oculata di questa risorsa da parte di un’amministrazione interamente pubblica preferendogli i privati, e chi difende il ruolo del servizio pubblico come garante di equità, ritenendo la gestione diretta il solo modo per garantirne il carattere di bene pubblico. Il dibattito non è solo italiano e apre una serie di considerazioni di portata internazionale. La gestione dell’acqua è un calcolo complesso che deve tenere conto di variabili territoriali, nazionali e internazionali, di costi infrastrutturali, modalità di utilizzo – civile, agricolo, industriale, per la produzione di energia - e ovviamente della sua abbondanza o meno.
Se in Italia non esiste il concetto di mercato dell’acqua, così non è per altri Paesi in cui le normative vigenti prevedono una gestione aperta a soggetti privati in concorrenza, come quella che interessa oggi altri servizi “a rete” come l’energia elettrica o il gas, e dove gli interessi economici si intrecciano con quelli della gestione del bene. “La discussione sull’acqua, come su altre risorse principali, coinvolge elementi quali la gestione dei diritti di proprietà e di sfruttamento, preoccupazioni ambientali e sociali sull’utilizzo delle regole di mercato per la sua distribuzione, creando problemi di equità sociale tra i soggetti interessati: consumatore, produttore e politica”. Lo dice l’economista e premio Nobel nel 2000, Daniel Little McFadden, che affronta la questione come sostenitore della privatizzazione dell’acqua, una misura a suo parere “in grado di portare a una razionalizzazione e a un uso della risorsa più efficiente”. “Il commercio dell’acqua non è etico? - chiede retoricamente McFadden - Anche una risorsa primaria gestita dai privati può fare gli interessi del sociale se i meccanismi che regolano il mercato sono realizzati con determinate caratteristiche”. D’altra parte Paesi come Stati Uniti, Cile, Israele, Australia e Spagna adottano sistemi legislativi in cui il mercato dell’acqua è prassi consolidata da anni, sempre tenendo però in conto il fabbisogno comunitario a fianco di quello economico dello sfruttamento.
McFadden si spinge oltre e propone di tradurre un modello già usato (e osteggiato in alcuni casi) per gestire la produzione di energia elettrica e l’inquinamento che ne deriva. Si tratta del cap and trade, un modello manageriale per il controllo dell’inquinamento in cui un governo stabilisce un limite massimo (cap) alla quantità di emissioni di un dato inquinante da parte delle aziende e distribuisce poi un determinato numero di permessi, corrispondenti a una quota di emissioni inquinanti. Le imprese “virtuose”, che non inquinano, possono alla fine vendere la loro quota di permessi, generando profitto, quelle invece inquinanti devono a loro volta acquistarli per “pagare” la loro quota di inquinamento. Una logica simile a quanto messo in atto con il protocollo di Kyoto per le immissioni di Co2 nell’aria e che negli Stati Uniti ha portato a una riduzione dell’inquinamento causato dalle centrali elettriche a carbone. “Questo sistema - spiega McFadden - potrebbe portare a un miglioramento della gestione e della distribuzione dell’acqua, comportando benefici in termini ambientali e per limitare gli sprechi”. L’economista non spiega i meccanismi attraverso cui il cap and trade potrebbe essere applicato, ma una ricerca dell’Iwrm-net (Towards a European exchange network for integrating research efforts on integrated water resources management) analizza proprio questa metodologia per applicarla al ciclo di gestione dell’acqua come scenario (possibile o meno) per l’Europa del Sud.
Non appare però sostenibile un modello che affida alla sola capacità individuale di spesa la distribuzione effettiva: i rischi, a livello sociale ma anche sanitario, sono eccessivi. Una consapevolezza, questa, testimoniata dai ripetuti richiami dell’Organizzazione mondiale della sanità, che sottolinea come la prima misura per prevenire epidemie sia la disponibilità di un minimo vitale d’acqua pro-capite comunque assicurata, ma anche dalla legislazione italiana che, in caso di incapacità di spesa, consente alle aziende erogatrici la riduzione del flusso, ma non la completa interruzione. Gestire l’acqua in modo privatizzato richiede dunque, preliminarmente, una serie di misure di compensazione, dato che comporta un rischio elevato di aumento dei costi di gestione che poi ricadranno sull’utilizzatore finale.
Il politologo Edward Luttwak preferisce spostare l’attenzione sui metodi di gestione dell’acqua: “Il problema non è l’abbondanza o meno della risorsa ma il modo in cui questa viene amministrata”. Per l’economista del centro internazionale di studi strategici di Washington, l’acqua ha un suo ciclo virtuoso “laddove viene gestita con oculatezza”. È il caso di Israele dove, in un regime di privatizzazione e di scarsità, il bene raggiunge tutti senza sprechi e passando oltre a questioni di politica e guerre: “Tra Israele e Giordania ci sono state due guerre - spiega Luttwak - e mai si è pensato di usare l’acqua come mezzo per giungere a un compromesso”. In tempi più recenti, lo stesso è accaduto nelle battaglie lungo la Striscia di Gaza, durante le quali Israele non ha mai chiuso i rubinetti dei suoi acquedotti. Ma altri esempi di privatizzazione sono invece finiti in rivolte o rappresentano, anche in zone dove la risorsa è abbondante, partite geopolitiche di scala internazionale.
Con una rivolta è finito il tentativo, da parte del governo boliviano, di privatizzare la gestione dell’acqua nel distretto di Cochabamba: è il 1999 quando la società americana Bechtel (vi partecipa anche l’italiana Edison) assume la gestione del servizio idrico. Le conseguenze sono disastrose: le tariffe aumentano nel giro di pochi mesi del 300% e pesano molto su un reddito pro-capite mensile di appena 60 dollari. Nel giro di un anno, a fronte di massicce proteste di piazza, il governo ritira la legge sulla privatizzazione dell’acqua. “L’acqua in Bolivia non manca - argomenta Luttwak, ma il pagamento di una tariffa elevata presuppone la disponibilità economica di un Paese ad accettarla, altrimenti il sistema non può reggere”.
Diverso il caso della “guerra” dell’acqua in corso nel Sudest asiatico e che coinvolge Cina, Laos e Vietnam per la gestione del fiume Mekong. La disputa riguarda la costruzione di dighe per la produzione di energia elettrica in Cina e poi in Laos, che comprometterebbero la portata del fiume a discapito degli Stati più a valle. “In questo caso la diplomazia internazionale si sta adoperando”, dice Luttwak. Nasce già nel 1995 la commissione per il fiume Mekong, organismo (con all’interno del board componenti americane ed europee) per dirimere le questioni legate allo sfruttamento del corso d’acqua: “Il conflitto in essere non è per la mancanza di acqua - conclude Luttwak - ma per la gestione geopolitica di una risorsa essenziale in una zona inserita nel principale asse della politica internazionale”. Piani diversi si intrecciano insomma nella visione futura per la gestione dell’acqua. L’attenzione dovrà essere massima e la svolta di sensibilizzazione sul tema (il 2013 sarà l’anno della cooperazione internazionale per l’acqua) dimostra come ci troviamo di fronte ad un argomento in grado di destabilizzare il sistema economico e sociale su scala globale come locale.
Mattia Sopelsa









