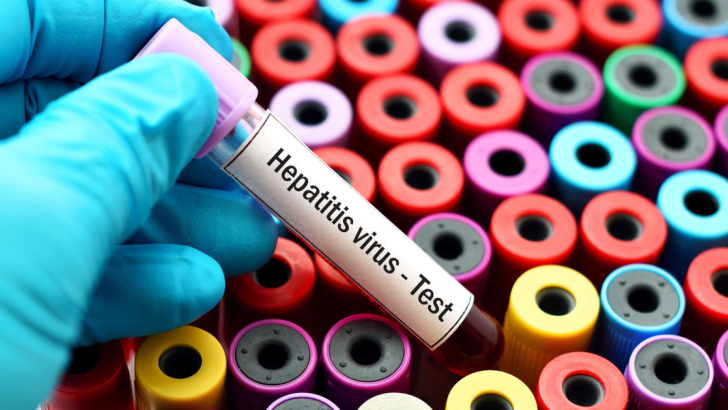Le due battaglie contro Ebola

Prove di vestizione degli indumenti protettivi contro il contagio del virus ebola. Foto: Reuters/Susana Vera
Questo 2016 non è iniziato bene per il mondo dello spettacolo e della cultura e per il suo pubblico. Poco più di una settimana dopo il giorno di capodanno le agenzie di mezzo mondo hanno battuto la notizia che David Bowie era morto all'età di 69 anni. Appena quattro giorni dopo dal Regno Unito veniva comunicata la dipartita di Alan Rickman, a 70 anni, l'indimenticato Severus Piton della saga di Harry Potter. Il 19 febbraio, si è spento, nella casa milanese, Umberto Eco, uno degli intellettuali italiani per antonomasia, un mese e mezzo dopo aver compiuto 84 anni.
Tra questa serie di lutti e di cronache di funerali affollati da parenti, amici e fan, è passata un po' in sordina una bella notizia. Alle 10:45 del mattino del 14 gennaio, l'Ansa rilancia il comunicato dell'OMS:” Tutte le catene note di trasmissione del virus Ebola sono state fermate in Africa Occidentale.” Il braccio operativo dell'Onu in ambito sanitario quel giorno di tre mesi fa decretò ufficialmente la fine dell'epidemia che per due anni afflisse Sierra Leone, Liberia e Guinea.
I dati sul numero delle vittime che il virus ha mietuto tra la popolazione locale sono noti ormai da tempo. Il CDC di Atlanta (Center for Desease Control) riporta in una tabella asettica e pratica da consultare: più di 2.500 morti in Guinea, poco meno di 4.000 in Sierra Leone e circa 4.800 in Liberia, su un totale di 28.600 persone contagiate da Ebola in Africa occidentale. Grafici colorati evidenziano come dall'ottobre del 2014 ci sia stata un'impennata dei casi confermati di Ebola, specialmente in Sierra Leone e Liberia, prima dello scemare dei nuovi contagi verso fine del 2015.
Al di là di numeri, dati, mappe ciò che rimane più fumoso, meno spiegato e poco raccontato, è cosa significhi curare un paziente affetto da Ebola. Che cosa vuol dire per un medico, un infermiere, trovarsi nella “zona rossa”, l'area dove i malati contagiosi di Ebola ricevono le terapie? Quali scene di drammi quotidiani si svolgono di continuo davanti agli occhi di un operatore sanitario occidentale impegnato in un Ebola Treatment Center africano? Ha provato a raccontarlo, a Padova - in un'aula gremita di studenti - Fabrizio Pulvirenti, medico infettivologo siciliano e volontario di Emergency. Pulvirenti ha condotto due battaglie: la prima in Sierra Leone, tra le schiere dei coraggiosi che hanno lottato contro un nemico tanto invisibile quanto letale, chiamato virus Ebola; la seconda a Roma, nel reparto di terapia intensiva dell'Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, per sopravvivere proprio al nemico invisibile che per mesi il medico catanese ha cercato di debellare e che da novembre ai primi di gennaio del 2015 affliggeva il suo organismo.
Arrivare in uno stato africano come la Sierra Leone vuol dire innanzi tutto scendere in campo con già un goal di svantaggio. La povertà di questo paese rappresenta un gravissimo handicap per chiunque (Emergency, Medici Senza Frontiere, OMS poco importa) si lanci nell'impresa di contenere un fenomeno complesso e diffuso come l'epidemia di Ebola di due anni fa. Non a caso i tre paesi più martoriati da questo flagello, Sierra Leone, Liberia e Guinea, sono alla posizione 183, 179 e 175 su 187 paesi di tutto il mondo, nella classifica dell'indice di sviluppo economico.
Il villaggio di Meliandou, in Guinea, dove si è registrato il primo contagio dell'epidemia, è un aggregato di capanne di fango con il tetto spiovente di foglie di palma essicate, nel fitto della vegetazione, che di giorno in giorno si riduce per la deforestazione incontrollata. Non sono presenti né un impianto fognario, né un acquedotto ed in generale manca qualsiasi infrastruttura di base al di là di una strada.
In questo angolo sperduto, il giorno di Natale del 2013, Emile Ouamouno, un anno di età, si ammalò, diventando noto come il paziente zero agli epidemiologi che mesi dopo sarebbero accorsi in Africa occidentale. Dopo appena tre giorni di diarrea, vomito e febbre il piccolo organismo soccombette al virus ed Emile morì. Da lì a poco la madre, la sorella, la bisnonna e molti vicini del villaggio seguirono la stessa sorte del paziente zero, dando il via a due anni di contagio da Ebola, che da Meliandou varcò le frontiere di Liberia e Sierra Leone.
La situazione di estrema miseria in cui viveva la famiglia Ouamouno non era e non è tuttora un caso isolato rispetto allo standard delle altre zone in cui dilagò il virus. “Dopo anni di guerra civile” racconta Pulvirenti “il governo della Sierra Leone ha ceduto i diritti di estrazione mineraria e ha concesso la deforestazione” a multinazionali nord americane, europee e cinesi. Purtroppo un copione letto e riletto in Africa. Non è stata quindi una sorpresa quando la mappa su cui erano riportate le zone a più alto tasso di deforestazione dell'Africa occidentale si è sovrapposta perfettamente alle aree in cui spuntavano come funghi i focolai di Ebola: il virus è una zoonosi e quindi si sposta da animale ad animale (soprattutto pipistrelli). Abbattere gli alberi che fungono da habitat naturale inevitabilmente caccia via la fauna locale, che migra entrando in contatto con l'uomo: è questa una delle ipotesi più accreditate per il contagio di Emile Ouamouno. Pulvirenti ricorda con un sorriso amaro ed un sospiro sconsolato che le aziende straniere pagano le concessioni statali per lo sfruttamento del territorio con la realizzazione di infrastrutture, che nella quasi totalità dei casi sono esclusivamente strade. Utili per il trasporto su gomma di tronchi di albero e di minerali preziosi, superflui per garantire quel minimo di standard di igiene pubblica necessario a limitare la diffusione di Ebola. Il virus usa come ponti per il contagio uomo-uomo il sudore che prova ad abbassare la temperatura corporea, il vomito continuo, la diarrea che disidrata un organismo contagiato. Acquedotti per l'acqua pulita in casa e fognature per il reflusso delle acque nere avrebbero dato una chance in più ai paesani deceduti di Meliandou: di sicuro catrame e cemento non sono serviti in tal senso.
Anche chi dal nord del mondo andò con le migliori intenzioni per aiutare i contagiati dovette scontrarsi con la scarsa collaborazione della popolazione locale, oltre che con lo sfruttamento incontrollato e con la povertà dilagante. Tra gli indigeni ci sono numerosi musulmani e pure una fitta comunità cristiana, ma tutti, indipendentemente da fede o credo, sono animisti. Esserlo significa seguire con ligia liturgia rituali che rinsaldano e uniscono i membri di una comunità ma che sono un grosso ostacolo per i medici che, di villaggio in villaggio, spesso dopo ore di viaggio, si spostano a spiegare le basilari procedure di sicurezza per prevenire un contagio. Perfino Gino Strada, fondatore di Emergency, racconta lo stupore, la diffidenza e in alcuni casi l'ostilità degli abitanti della Sierra Leone quando veniva loro spiegato di non toccare il corpo del figlio, quello del marito o della moglie o ancora quello di un amico ucciso dal virus. I rituali del lavaggio del cadavere da parte della famiglia e di danze funebri dei compaesani attorno alla salma sono da un lato l'incubo di ogni epidemiologo che vede in questo ultimo saluto una temibile occasione per la diffusione del virus, ma dall'altro sono usanze animiste sedimentate in millenni, difficili se non impossibili da stravolgere dal raziocinio scientifico occidentale. Solo coinvolgendo attivamente volontari liberiani, sierraleonesi e guineiani, preferibilmente capi spirituali e figure di riferimento per una comunità, piano piano si sono diffusi per i villaggi, nei supermercati, nei bagni pubblici i catini blu di acqua clorata per disinfettare la pelle.
Infettivologi, infermieri e personale di supporto logistico, per quanto ben equipaggiati, finanziati ed integrati nella comunità locale, devono comunque superare il vero e proprio cimento per cui sono andati in Africa: curare il paziente infetto. Non esiste una vera e propria terapia per debellare il virus dall'organismo, al di là del tentativo di far guadagnare giorni al malato aspettando e sperando che il suo sistema immunitario monti in tempo una riposta contro Ebola. Questo richiede soldi e personale preparato. Al “Lazzaro Spallanzani” in terapia intensiva, il dottor Pulvirenti fu seguito e curato con successo da circa 30 professionisti della sanità, protetti dal rischio infezioni dagli speciali dispositivi di sicurezza di cui erano dotati, ricevette farmaci sperimentali costosi (come le fiale degli anticorpi monoclonali ZMAb, circa 3.000 dollari a fiala, prodotte dalla canadese Defyrus), fu costantemente idratato con un accesso venoso e quando la situazione si fece più critica venne intubato. A Lakka, nel centro di Emergency, dentro a tendoni di plastica con la temperatura a 45 gradi centigradi, i medici entravano con addosso tute di gomma arancioni, guanti alle mani, una visiera protettiva, sfidando il rischio di un colpo di calore che aumentava di minuto in minuto. Cinque medici dovevano prestare assistenza fino a trenta pazienti e la possibilità di praticare un accesso venoso per una flebo, terapia data per ovvia in qualsiasi struttura ospedaliera occidentale, era tutt'altro che scontata. Ancor meno la possibilità di assistere la respirazione con un tubo in trachea. Farmaci come lo ZMAb sono fuori dalla portata dei prosciugati budget della sanità africana e le poche fiale a disposizione sarebbero state in numero del tutto insufficiente per limitare l'epidemia. Gino Strada e Roberto Satolli raccontano nel libro “Zona rossa”, edito da Feltrinelli nel 2015, che nelle riunioni tra OMS e le varie realtà delle Ong, terapie banali come l'idratazione per endovena erano fortemente ostacolate perché definite “troppo invasive”. Dalle righe dei resoconti di Strada e Satolli emerge il rammarico nel constatare che da questi incontri non erano proposte soluzioni per i malati africani, ma un uso del tutto iniquo e poco scientifico della medicina: “Per nessuno di loro è stato fatto tutto questo”, dice Pulvirenti. Dove con “loro” intende gli uomini, le donne, i bambini, gli anziani della Sierra Leone contagiati da Ebola e con “tutto questo” le risorse e la dedizione che ha ricevuto egli stesso per la medesima infezione qualche parallelo più a nord.
Tommaso Vezzaro