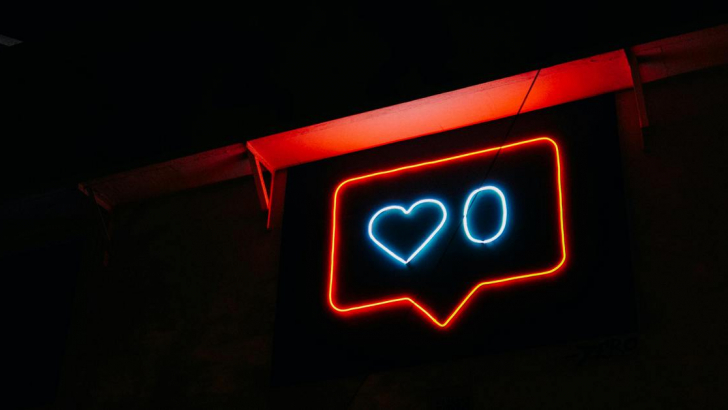SOCIETÀ
Il grande inganno della like-philosophy

Il 15 settembre scorso, Mark Zuckerberg, Ceo e fondatore di Facebook, ha annunciato che la piattaforma avrà finalmente un tasto “non mi piace”, ma, ha subito aggiunto, si tratterà di “qualcosa di positivo, e non di un mezzo per denigrare i post degli altri”. Subito placati, quindi, gli entusiasmi di chi sperava in una evoluzione dialogica del mezzo che permettesse, ad esempio, di allontanare dal newsfeed le bufale, la cattiva informazione, il razzismo, l'apologia di fascismo, l'hate speech in ogni sua forma, la pubblicità ingannevole o sessista.
Grazie a questo microscopico mutamento, l'utente avrà invece in mano uno strumento aggiuntivo per esprimere un “mi dispiace per quanto è avvenuto”. Non si andrà insomma ad intaccare la like-philosophy su cui si regge la piattaforma, ma, al contrario, si offrirà un ulteriore mezzo tecnico per esprimere una più o meno disimpegnata e disinteressata vicinanza umana a un amico, un conoscente o un collega, che vive una situazione di difficoltà. Zuckerberg ha parlato impropriamente di empatia, una emozione che, secondo le definizioni date in psicologia e in sociologia delle emozioni, richiederebbe piuttosto la connessione e l'internalizzazione dei sentimenti altrui.
Ai nostri occhi, invece, il dislike button assolverà a un compito minimo, ma cruciale: la funzione sistemica di “consolazione dello sconfitto”. Ne parlava già Erving Goffman in un saggio poco conosciuto, scritto all'inizio degli anni Cinquanta, che si intitola, per l'appunto On cooling the mark out. Narra, con estremo distacco emotivo, degli artifizi cinici che si adoperano per far digerire agli individui un licenziamento, un abbandono relazionale, la perdita di un famigliare, o una sconfitta di altro genere. Senza alcun dubbio, Facebook è lo strumento che meglio realizza quel modello occidentale di ordine dell'interazione che si basa sul tatto, sul salvataggio pubblico della “faccia”, sulla deferenza affettata, di cui a lungo lo stesso Goffman si è occupato. Ma è anche lo strumento che più si avvicina al modello psicoanalitico del narcisismo: l'associazione, potenziale, fra una concezione del sé sproporzionata e una mancanza di intimità nelle relazioni interpersonali. Chiaramente non tutti gli utenti accettano passivamente la saturazione del sé a cui la piattaforma sottopone, e ognuno piega la presentazione del sé agli usi e benefici personali che possono derivarne dall'uso.
È problematico, invece, affermare che Facebook realizzi al meglio le capacità dialogiche, che pure il mezzo potrebbe avere. Secondo una ricerca condotta da GovFaces nel 2014, il 90% della comunicazione politica sui social network si approssima più al modello del broadcasting, one-to-many, che non a quello dell'interazione one-to-one; un altro studio condotto dal Pew Internet Research rivela come solo il 14% degli utenti americani di Facebook e Twitter accetterebbe di discutere online del caso Snowden, un tema potenzialmente soggetto sia a censura legale, che a feedback negativi da parte degli altri utenti. Infine, si registra una tendenza sempre più marcata al flaming nei commenti online a notizie di cronaca che riguardano categorie sensibili, dagli immigrati, alle donne, agli omosessuali. Ciò è chiaramente dovuto ai costi e all'opportunità della moderazione di commenti capaci di generare sia un preoccupante revanchismo xenofobo, che un traffico internet economicamente proficuo per gli inserzionisti.
E qui veniamo al punto fondamentale della questione: non introdurre la possibilità di una piena discordanza non limiterà il cyberbullismo, come invece dichiarano a Menlo Park, ma continuerà a garantire il modello algoritmico su cui basa il business commerciale della piattaforma. Il cyberbullismo, del resto, è un fenomeno già diffuso su Facebook e su molte altre piattaforme, che amplificano i campi di vulnerabilità a cui sono soggette le personalità più deboli. Introdurre un tasto di vera e propria disapprovazione dei contenuti – come avviene ad esempio su Youtube – vorrebbe piuttosto dire mettere a repentaglio le inserzioni pubblicitarie e contraddire il meccanismo che produce quella schiavitù dai like che, seppur in proporzioni diverse da soggetto a soggetto, colpisce ogni utente della piattaforma.
Per volumi di interazione e per facilità di utilizzo, Facebook è diventato di fatto la prima fonte di autostima, soprattutto per gli utenti più giovani. È utilizzato quotidianamente da oltre 900 milioni di utenti, e per molti di loro la distinzione fra interazioni offline ed online è puramente formale. Questo comporta due fenomeni omologhi, ma opposti: la già citata tendenza all'autocensura, e la ricerca dell'hype, della grande approvazione tramite i like. Timidezza ed estroversione non solo poli oppositivi, ma assi che si intersecano nella presentazione del sé. Si ricercano perciò le manifestazioni di maggior successo potenziale, e si finisce, inevitabilmente per approssimarsi al modello di “persone normali” che la rete si attende.
In altre parole, il soggetto adatta la narrazione del sé a modelli identitari che percepisce come vincenti: l'autoaffermazione, il giovanilismo, il consumismo, il cosmopolitismo, la seduzione, la celebrazione del tempo libero, il rifiuto delle forme di stabilità relazionale tradizionali. Ciò incide sulla sua socialità, sul capitale sociale che riesce ad ottenere, sui modi in cui si comunica e ci si associa. A chi conviene in fondo uscire dal grande inganno della like-philosophy? Di certo, non a Facebook.
Vincenzo Romania