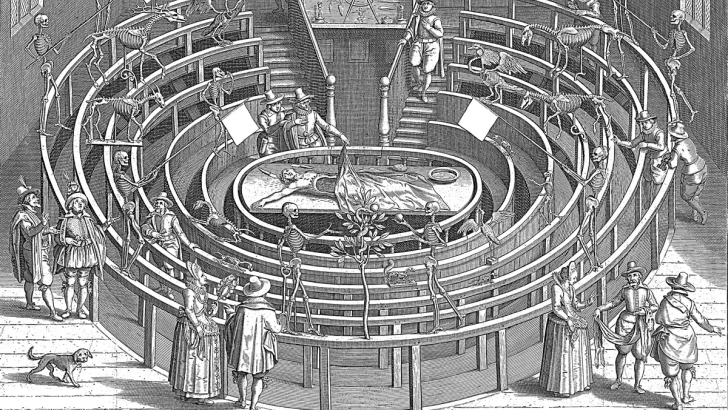Ogni libreria dei libri “di scienza” dovrebbe avere uno scaffale apposta per i libri che mescolano verità e fiction, che sfumano la saggistica nel racconto e viceversa, che sanno usare la scienza come materiale narrativo, rispettandola ma anche valorizzandola con qualche colpo di fantasia. Tra i loro numerosi pregi c’è quello di mostrare quanta umanità stia nelle cose, anche in quelle che ci ostiniamo a considerare dominio esclusivo della razionalità, e come sia possibile colmare i gap cognitivi che tutti, da qualche parte, abbiamo, usando un po’ della nostra naturale immaginazione.
Che poi, a pensarci bene, non sono mica rarità: certe storie di Gianni Rodari a base di viaggi spaziali, scritte quando quella era davvero scienza di frontiera, hanno segnato la strada. Né sono testi per pubblici piccoli, si pensi al sontuoso “Quando abbiamo smesso di capire il mondo” di Benjamin Labatut (Adelphi) che è stato tradotto in un sacco di lingue, e romanza la vita degli scienziati del Novecento che hanno cambiato la nostra lettura della realtà. Infine, non sono nemmeno libri così distanti dall’accademia, se pensiamo a una delle ultime fatiche di Telmo Pievani, la sua immaginifica “Finitudine”: un romanzo (definito così nel sottotitolo, con l’aggiunta di “filosofico”) che racconta un dialogo possibile, ma mai avvenuto, tra lo scrittore Albert Camus e il biologo Jacques Monod.
Tra questi libri va messo “Altro nulla da segnalare” di Francesca Valente, uscito per Einaudi nella collana Unici, e vincitore del Premio Italo Calvino 2021. Anche qui si parte da frammenti di realtà e si costruiscono storie probabili, solo che qui non stiamo giocando coi pensieri dei grandi intellettuali ma coi gesti e le azioni di uomini e donne pazienti di un servizio psichiatrico. Qui ci sono persone indicate per cognome, definite i “paz” ma solo come abbreviazione di “paziente”, alle prese con una libertà che forse non sanno gestire, e raccontati dai rapporti che gli operatori del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale Mauriziano di Torino lasciano a fine turno ai colleghi che li seguiranno.
In questi rapportini, autentici, raccolti da uno psichiatra al lavoro in quegli anni e consegnati da lui personalmente alla scrittrice, si trova il “paz.” che si è presentato con un calice di champagne “pieno di urina invece che di champagne” e poco sotto l’indicazione: “mancano le luci in cesso”. Quello che viene “dimesso a se stesso”, e l’altra che “tutta isterica, continua a non avere un comportamento molto igienico”. Il “sig.” che si affaccia al reparto, chiede chi faccia la notte, e avuto la risposta “a salutato ed e andato via” (sic), e l’infermiere che annota: “i certificati elettorali sono nell’armadietto stupefacenti”. E infine, quasi sempre, “altro nulla da segnalare”.
Siamo nei primi anni ottanta, e i “paz” sono quelli che la legge 180 ha liberato dai manicomi. Lo psichiatra, invece, si chiama Luciano Sorrentino: la sua storia comincia a Torino in una famiglia emigrata dal sud e lo porta negli Stati Uniti. Lì lo vede avvicinarsi, ragazzo, ai temi della deistituzionalizzazione del malato e alla critica del modello psichiatrico dominante. E poi il ritorno in Italia (anche per evitare di partire soldato in Vietnam), Basaglia e l’ospedale Mauriziano dove si trovava uno dei primi “reparti aperti” d’Italia. Infine il paziente Carlo, la sua avventura di attore, e una fotografia che li immortala, il medico e il malato, più simili nell’anima di quanto siamo pronti a pensare. Così anche le storie degli altri, alla fine sono piccole fotografie di un passato recente, e assomigliano alle tante che abbiamo sempre sentito: quelle dei “paz.” che ci siamo abituati a chiamare “sig.” e che sono parte della nostra umanità.