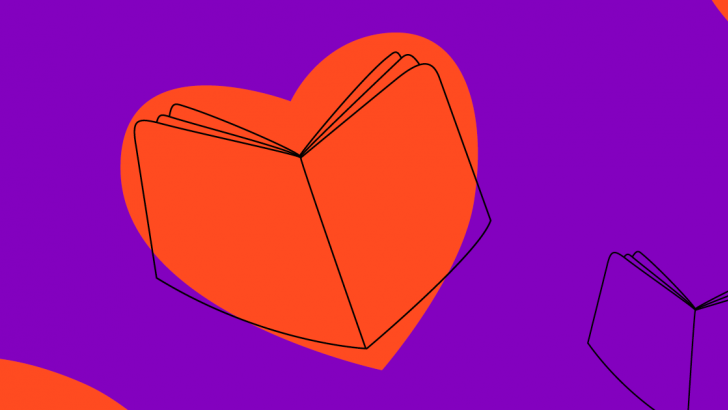Rosella Postorino vince il Premio Campiello con "Le assaggiatrici"

Rosella Postorino, classe 1978, scrittrice ed editor, vince la 56esima edizione del Premio Campiello con il romanzo Le assaggiatrici (Feltrinellii 2018, 285 pagine). L’abbiamo intervistata.
Come ti è venuta l’idea di raccontare la storia di un’assaggiatrice di Hitler?
Mi è venuta perché nel settembre 2014 mi sono imbattuta in un trafiletto sul giornale che parlava proprio di un’assaggiatrice di Hitler: una signora di 96 anni di nome Margot Wölk, berlinese, che dopo aver taciuto per tutta la vita la sua esperienza, per la prima volta confessava che da giovane aveva assaggiato i pasti destinati al Führer per accertarsi, sulla propria pelle, insieme ad altre donne, che questi non fossero avvelenati. L’idea quindi mi è venuta da una testimonianza vera, di una donna, che mi ha folgorata, perché mi sono trovata di fronte a una persona che, per questioni di sopravvivenza ‒ perché era affamata dalla guerra, perché era da sola, perché la sua casa era stata bombardata ‒, non per fanatismo politico, si era trovata a lavorare per il Führer. E cercava di sopravvivere rischiando tre volte al giorno di morire: questo la rendeva contemporaneamente vittima e colpevole ed era questa condizione esistenziale che mi ha fatto interessare a lei, che mi ha spinta a scrivere il romanzo.
Come hai fatto ad immedesimarti in un personaggio per certi tratti così estremo?
Ma sai, io non penso che sia estremo, è questo il punto. Nel momento in cui ho letto la storia di Margot Wölk, ho sentito che mi riguardava. La stranezza può sembrare proprio questa: ho sentito che questa storia riguardava me, che riguardava qualunque essere umano, perché qualunque essere umano è in una condizione estrema.
“ La stranezza può sembrare proprio questa: ho sentito che questa storia riguardava me, che riguardava qualunque essere umano
Ecco: la condizione è estrema, non il personaggio che ci si trova. Qualunque essere umano in condizioni limite può arrivare a compiere dei gesti che in situazioni normali non compirebbe. Primo Levi ne I sommersi e i salvati diceva: “Nessuno di noi può sapere come si comporterà in una situazione estrema”. Peraltro la lettura di moltissimi breviari, mémoires e romanzi legati al periodo della Seconda Guerra Mondiale mi ha fatto capire quanto le persone siano disposte a fare in situazioni di necessità, di privazione totale, per sopravvivere.
Quindi mi sono immedesimata nella protagonista perché mi sono domandata cosa avrei fatto io al suo posto, e me lo sono chiesta togliendomi il pregiudizio dell'eroe. È molto facile, a distanza, dire: “Io, in quella situazione, piuttosto che mangiare il cibo di Hitler sicuramente sarei morto di fame, mi sarei ammazzato, sarei scappato rischiando di essere fucilato”. Insomma, è molto facile, senza trovarsi nelle cose, pensare che la nostra reazione sarebbe stata quella eroica. È molto più attendibile invece, immaginare ‒ anche leggendo, ripeto, documentazioni, libri, diari e lettere che riguardano quell'epoca ‒ che le persone provino a sfangarla come possono, erodendo ogni volta un pezzetto della propria dignità. La guerra fa questo: non solo ti priva, ti fa perdere continuamente persone care, la tua casa ecc., ma ti toglie progressivamente la tua dignità, e la tua umanità. Il tema è: come si fa a restare umani dentro una situazione disumana come la guerra?
Rosa Sauer, la protagonista, ha una relazione adulterina con il tenente Ziegler, il comandante del campo, e in qualche modo quindi tradisce due volte perché fa l'assaggiatrice di Hitler e si innamora di un uomo della sua squadra. Questo secondo aspetto ti interessava in particolare? O l'hai inserito perché drammaturgicamente funzionava?
Funzionava benissimo, perché la colpa di Rosa di assaggiare il cibo di Hitler è una colpa accidentale, non è legata a una scelta. Lei semplicemente va a rifugiarsi nella casa dei suoceri, a Gross-Partsch, nella Prussia orientale, un paesino a soli 3 km dalla “Tana del lupo”, il quartier generale di Hitler, la cosiddetta città bunker, e a una settimana dal suo arrivo viene reclutata dalle SS alle quali non può dire di no ‒ o comunque dire no sarebbe molto complicato perché darebbe luogo a una serie di altri problemi.
Invece la sua relazione con Ziegler è il frutto di una scelta, che lei avrebbe potuto non fare. È vero che il desiderio è qualcosa che irrompe nelle nostre vite, in qualche modo è una “frattura nella logica dell'universo”, come direbbe Marguerite Duras, però allo stesso tempo è chiaro che il nostro comportamento potrebbe portare al non aderirvi. Quando invece lei lo fa, le sembra di essere consenziente al volere di un altro, al suo potere, perché il tenente è colui che dirige la caserma e lei pensa di non poter fare altro che consegnarsi al boia. D’altra parte però, nel momento in cui lei e quell’uomo si incontrano, smettono di essere il loro ruolo e tornano ad essere persone singole e irriducibili e irripetibili.
Il desiderio mette in scena un Io e un Tu: lei torna ad essere una donna e lui ritorna a essere un uomo, e, dentro questa loro relazione ‒ che è per certi versi abietta e comunque una relazione clandestina, in cui lei sta desiderando il corpo di un uomo nazista e di questo si vergogna, non solo davanti al marito, ai suoceri, ai compagni, ma anche all’idea del padre che era un antinazista ‒ c’è comunque una forma di ribellione, di resistenza al Terzo Reich che vuole ridurre ciascun essere umano a un ingranaggio di un sistema. Loro, in quel momento, è come se tradissero proprio il Terzo Reich.
Il rapporto tra le assaggiatrici com'è? Tra di loro, voglio dire.
Il rapporto che io ho immaginato è come qualunque rapporto che può nascere dentro un luogo in cui ci si vede tutti i giorni senza averlo scelto. Voglio dire, anche a scuola vedevi tutti i giorni i tuoi compagni di classe senza averli scelti e a un certo punto instauravi con alcuni dei rapporti più profondi, o comunque una simpatia maggiore, con altri meno, ad alcuni eri più vicino, ad altri no: in ogni caso qui siamo in una situazione in cui la protagonista vede tutti i giorni le persone con cui rischia di morire. La dimensione della caserma è esattamente come il carcere e loro è come fossero un po' delle detenute, un po' delle schiave, ma sono anche delle giovani donne che non possono non legarsi tra loro visto che tutti i giorni affrontano la morte, e la superano insieme.
È chiaro che vivono in una condizione di coercizione, di paranoia, perché possono morire da un momento all’altro, e quindi in una condizione di sospetto, che viene all’origine determinata dal Führer che prova un senso di minaccia, ha paura di poter essere avvelenato. Le assaggiatrici sono delle persone che non sanno veramente se si possono fidare del prossimo e quindi fra di loro sviluppano dei rapporti di solidarietà. A volte però questi rapporti, anche i più profondi, sono in qualche modo minati da un segreto, da una reticenza, da una forma di sospetto, da una diffidenza. C'è una rinegoziazione continua della fiducia, che non è mai data per definitiva. Quindi credo che loro ricreino quelle che sono le dinamiche della società: provano in qualche modo, dentro quell’orrore, a ristabilire un microcosmo di normalità. La caduta di Antony Beevor racconta di una signora che, chiusa in un rifugio antiaereo, tutte le mattine alle otto si apre sulle ginocchia uno strofinaccio e su quello prepara una fetta biscottata con la marmellata per il figlio. Crea una routine, crea un’abitudine dentro l’orrore.
C’è una frase, un verso di Jorge Luis Borges che dice: “L'abitudine che ci aiuta a sentirci immortali”. Quindi ricreare la normalità nella tragedia è proprio un bisogno umano, altrimenti non ce la si farebbe a sopportarlo. Le assaggiatrici provano a farlo, dopodiché però sono in una situazione estrema, quindi anche questa normalità è ovviamente inficiata dal fatto che si sentono continuamente minacciate, e questo ovviamente condiziona le loro relazioni.
“ Ricreare la normalità nella tragedia è proprio un bisogno umano, altrimenti non ce la si farebbe a sopportarlo
Dal punto di vista stilistico che lingua hai scelto per raccontare questa storia?
Questo aspetto è quello su cui mi sono concentrata di più. Intanto avevo deciso di raccontare la storia in prima persona, cioè di provare a immergermi nella testa di una donna che aveva 26 anni nel ‘43, quindi molto lontana da me. Il punto era questo: che la storia doveva essere raccontata da un tempo in cui si sapesse che cosa era stato il Terzo Reich in maniera esaustiva, inequivocabile. La voce narrante, cioè, non doveva avere alibi, non poteva dire: “No, non sapevo che...”, perché doveva essere conscia della propria condizione di colpevolezza, sebbene accidentale, o frutto di una non-scelta ‒ ma in certi periodi storici non scegliere è già scegliere. Nello stesso tempo però non doveva essere una voce giudicante, perché volevo che questi eventi che Rosa Sauer attraversava fossero raccontati come se fossero in presa diretta, perché il lettore mentre legge deve sentirsi lì, assieme al personaggio, perché deve provare a vivere quello che aveva visto lei, per tentare di capire le sue ragioni, per quanto discutibili.
Non avrebbe avuto nessun senso una voce giudicante tout-court, sarebbe stato solo un atto ideologico, ma la letteratura è un'altra cosa: è un’indagine sull’umano e sulla complessità delle scelte, sulla loro ambivalenza. Quello su cui mi sono focalizzata è stato quindi avere una voce consapevole ma nello stesso tempo che riuscisse ad essere dentro gli eventi in modo tale da non creare un diaframma di giudizio, e capace di far sentire il lettore esattamente lì dov’era la protagonista, per vivere le cose assieme a lei.