Il diritto di esser (e dichiararsi) gelosi
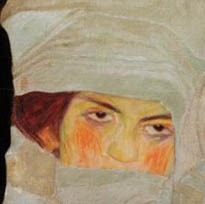
Nell’Otello di Shakespeare viene descritta come “un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre”. Una passione inconfessabile, imbarazzante e assai pericolosa. Ma quanti di noi possono dire: non ho mai provato gelosia? E quanti invece hanno avuto il coraggio di confessarla? Di parlarne liberamente, senza censure? Ci hanno insegnato che la gelosia è una sciagura d’amore, un mostro da sconfiggere. Sei troppo possessiva, troppo insicura. Sforzati di nascondere questa passione, non ti accorgi di esserti spinta al limite della trivialità? A riabilitarne il ruolo, a riconsegnarle dignità e significato nella relazione amorosa è Giulia Sissa, storica della cultura e delle idee, docente all’università della California, Los Angeles (UCLA) e autrice del libro La gelosia (Laterza), recentemente ospite del nostro ateneo, in occasione di un incontro a Palazzo Bo organizzato da Progetto giovani del Comune di Padova.
“Cosa è accaduto, nella nostra esperienza dell’amore, che ci ha portato ad aver vergogna di esprimere quella che è, in primo luogo, una sofferenza? È stato sempre tanto indecoroso affermare la propria dignità erotica? Duelli non se ne fanno più, il delitto d’onore è stato abolito, l’adulterio non è più così grave, la seduzione viene ostentata, il desiderio circola liberamente: tutte cose meravigliose. Ma, in questo godimento disinvolto e multiforme, i gelosi e, soprattutto, le gelose sono soli”. Per Sissa, la gelosia non deve subire censura. “Basta con il biasimo, è necessario riconoscerla come sofferenza. Nulla di eroico nel non confessarla, anzi, dichiararla può avere un effetto catartico, permettendo ad altro di accadere. Dire la gelosia può essere un modo per ristabilire l’uguaglianza in una relazione”. Ci spiegano come curare questa figlia malata dell’insicurezza, “passione cattiva, meschina, diffidente, sgradevole, sinistra e amara”, ma il punto è: chi può dirsi davvero sicuro? Non ci sentiamo forse ansiosi e incerti in tutti gli aspetti della quotidianità? L’insicurezza non è forse una condizione umana. Proviamo vergogna perché ci fanno vergognare, temiamo di essere giudicati ridicoli e fare brutta figura. E allora ce ne stiamo zitti, la nascondiamo, fingiamo indifferenza perché “non abbiamo la forza di sopportare le osservazioni crudeli, i consigli condiscendenti e i sorrisetti”. La vergogna è un’emozione sociale. Riconoscere la propria gelosia significa accettare la sfida e rifiutare di farsi intimidire.
Quando non è patologia (e questo è un altro discorso) la gelosia è normale, lo diceva anche Freud, definendola competitiva, e “non perché siamo banalmente meschini, ma perché l’amore e il desiderio di cui costituiamo l’oggetto ci distinguono dagli altri, ci mettono in evidenza, ci esaltano. L’amore ci individualizza. Di più: il nostro desiderio si rivolge al desiderio dell’altro. L’amore invoca reciprocità. E siccome l’esperienza erotica è l’esatto opposto di un’appropriazione, arrogante e definitiva, e non cessa di inquietarci, la gelosia è l’esatto opposto di quello che se ne è voluto pensare in una tradizione che ne reitera il biasimo. La gelosia, dunque, è l’amore. Il nostro amore rende l’oggetto amato talmente meraviglioso e degno del più alto interesse che è del tutto logico per noi pensare che anche altri lo vedano sotto la stessa luce. Dal momento che, col pensiero, moltiplichiamo le occasioni di felicità in compagnia dell’individuo che abbiamo divinizzato, ci è del tutto naturale immaginare un altro, un’altra, al posto nostro e nelle stesse situazioni. E gli altri esistono”.
Dalla tragedia di Medea, furibonda per il tradimento di Giasone, passando all’Arte di amare di Ovidio. E poi Stendhal (la cui intuizione più affascinante “è quella di cristallizzazione – aggiunge Sissa - vale a dire la trasfigurazione immediata e improvvisa che ci fa vedere la persona sulla quale, casualmente, si appunta il nostro desiderio come una persona brillantissima ed eccezionale”), Proust, Freud. Tutti d’accordo nel dire che “il potere idealizzante dell’ammirazione innesca un gioco di specchi. Perché nella prima cristallizzazione, malgrado l’entusiasmo, si è ancora distratti, ed è solo con il sopravvenire dei primi dubbi sul desiderio dell’altro che un innamorato è indotto ad intensificare il proprio amore”. Vacilla la speranza di reciprocità, non sono più così certo che l’altro ricambi “e il suo desiderio è ormai un problema”.
La gelosia è stata ampiamente indagata, ha attraversato le epoche svelandosi, secondo Sissa, nel disperato tentativo di “durare nell’amore nonostante l’altro si sia distratto”. Se nella Grecia antica, la passione di Medea veniva descritta come la collera erotica di una donna tradita, sofferente ed eroica, come “punto d’onore delle donne gelose di stampo antico” (escludendo, ovviamente, la violenza nei confronti dei figli, gesto estremo da condannare senza esitazioni), la Medea di Seneca è invece pura crudeltà, nulla di lei e della sua malsana passione viene compreso o salvato. È quest’ultima la visione degli stoici, che ribalta il punto di vista e condanna l’ingestibile tormento.
Facendo un viaggio nel tempo, si scopre che quel che per gli antichi era un’onta da lavare e per gli innamorati moderni uno smacco inconfessabile in una competizione di tipo agonistico, ora è diventato addirittura un errore politico. Spiega Sissa: “Alla proibizione di rivelarsi gelosi si è aggiunta quella di esserlo, raddoppiata dall’ingiunzione di ascoltare le confessioni dei nostri amanti. La gelosia è politicamente scorretta. È l’emozione più oscena che esista. Oggi, tra libri, blog e siti web, ci viene detto che la gelosia rivela una forma di insicurezza, un bisogno di validazione, una follia a due. Tutte le illusioni di una certa idea di individuo indipendente, fiducioso di sé, gonfio di self-esteem – in breve: arrogante – si riuniscono negli stereotipi psicologici. Sempre un tono di rimprovero, sempre l’insinuazione che si sta esagerando: se solo tu fossi capace di dare fiducia, se amassi di più te stessa, se non fossi stata gelosa della tua sorellina, se non avessi dei genitori, se, infine, ti ritenessi imbattibile, allora sì saresti perfettamente beata”.
L’imbarazzo della gelosia risiede nel presente. Scriveva La Rochefoucauld in una delle sue Massime: “Ci si vergogna di confessare che si prova gelosia, ma ci si vanta di averne provata e di essere capaci di provarne”. Risulta, dunque, impossibile ammetterla nel momento in cui la si prova; più facile (e accettabile) confessare di averne provata in passato. “Inammissibile al presente, la gelosia diventa encomiabile, perfino onorevole, al passato e al condizionale – spiega Sissa nel suo libro - Ignominiosa e rispettabile; abietta ed eroica; vergognosa sconfitta e sussulto di dignità. L’esperienza delle gelose e dei gelosi cambia col passare del tempo e, soprattutto, nel modo di parlarne. Indicibile nell’immediato; lodevole a distanza di tempo. È qui il suo paradosso”.
Ma cosa ci si dovrebbe vergognare esattamente, oggi? “La gelosia è l’amore, immerso nel mondo dopo che abbiamo puntato l’attenzione, una profonda attenzione, sull’altro nella realtà delle sue relazioni, delle sue abitudini, della sua vita sociale. Perché, anche se ognuno cristallizza a suo modo e per persone diverse, il desiderio indefinito (per dirla con Hobbes) o il sesso fisico (per dirla con Rousseau) fluttuano di continuo e dovunque. I rivali effettivi o potenziali non sono fantasmi, puro prodotto di una allucinazione paranoica, ma sono quel tale uomo che frequenta il salotto della nostra amante o quella tale donna che il nostro amante segue con sguardo sorridente”.
Francesca Boccaletto









