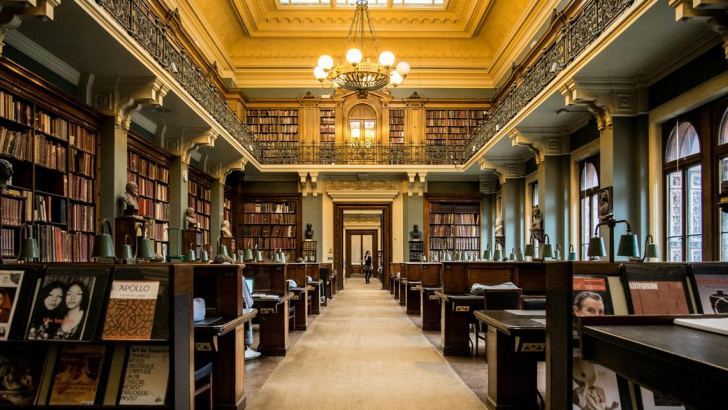Giornata internazionale delle donne nella Scienza: oltre i numeri, verso la collaborazione

Per lungo tempo, il contributo delle donne alla scienza è stato marginalizzato, talvolta nascosto o attribuito ad altri. Figure come Rosalind Franklin, Lise Meitner e molte altre hanno visto i propri meriti riconosciuti solo tardivamente, spesso dopo decenni di oblio e, in alcuni casi, persino dopo la morte. Questa situazione non è solo frutto di pregiudizi storici, ma anche di un sistema che per anni ha reso difficile per le donne accedere agli stessi strumenti e opportunità dei colleghi uomini, e che lo rende difficile anche ai giorni nostri: il panorama è cambiato, ma le sfide non sono scomparse.
Le difficoltà per le donne che lavorano in campo scientifico non si limitano solo alla fase dell’accesso alla carriera, anzi. Il problema sono soprattutto i passaggi successivi, dalla progressione accademica alla leadership nei gruppi di ricerca. Molte scienziate si trovano ancora a dover dimostrare di meritare il proprio posto più dei loro colleghi maschi e faticano a ottenere ruoli di rilievo nei comitati scientifici e a ottenere finanziamenti per le loro ricerche. Sia chiaro, non parliamo solo di problema di giustizia sociale, che meriterebbe comunque il suo spazio, ma di una perdita per tutta la comunità scientifica, che rischia di escludere talenti che potrebbero dare un grande contributo al progresso della conoscenza.
La Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza
L’11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita nel 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di promuovere la piena ed equa partecipazione delle donne e delle ragazze alla scienza. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la disuguaglianza di genere nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) rappresenta un ostacolo per le donne, ma anche per il progresso dell’umanità nel suo complesso: se per un bias dei decisori (o delle decisore, nemmeno le donne sono immuni dai pregiudizi) ai vertici di aziende e istituzioni scientifiche arrivano solo uomini, è lecito pensare che non si stiano scegliendo le persone migliori per quel determinato ruolo, ma solo gli uomini migliori.
Negli anni, questa giornata ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e a incentivare politiche a favore della parità di genere nella ricerca scientifica. Istituzioni accademiche, centri di ricerca e aziende tecnologiche organizzano eventi, conferenze e attività di divulgazione per mettere in luce i successi delle scienziate e ispirare le nuove generazioni, ma non basta. Nonostante questo, come riporta l’UNESCO, le donne rappresentano ancora solo il 33% dei ricercatori a livello globale, e meno del 30% delle studentesse universitarie sceglie corsi di laurea nelle discipline STEM.
Certo, progressi ce ne sono stati, ma i dati dimostrano che c’è ancora molta strada da fare, e che se si procede a questo ritmo potrebbero volerci decine di anni per raggiungere la parità. Per questo motivo, la Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza non deve essere solo una celebrazione simbolica, che si limita a promuovere iniziative, seppur virtuose, che rischiano di rimanere isolate. La cosa più importante, in questo caso, è di rendere possibili cambiamenti strutturali nel mondo accademico e professionale.
Il problema della disparità di genere nella scienza non è solo una questione di numeri, ma di cultura. Il modo in cui la società percepisce il ruolo delle scienziate, la mancanza di modelli di riferimento e la difficoltà di conciliare carriera e vita personale sono tutti fattori che contribuiscono al persistere del divario di genere. Affrontare questi ostacoli richiede un cambiamento profondo, che parte dall’educazione e dalla comunicazione per arrivare alle politiche istituzionali.
She is a Scientist, per affrontare in modo concreto il problema culturale
In Italia tra i progetti che vanno in questa direzione c’è She is a Scientist, fondato nel 2017 con l’idea iniziale di spezzare gli stereotipi visivi legati alle scienziate: “Mi immaginavo – racconta la fondatrice Nicole Ticchi – una campagna pubblicitaria che raccogliesse delle foto di scienziate con il messaggio: 'Questa è una scienziata', e che mostrasse persone molto diverse tra loro, perché spesso si associa il concetto di scienziato a un certo aspetto fisico o a un certo modo di essere, mentre nella realtà chi fa scienza spesso ha un aspetto che molti non si aspettano”.
Nel tempo, She is a Scientist è cresciuto, diventando un’associazione di promozione sociale nel 2021. Oggi collabora con scuole, università e istituzioni per promuovere la cultura scientifica con un approccio inclusivo. “Non si tratta solo di aumentare il numero di donne nella scienza, ma di creare un ambiente in cui chiunque, indipendentemente dal genere, possa esprimere il proprio valore senza doversi conformare a modelli preesistenti” spiega Ticchi.
“ Le donne rappresentano solo il 33% dei ricercatori a livello globale, e meno del 30% delle studentesse universitarie sceglie corsi di laurea nelle discipline STEM
Non una guerra di genere, ma un problema culturale
Quando si parla del ruolo della donna in contesti tradizionalmente riservati agli uomini, si rischia di cadere in un fraintendimento, che è quello che prevede l’opposizione di due generi che si fronteggiano in un campo di battaglia per ottenere un non meglio specificato premio. Forse per alcuni dei membri delle parti in causa la questione sta proprio in questi termini, ma per fortuna molti invece si stanno rendendo conto che gli stessi pregiudizi che danneggiano le donne possono andare a colpire anche gli uomini, perché la mentalità che sta alla base del dualismo esasperato non ammette deroghe (per esempio ad oggi, se un padre italiano volesse stare con il suo bambino appena nato per più di qualche giorno dovrebbe prendere le ferie, e forse il suo capo – o, di nuovo, la sua capa – troverebbe strana la richiesta e i suoi colleghi lo chiamerebbero “mammo”).
“Uno dei problemi principali – conferma Ticchi – è che la questione della parità di genere viene spesso percepita come un tema esclusivamente femminile: molti uomini si sentono esclusi o temono di dire la cosa sbagliata. Ma il punto è proprio questo: finché continueremo a considerarlo un tema settoriale, non faremo progressi reali, il cambiamento deve essere collettivo. La nostra associazione ha sempre cercato di mantenere un approccio costruttivo, evitando derive polarizzanti, perché non vuole essere uno spazio in cui le donne si lamentano degli uomini, ma un luogo in cui cerchiamo soluzioni insieme”.
La rappresentazione mediatica e il problema della leadership
Uno degli aspetti più delicati è la percezione delle scienziate nei media. Secondo Ticchi, c'è ancora un doppio standard: “Quando un uomo parla di scienza, gli si attribuisce automaticamente autorevolezza; una donna, invece, deve prima dimostrare di meritarsela. Questo porta molte scienziate a doversi adattare a modelli di leadership tradizionalmente maschili: alcune adottano toni più assertivi, altre cercano di assumere un aspetto più autorevole, magari vestendosi in modo più formale, ma il vero obiettivo dovrebbe essere costruire un modello alternativo di leadership”.
Non è una mera questione di abbigliamento o stile di eloquio: se una donna trova nell’assertività uno stile comunicativo congeniale, o se preferisce indossare un tailleur maschile perché le piace, è una scelta personale che va rispettata. Il problema nasce quando queste scelte diventano obbligate, quando una scienziata sente di doversi adeguare a certi modelli per essere presa sul serio. Dall’altro lato, se una donna con un piercing al naso e un abbigliamento meno convenzionale ha le competenze per eccellere, non dovrebbe essere penalizzata per la sua immagine, né tantomeno dovrebbe cambiarla.
Questa non vuole essere un’adesione ingenua alle ideologie dei guru dell’empowerment un tanto al chilo: un conto è essere consapevoli che l’apparenza abbia un ruolo importante e che il mondo del lavoro, incluso quello scientifico, non è immune a questi meccanismi, ma ciò non toglie che si possa collaborare per creare qualcosa di diverso: il cambiamento culturale deve andare nella direzione di premiare il merito e le competenze piuttosto che l’aderenza a codici imposti dalla tradizione, e quindi bisogna lavorare per un ambiente in cui il valore di una professionista non sia giudicato partendo da dettagli superficiali, ma solo affidandosi alla qualità del suo lavoro e alla sua capacità di contribuire al progresso scientifico e sociale.
Non è (solo) una questione di numeri
Il problema non riguarda soltanto la scarsa presenza di donne nell’ambiente STEM, perché anche se, per ipotesi ottimistica, si arrivasse in breve tempo a un 50% di presenza femminile nei corsi scientifici rimarrebbe da sciogliere il nodo della presenza femminile nei ruoli decisionali. “Non basta – spiega Ticchi –aumentare il numero di donne nella scienza se poi non arrivano a posizioni di leadership. Bisognerebbe anche andare a vedere quali sono queste posizioni, perché spesso si tratta di ruoli nominali, senza che corrisponda un reale potere decisionale”. Questo ha conseguenze pratiche sul progresso scientifico stesso: “Il problema – aggiunge Ticchi – non si limita solo alle donne, ma a tutte le minoranze sottorappresentate, perché avere gruppi decisionali diversificati porterebbe a soluzioni scientifiche più efficaci che potrebbero conto di una gamma più ampia di esperienze e bisogni”.
Verso il futuro, con ottimismo
Quello che colpisce, ascoltando Ticchi, è il suo ottimismo, in un periodo storico in cui in vari paesi la tendenza è quella di fare passi indietro anche clamorosi sui diritti civili. Nonostante le difficoltà e le resistenze, Ticchi crede fermamente nella possibilità di un cambiamento reale e duraturo. "Se ci fermiamo a vedere solo gli ostacoli – dice – rischiamo di perdere la motivazione, ma se ci concentriamo sulle opportunità e su ciò che possiamo fare concretamente, allora abbiamo una direzione chiara che porterà dei risultati".
Essere ottimisti non significa ignorare le difficoltà, ma affrontarle con la consapevolezza che ogni piccolo passo avanti conta. La parità di genere nella scienza non si raggiungerà dall'oggi al domani, ma con un impegno costante nel tempo. Per questo, è fondamentale che iniziative come She is a Scientist continuino a crescere e a ispirare nuove generazioni di scienziate e scienziati.
Guardando avanti, Ticchi ha le idee chiare su come affrontare la questione: “Stiamo lavorando per portare un’educazione scientifica più equa nelle scuole, non solo per insegnare le STEM, ma per far capire ai ragazzi che la scienza è un percorso aperto a tutte le persone”. L’associazione sta lavorando per garantire queste opportunità anche a scuole con meno risorse: “Non vogliamo che siano solo le scuole più attrezzate a poter accedere a percorsi di formazione avanzati, perché l’equità si costruisce dalle basi”.
La Giornata delle donne nella scienza non è una mera ricorrenza simbolica, ma un’opportunità concreta per continuare a promuovere cambiamenti strutturali nella nostra società, non solo un giorno all’anno, per costruire una cultura scientifica più inclusiva, che superi la dicotomia tra scienza e umanesimo e che valorizzi il pensiero critico e l’etica accanto alle competenze tecniche. Una cultura scientifica che sia per tutte le persone, a prescindere da genere, nazionalità, orientamento sessuale e possibilità economiche, un passo alla volta e senza farsi scoraggiare da quelli che camminano in un’altra direzione.