Nadia Urbinati: “La democrazia non può sopravvivere alla povertà di massa”
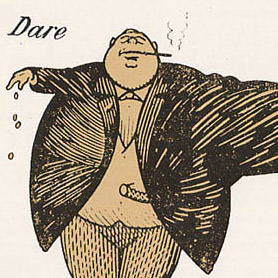
La narrazione canonica che viene trasmessa nelle università occidentali parla di due modelli di costruzione dei sistemi sociali e politici: uno inclusivo e aperto e uno estrattivo e chiuso. Il primo corrisponde grosso modo alle democrazie capitalistiche occidentali (ovvero al loro mito, si dovrebbe aggiungere) ed è basato sul principio della diffusione del potere politico e della sicurezza dei diritti individuali fondamentali. Questo modello si sorregge sull’idea che sguinzagliando le potenzialità e le opportunità su tutto il bacino della popolazione, ciascun cittadino avrà più possibilità di innovare e creare, e ciò renderà l’intero sistema più dinamico. Nell’altro modello, che oggi grosso modo corrisponde al capitalismo cinese, la logica che tiene il paese è estrattiva delle risorse ed esclusivista, ovvero accumula in verticale e punta a riprodurre un’oligarchia forte che ha tutto l’interesse a restare coesa per dominare chi sta sotto.
Gli economisti e gli scienziati politici occidentali, non solo americani, ritengono che per sostenere il modello inclusivo sia fondamentale favorire la crescita economica e in particolare stimolare l’innovazione, la quale avviene distruggendo quel che c’era sostituendolo con prodotti più efficienti o adatti. “Distruzione creativa” è il termine reso celebre da Joseph Schumpeter e usato per designare questa fatica di Sisifo che senza posa crea-distrugge-e-crea. Poiché non ci può essere crescita illimitata (e la dottrina del liberalismo economico comprende solo la crescita) occorre ricreare sempre le condizioni della crescita. Qualche volta le guerre aiutano, altre volte occorre imitare l’azione demolitrice dei campi di battaglia ad arte. Per rendere possibile Il vero problema delle democrazie capitalistiche è dunque l’aumento vertiginoso della diseguaglianza economica poiché questa si traduce celermente in diseguaglianza politica: che è la premessa all’inversione del modello da inclusivo a estrattivo. Perché chi ha più potere economico investe nella politica, usando i media per influenzare l’elettorato e i soldi e la promessa di privilegi per portare rappresentanti amici in parlamento, e fare passare le leggi che più aiutano o meno danneggiano i propri interessi. Più potere economico, più potere di voce, più potere di influenza, più potere politico. Il declino della democrazia sta scritto qui. la distruzione creativa in tempi di pace, la società deve essere orizzontale e aperta a tutti poiché da ciascuno può prendere quel che meglio serve a tenerla in moto innovativo. Questa visione, che rassomiglia al mito della prateria, che sposta sempre oltre il confine del possibile e dello sfruttabile, ha sedimentato l’ideologia della democrazia capitalistica e giustificato la sua esportazione nel mondo. L’idea centrale è che le disfunzioni (i paesi che non crescono) sono la conseguenza di sistemi istituzionali, economici e politici, che non sguinzagliano potenzialità e non sostengono la distruzione creativa. È un po’ come la traduzione mondana della parabola evangelica della moltiplicazione dei pani e dei pesci. La forza moltiplicatrice dello spirito imprenditoriale e dell’individualismo creativo sarebbe alla base del benessere e della giustizia. Questo è il credo liberal-liberista.
Ma anche i più devoti nella credenza di questa fede dovrebbero avvedersi che il sistema regge a un patto: che appunto sia e resti inclusivo per davvero, e non solo per illusione o mito. Ovvero che non ci sia tanta diseguaglianza da rendere l’impegno individuale futile in partenza. Il vero problema delle democrazie capitalistiche è dunque l’aumento vertiginoso della diseguaglianza economica poiché questa si traduce celermente in diseguaglianza politica: che è la premessa all’inversione del modello da inclusivo a estrattivo. Perché chi ha più potere economico investe nella politica, usando i media per influenzare l’elettorato e i soldi e la promessa di privilegi per portare rappresentanti amici in parlamento, e fare passare le leggi che più aiutano o meno danneggiano i propri interessi. Più potere economico, più potere di voce, più potere di influenza, più potere politico. Il declino della democrazia sta scritto qui.
Quello che vediamo succedere in Europa assomiglia a questo processo involutivo. E la ragione è contenuta nella diminuzione del sostegno e dei diritti del lavoro il cui obiettivo era di rendere il lavoro equamente pagato, non semplicemente pagato. È la nuova forma di povertà che dovrebbe indurre i governanti delle democrazie europee a riflettere sulla saggezza delle loro gioiose liberalizzazioni. I nuovi poveri non sono tanto e solo i disoccupati, ma invece i lavoratori, una sempre più larga fascia di chi lavora con salari semplicemente troppo bassi per pagare le bollette, la scuola ai figli, il mutuo, l’affitto o perfino per sbarcare il lunario avendo una casa in proprietà e libera da mutuo. Si chiamano lavoratori marginali. Coloro che hanno contratti di lavoro a termine, che non guadagnano a sufficienza per consumare e che quindi non generano crescita, non sguinzagliano innovazione. In Italia questa sindrome della “creazione di posti di lavoro senza crescita” ce la raccontano Tito Boeri e Pietro Garibaldi. Ma il fenomeno è generale nelle democrazia capitalistiche. E si chiama nuova povertà, ritorno alle condizioni di vita dell’Ottocento, quando non c’erano ancora i sindacati a proteggere i salariati ma solo le solidarietà post factum, la rete di carità delle parrocchie e delle società di mutuo soccorso, quella che Robert Nozick ha elogiato come libero sostegno e aiuto caritatevole per via di scelta individuale, non di imposizione fiscale come vorrebbero i liberal-sociali o socialdemocratici che dir si voglia.
Questa povertà di ritorno è però di gran lunga più preoccupante e devastante di quella ottocentesca, poiché arriva per perdita. Perdita di potere di contrattazione, di potere di acquisto, di influenza politica, di dignità del lavoro e di diritti associati al lavoro, perdita della cittadinanza. Ma augurarsi che i sindacati si indeboliscano, è quanto di più sbagliato e assurdo per il modello inclusivo poiché è proprio grazie al conflitto che ancora esiste la possibilità di tenere aperto il gioco del modello capitalistico senza franare nel modello estrattivo. La forza della libertà sta proprio qui, nell’impedire che il modello inclusivo segua le pulsioni che ha verso l’altro modello. Senza lasciare libero gioco al conflitto sociale c’è semplicemente povertà, una maledizione contro la quale non c’è proprio nulla da fare. E se nulla resta da fare o da perdere per chi è in fondo alla scala gerarchica economica, allora la violenza e la disintegrazione sociale sono scenari del possibile. In questo caso, a perderci non sono soltanto i milioni di cittadini e di esseri umani che vivono come topi nelle ‘affluenti’ società capitalistiche. A perderci è l’intero sistema poiché quando una parte sempre più ampia è esclusa a priori dalla possibilità di provare a costruire e fare, a guadagnare e vivere bene e dignitosamente, allora si è già in regime “cinese”, quello che estrae dalla società grande la ricchezza che va a impinguare la società piccola, usando l’arma della repressione per scoraggiare gli oppositori invece di quella della loro inclusione nel sistema di decisione.
La lezione della storia, scrivono in un libro appena uscito Daron Acemoglu e James A. Robinson, è che non si fanno scelte economiche giuste se non si fanno anche scelte politiche giuste, ovvero se le prime non sono fatte a spese delle seconde o viceversa. In sostanza, il giacobinismo liberista e quello politico (di destra) si incontrano proprio nel sacrificare o restringere le opportunità a che tutti possano partecipare al gioco, sapendo che i loro sacrifici non saranno futili, ovvero che il gioco è aperto ai loro sforzi. La crescita del numero dei lavoratori poveri è un monito a chi governa a dubitare dell’efficacia delle politiche liberiste (in America Latina sono state fallimentari e abbandonate con successo, dell’economia e della democrazia). Un lavoro mal pagato e poco garantito è una porta spalancata alla povertà, di chi lavora e dell’intera società, se vogliamo ancora credere nella promessa di libertà e opportunità che ci viene dall’ideologia della democrazia nella società di mercato.
Nadia Urbinati









