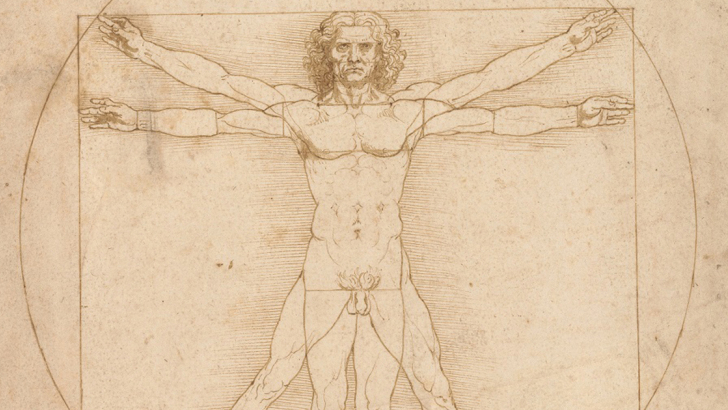Gli occhi del cielo: come si controlla il traffico aereo in Italia

“ITY 795, Linate torre buongiorno, vento calmo, QNH 1013, autorizzati all’atterraggio pista 35”
Questa è una frase standard di autorizzazione all’atterraggio (sarebbe in inglese ma semplifichiamo per comodità) che viene utilizzata ogni giorno, centinaia di volte, da un controllore di volo in Italia, nello specifico, all’aeroporto di Linate (Milano) in Lombardia. Il nome in codice dell’aereo è fittizio (ITY sta comunque per It-arrow, il codice con cui è conosciuta la nostra compagnia di bandiera, Ita Airways), ma quello che interessa è sapere che nella serata di sabato 28 giugno scorso, un’autorizzazione del genere non sarebbe mai potuta avvenire, a causa del grave problema tecnico che ha prima bloccato e poi rallentato l’intero sistema aeronautico civile del Nordovest italiano.
Impossibile, ancora, sapere le cause, né sarebbe corretto affrettarsi a fare delle conclusioni prima che siano chiuse le indagini. Quello che si sa è che, a partire dalle 20:20, il sistema che permette di monitorare il traffico aereo tra i cieli della Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia è andato in tilt, costringendo gli enti preposti a mettere a terra tutti gli aeromobili in arrivo e in partenza. Ad andare KO, per cause ancora tutte da chiarire, non i radar veri e propri (le grandi antenne che trasmettono e ricevono i segnali), ma la rete che trasmette i dati e che permette ai controllori di visualizzare sui monitor i velivoli, chiamata E-Net.
Come funziona il controllo del traffico aereo
L’air traffic control (ATC) è suddiviso per aree di intervento. A livello macro, l’Italia è suddivisa in quattro grandi settori, detti CTR (Control Traffic Region): Milano (quello del guasto in questione con competenze nel Nordovest), Padova (Nordest), Roma (centro e isole) e Brindisi (Sud). All’interno dei CTR, senza entrare necessariamente in tecnicismi estremi, a seconda della posizione dell’aereo in questione, ci sono diversi settori di competenza. Semplificando molto, ci sono controllori che si occupano del traffico aereo a terra (ground, cioè tutti i velivoli che si trovano sulle piazzole di sosta o in movimento verso le piste), quelli che si occupano degli aerei in decollo o atterraggio da un aeroporto (Tower, le torri di controllo vere e proprie o ADC, gli aerodrome controller), chi si occupa degli avvicinamenti, cioè di tutti gli aerei che stanno uscendo dalla crociera per avvicinarsi a un aeroporto e viceversa (Gli approach controller, APC) e infine gli ACC, gli area controller che sono impegnati nel seguire gli apparecchi in volo nelle quote di crociera e che hanno il compito di gestire le separazioni, cioè le distanze verticali e orizzontali. Immaginate il cielo come una sorta di autostrada con numerose corsie che portano a destinazioni diverse: gli aerei volano a quote differenti e devono rimanere, appunto, separati – verticalmente – di almeno 1.000 piedi (circa 300 metri) e di cinque miglia nautiche sul piano orizzontale (circa nove chilometri).
Leggi anche: I dati dicono che viaggiare in aereo è ancora sicuro
Per dare un’idea della mole di lavoro media giornaliera: in Italia si muovono mediamente poco più di 1.000 aerei, suddivisi tra traffici domestici (partono e arrivano da aeroporti nazionali), internazionali e di sorvolo (passano solamente sopra al nostro spazio aereo nazionale).

La torre di controllo dell'aeroporto di Linate. Foto: Wikipedia commons - Saggitarius A
Come si controllano tutti questi velivoli
Qui entrano in gioco la vista (per le torri di controllo minori), e i radar (di terra per la ground), per tutto quello che è già in volo.
I radar, a loro volta, sono suddivisi in due gruppi. Esistono i cosiddetti radar primari e quelli secondari.
I primi sono quelli che siamo abituati a vedere in tutti i film: sono le grandi antenne a parabola che girano su se stesse e trasmettono un segnale che viene riflesso dagli aerei e captato nuovamente dalla stessa antenna. Sono gli strumenti che permettono ai controllori di vedere le tracce dei velivoli sui propri schermi. I radar secondari, invece, garantiscono la ricezione di informazioni aggiuntive molto importanti, quali il codice identificativo di un aereo, la sua altitudine e la sua velocità. Funzionano grazie alla ricezione di un segnale radio inviato da uno speciale dispositivo che si trova all’interno di ogni aereo (privato, militare o commerciale che sia), chiamato transponder. Per rendere l’idea, il transponder è lo strumento che viene utilizzato da un pilota anche quando è costretto a chiedere aiuto con il segnale di emergenza più importante, il mayday: il comandante, oltre ad avvisare via radio dell’allarme, imposta uno speciale codice numerico (detto Squawk in gergo) sul transponder che verrà identificato come tale anche dai controllori di volo.
Attraverso questi sistemi di sorveglianza e alle comunicazioni via radio (e anche in formato digitale), i guardiani dei nostri cieli riescono a smistare, osservandoli su numerosi schermi, tutti gli aerei e a dirigerli verso le loro rispettive destinazioni. Quando tutto funziona a dovere. È logico comprendere quanto sia delicato un lavoro del genere e quanta attenzione, tecnica e umana, sia necessaria perché tutto funzioni correttamente.
L’ente preposto al controllo
In Italia, la società che sovraintende a tutte le operazioni di controllo del traffico aereo civile (per quello militare c’è un sistema a parte) si chiama Enav (Ente nazionale per l’assistenza al volo) e gestisce il traffico aereo italiano e tutti i controllori di volo.
L’infrastruttura tecnologica gestita da Enav è considerata una delle più avanzate a livello europeo ed è rappresentata dall’ATM, l’air traffic management, il sistema di elaborazione dei dati e di presentazione degli stessi per le operazioni di controllo del traffico aereo. Nella pratica, Enav è dotata di nove radar primari, di 12 radar secondari per il controllo del traffico di rotta (gli ACC di cui sopra), 18 radar primari e 18 secondari per le fasi di avvicinamento e 10 radar di terra. Questi sistemi trasmettono un’enorme mole di dati grezzi che devono essere elaborati, filtrati e smistati in segnali riconoscibili dai controllori.
Il sistema E-Net
Qui entra in gioco E-Net, il sistema che riceve e trasmette tutti i dati ricevuti dai radar e li manda ai chi gestisce il traffico. Non solo questo, perché – nella realtà – questa rete di trasmissione dati permette anche di scambiare comunicazioni interne tra i vari enti di controllo, nazionali e internazionali. Ed è proprio E-Net ad essere andata in tilt lo scorso sabato 28 giugno. Il guasto, infatti, non avrebbe colpito i radar fisici. Le antenne hanno continuato a ricevere i dati che, però, non sono stati poi trasmessi come da protocollo. La conseguenza è stata quella che conosciamo: Enav ha attivato i sistemi di emergenza (funzionano tramite i satelliti) che però non possono garantire la stessa precisione di quelli primari ed è stata costretta a chiudere il CTR di Milano, garantendo ai velivoli in avvicinamento e nella fase successiva al decollo di concludere le operazioni, fermando tutto il resto. Stop ai voli strumentali (praticamente tutti quelli di linea) dagli aeroporti di Linate e Malpensa (Milano), Orio al Serio (Bergamo), Caselle (Torino) e di Sestri (Genova). Si stima che gli aerei interessati dallo stop siano stati oltre 300. Un numero abbastanza elevato, nonostante il guasto si sia verificato in orario serale, ma che non stupisce: i soli aeroporti di Malpensa e di Orio al Serio sono il secondo e il terzo più trafficati di Italia. Prima di loro solamente Roma Fiumicino.
L’indagine in corso
Tornando a E-Net: al momento le cause del malfunzionamento non sono ancora note. Enav, in un gioco delle parti, ha accusato TIM (il gestore della rete) dei problemi, ma la compagnia telefonica ha rispedito al mittente il messaggio. Per sapere cosa sia successo, ci vorrà almeno una settimana: L’Enac (Ente nazionale aviazione civile), l’autorità che in Italia ha poteri di regolazione, certificazione, vigilanza e controllo dell’aviazione civile, ha ufficialmente aperto un’inchiesta su quanto successo. Il primo rapporto dovrebbe arrivare sul tavolo del ministero dei Trasporti e in Parlamento entro, appunto, sette giorni, stando a quanto dichiarato.
Al di là dei rimpalli e senza scadere in velleitarie quanto errate congetture, E-Net è ovviamente dotato di sistemi di ridondanza (cioè di apparati doppi in caso di emergenza per supplire a eventuali problemi). Resta da capire come mai non siano entrati in funzione nemmeno gli apparati secondari (Enav, in un comunicato stampa, ha dichiarato che anche i sistemi di backup erano andati in crisi e che gli unici sistemi a essere rimasti operativi riguardavano quelli voce, dati di volo, informazioni meteorologiche e i Notam – notice to air man cioè gli avvisi emanati dagli enti di controllo), costringendo l’ente a sospendere il traffico aereo per due ore su una porzione di cielo ad elevata circolazione.
Il precedente
Quello di sabato non è stato l’unico intoppo. Uno simile avvenne nel 2024 e interessò sempre la porzione di cieli del Nordovest italiano. Un guasto, a Linate, interessò il sistema operativo della sala di controllo del centro Enav di Milano. Anche in quel caso, seppure in modo meno grave, parecchi voli subirono ritardi e cancellazioni.
Nel resto del mondo
I problemi nei cieli non sono solo una casistica italiana, ma prima è necessario puntualizzare un dettaglio importante: volare rimane, attualmente, il modo più sicuro per viaggiare. Certo, gli inconvenienti e i guasti possono esserci anche qui, come in tutti i settori del trasporto, ma sono i dati statistici a parlare chiaramente. Fatta questa doverosa premessa, anche in altre parti del mondo, si sono verificati problemi ai sistemi di gestione del traffico aereo. In particolare negli Stati Uniti e più specificatamente nell’area di controllo di New York, una di quelle più trafficate al mondo. Più volte ci sono verificati dei veri e propri blackout che hanno fatto lavorare al “buio” i controllori per qualche minuto (eterni, rispetto alla mole di velivoli da gestire), fortunatamente senza che si siano create vere e proprie emergenze o, peggio ancora, tragedie.