“Vertigine” di Beatrice Mautino: credere nella scienza anche quando la paura fa vacillare
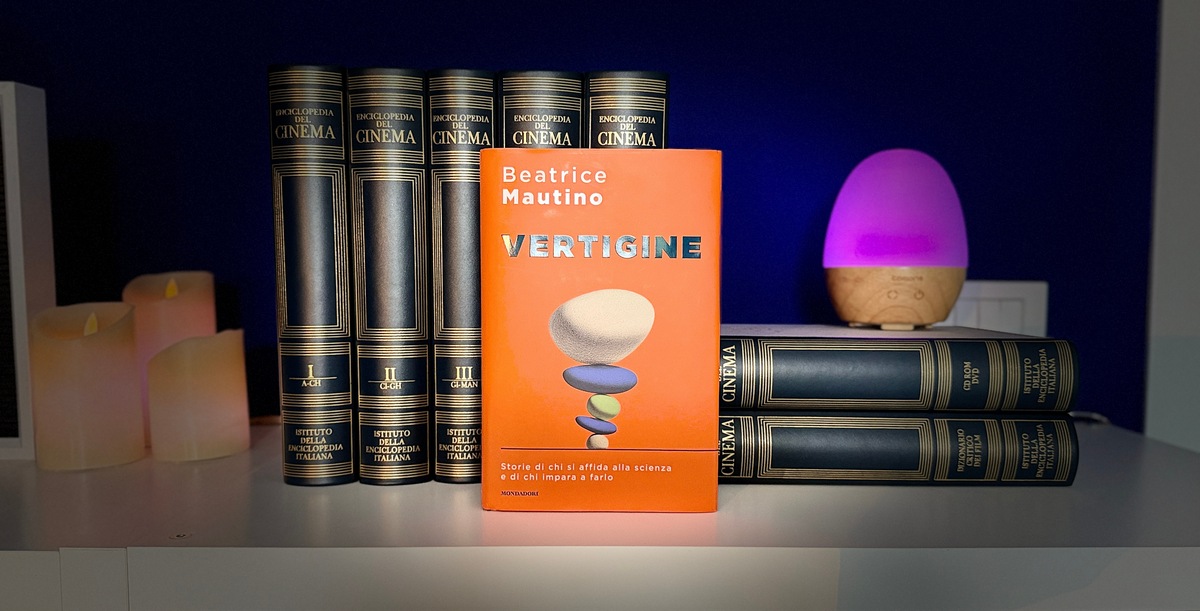
Ci sono persone fortunate che non si sono mai trovate nella situazione di doversi affidare alla scienza per curare una malattia grave che colpiva loro o un loro caro.
Per queste persone fidarsi della scienza di solito è semplice, ma quando la malattia ti entra in casa, spesso in modo improvviso, si finisce in un frullatore di emozioni, che possono anche arrivare a mettere in crisi le proprie certezze, e di colpo ci si ritrova in equilibrio instabile sull’orlo di un burrone: come si fa a fidarsi della scienza pur sapendo che la scienza, per definizione, non promette certezze definitive ma si costruisce per tentativi, prove ed errori? Forse è più facile affidarsi a chi di certezze ne ha fin troppe, come è successo a chi ha manifestato a favore del metodo Stamina, che poi di metodo non aveva nulla, quantomeno in senso scientifico. È facile cadere nel burrone, quando la speranza diventa più forte della razionalità, quando il desiderio di un miracolo ci allontana dal metodo, scientifico questa volta.
Quella del burrone è la metafora che utilizza Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice, nel suo nuovo libro Vertigine - Storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo (Mondadori, 2025). L’autrice parte da un’esperienza personale, ma poi allarga il discorso per raccontare anche storie di altre persone, in un’indagine collettiva che cerca di rispondere alla domanda “perché dobbiamo fidarci della scienza, anche quando diventa difficile?”
Anche le persone razionali vacillano
Mautino parte dal suo personale punto di rottura: la diagnosi di un tumore raro in famiglia, arrivata nel 2020, nel pieno del caos pandemico, quando non potevi nemmeno stare in sala d’aspetto con il familiare malato. Le fotografie dei suoi piedi davanti agli ospedali diventano il simbolo del confine tra dentro e fuori, tra chi è curato e chi resta sulla soglia: la pandemia ha portato a galla la condizione del caregiver, la persona che assiste il malato, e che pur restando fuori, dall’ospedale o dalla malattia, con la testa invece è sempre lì dentro.
Ma Vertigine non è un libro autobiografico: racconta come si fanno le scoperte, come si validano i risultati, come si sbaglia e si corregge, ma soprattutto cosa vuol dire “affidarsi alla scienza” non da un punto di vista filosofico, ma nella pratica, quando ci sei in mezzo, in ospedali, laboratori, centri di ricerca, luoghi dove il metodo scientifico si estrinseca in forma concreta e dove, accanto alle macchine, ci sono anche le persone.
E se anche alle persone che lavorano nel settore scientifico capita di vacillare, forse nel caso di episodi come quello di Stamina (trattato nel libro approfonditamente) bisognerebbe evitare di giudicare i disperati che manifestavano perché erano convinti di essere stati privati della possibilità di cura, e concentrarsi piuttosto su ciò che si può fare per evitare derive di questo tipo, proprio come ha fatto Mautino scrivendo questo libro.
Il metodo scientifico serve a proteggerci
Ma cosa succede quando il metodo scientifico viene messo in un angolo per dare voce a speranze più o meno affidabili? Una delle storie più disturbante è quella di Beata Halassy, virologa croata che, di fronte alla terza recidiva di un tumore, decide di iniettarsi da sola due virus nella speranza di curarsi. Halassy conosceva la viroterapia, sapeva manipolare i virus, e si è convinta di poter fare ciò che la medicina ufficiale non riusciva (ancora?) a offrire.
Mautino racconta il caso con comprensione ma anche inquietudine: riconosce in quella scelta la tentazione che tutti, prima o poi, sentiamo, quella di ignorare le regole, di credere all’intuizione più che alla procedura, di cercare una scorciatoia quando il dolore rende intollerabile l’attesa: probabilmente al posto di Halassy molti farebbero la stessa cosa, ma è importante comprendere che è stato un tentativo estremo, che non ha nulla a che vedere con la scienza, e proprio per questo non è mai riuscita a pubblicare i risultati su una rivista scientifica valida, ma solo su quella che spesso viene identificata come “predatoria” (per chi non sa cosa significa, c’è un capitolo del libro che spiega come funziona la ricerca, e che una pubblicazione non vale l’altra).
La scienza come esercizio di umiltà
La scienza dovrebbe essere anche un esercizio di umiltà, come dimostra la storia del salmone morto: siamo nei primi anni Duemila, e il neuroscienziato Craig Bennett sta testando un nuovo macchinario per la risonanza magnetica funzionale (fMRI), quella tecnica che “fotografa” le aree del cervello che si attivano in presenza di vari stimoli. Per calibrare la macchina, prova a mettere alcuni oggetti come una zucca dentro lo scanner. Tra questi oggetti, c’è anche un salmone comprato al supermercato e gli mostra una serie di fotografie di persone in diverse situazioni emotive. Naturalmente, essendo morto, il salmone non doveva avere nessuna reazione, e invece alcune aree del suo cervello risultarono attive. Un pesce fantasma particolarmente empatico? Naturalmente no: si trattava di un’anomalia statistica, perché le risonanze magnetiche funzionali analizzano centinaia di migliaia di micro-porzioni di tessuto (i cosiddetti voxel). Se si confrontano tutti questi voxel tra loro senza applicare filtri o correzioni matematiche, è praticamente certo che alcuni mostreranno falsi positivi, cioè, in questo caso, attività cerebrale inesistente.
Applicando i correttivi, i segnali sparivano. Quando Bennett andò a verificare altri studi già pubblicati, però, scoprì che molti non li avevano applicati: decine di ricerche “serie” sul cervello umano contenevano, potenzialmente, risultati falsati. La storia del salmone morto, oltre a farci riflettere sul fatto che a volte diventa utile avere l’umiltà (o l’umorismo) di controllare anche l’ovvio, mette in evidenza anche la fallibilità umana: se perfino le macchine possono produrre illusioni, quanto più fragile è il nostro giudizio quando la paura ci spinge a credere in qualcosa? Il metodo scientifico, in quei momenti, è lì per proteggerci da noi stessi, è ciò che ci impedisce di scambiare un pesce morto per un miracolo.
Come funziona davvero la scienza
Il cuore del libro è proprio una riflessione sul funzionamento quotidiano della scienza, della medicina e della ricerca, ben lontana dalla retorica eroica di certe forme di comunicazione che troppo spesso si concentrano sul lieto fine, romanticizzando le difficoltà superate, quando invece sono onnipresenti anche se le cose poi vanno bene.
La scienza è fatta di controlli, protocolli, statistiche, fallimenti, burocrazia e tempo. Un tempo lungo, incompatibile con la fretta di chi cerca una risposta immediata, magari perché ne va della sua vita.
Eppure è proprio questa lentezza la sua forza: il metodo serve a evitare che l’errore, la suggestione o la disperazione mettano in pericolo chi è in difficoltà.
“ Quando non vedi soluzioni, quando credi che nessuno pensi a te, quando ti scontri con la spietatezza del metodo scientifico, basta un niente per cedere al primo spiraglio di speranza, anche se viene da fonti non affidabili Beatrice Mautino
Dove la scienza diventa cura
Vertigine non si ferma a parlare del metodo in astratto. Mautino entra nei luoghi dove la scienza prende corpo: prima il Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) di Pavia, dove un sincrotrone spara fasci di protoni per curare tumori complessi, poi il SR-Tiget, l’istituto del San Raffaele dove si sviluppa la terapia genica.
Nel CNAO, racconta Mautino, c’è un’energia che non è solo quella dei protoni, ma quella di un gruppo di ricercatori, fisici, infermieri e tecnici che lavorano insieme per un obiettivo comune.
E quando descrive il Tiget, dove vengono curate le malattie genetiche rare, la prospettiva si allarga ancora: dietro ogni protocollo, ogni cellula manipolata, c’è il personale che ascolta, i genitori che aspettano, i bambini che vengono curati nel senso più ampio del termine, perché il percorso che dovranno affrontare non sarà solo fisico, e a volte anche una banale busta della spesa che li aspetta nella loro nuova casa provvisoria fa la differenza.
Nella parti del libro in cui vengono raccontate le esperienze dei pazienti il tono cambia, ma non si gioca mai sulla pietà: le storie delle persone, che siano i malati, i caregiver, i ricercatori, diventano parte del racconto scientifico, perché dimostrano che la scienza avanza anche grazie alla fiducia di chi accetta di partecipare alle sperimentazioni, di mettere il proprio corpo o la propria vita dentro un esperimento regolato, trasparente, verificabile ma, a volte, ancora senza certezze di successo, come nel caso della fecondazione in vitro.
Tra ricerca e fiducia
Uno dei meriti maggiori di Vertigine è la capacità di rendere visibile la ricerca, nel suo funzionamento reale: i finanziamenti, le revisioni, le pubblicazioni, gli errori, le scoperte.
Mautino la spiega, con chiarezza divulgativa, senza pedanteria, intrecciando gli argomenti più tecnici ai racconti umani: non ci sono confini rigidi tra parti tecniche e narrative, si integrano tra di loro come nella vita reale, dove la scienza non procede per compartimenti stagni ma attraverso conversazioni, tentativi e ripensamenti condivisi.
È questo intreccio a rendere il libro così efficace: mentre racconta come funzionano protocolli, finanziamenti e sperimentazioni, Mautino restituisce anche l’elemento che spesso sfugge, il fatto che la ricerca è una pratica profondamente umana, fatta di dubbi, compromessi e fiducia.
Viviamo in un’epoca in cui la scienza è ovunque ma la fiducia vacilla: tra bufale, complotti, e promesse miracolose, è facile cadere nella tentazione di chi offre certezze che non può dare. Mautino, e la scienza, non ci regalano illusioni, ma la consapevolezza che la conoscenza è instabile per natura, e che proprio per questo è la nostra migliore difesa contro la manipolazione: un’impresa collettiva fatta di fallimenti, di verifiche, e di persone che continuano, nonostante tutto, a cercare.









