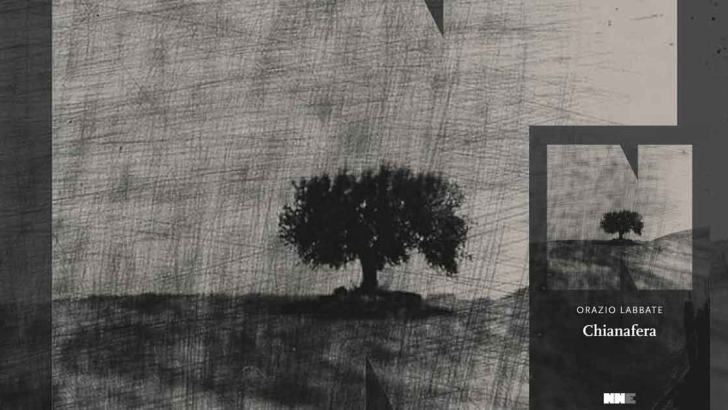Sullo scaffale: Dio della polvere di Mariapia Veladiano

“Il vostro è un Dio della polvere. Lo avete disintegrato. Per questo fate pulire i vostri palazzi in modo ossessivo, da donne addestrate ad affogare nell’ossessione della pulizia la loro vocazione. Dio si dissolve sotto i colpi delle vostre bugie, opere, omissioni, tergiversazioni, confusioni. Non c’è salvezza. Diventa polvere da scuotere fuori dalla finestra”.
Mariapia Veladiano non fa sconti: il suo ultimo romanzo, Dio della polvere (Guanda, 2025), colpisce per quant’è diretto, disincantato, affilato e umano.
Queste parole sono pronunciate, a due terzi della storia, dalla protagonista, una fisioterapista fortemente motivata a fare chiarezza su un presunto caso di abuso perpetrato da un uomo di Chiesa su una sua paziente quando era bambina, e la battuta è pronunciata in un dialogo serratissimo con il vescovo. Dialogo che è il cuore del romanzo tutto.
Non è un libro di trama questo, per paradosso, ma di lingua e di pensiero. La ricostruzione della verità non avviene nel discernimento dei fatti ma nel registrare le reazioni del colpevole, che – per traslato – è anche chi sapeva e non ha detto, chi ha insabbiato, chi semplicemente non ha avuto cura.
“Prego aveva detto la suora. Prego, diceva il monsignore. Tutti questi prego, lei pensò, ma pregava questa gente?”
Veladiano, laureata in filosofia e teologia – e che non ha mai nascosto la sua solida fede –, in questo romanzo fa qualcosa che, venendo proprio da chi conosce il Verbo, assume una potenza dirompente. Scandagliare un mondo conosciuto, amato, studiato, sostenuto (soprattutto di questi tempi, in cui è più comune prenderne le distanze) e tracciarne con la penna, tagliente come un rasoio, le indicibili debolezze fa di questo romanzo una discesa agli Inferi che è quasi resurrezione.
Si intuisce che c’è stata grande documentazione e la disamina del dato oggettivo trova spazio nella storia stessa: “Prendendo le vostre vaticane cifre ufficiali, annacquate nel Tevere, i pedofili sono il due per cento dei vostri preti. Siccome li spostate di parrocchia in parrocchia quando vengono scoperti, e così offrite loro vittime fresche e abbondanti a ogni cambio di destinazione, si può ipotizzare che queste possano essere più o meno cento per prete nel corso della vita” e facendo due conti, nella diocesi in cui si svolgono le vicende “ci sono almeno mille vittime, calcolate sui numeri che voi spacciate”.
Dio della polvere è un romanzo che, toccando l’abisso, ragiona una volta in più sull’ “homo sum” terenziano: niente di umano ci è distante. No, certo. Ma gli emissari del Signore non dovrebbero – anche in virtù del loro potere – non permettersi mai la caduta?
“Sappiamo bene che tutti possiamo fare cose tremende. Ma se il prete violentatore dice di essere Dio e altri preti che dicono di essere Dio lo proteggono dalle vittime, cioè i bambini che Dio ama, allora il cortocircuito è definitivo”.
Ed ecco che vengono a galla tutte le contraddizioni, anche quelle più semplici: “Voi parlate di fedeli ma a chi? A voi o a Dio? Fedele è una parola ambigua e dovreste usarla con prudenza perché voi pensate a voi stessi e non a Dio quando la pronunciate”; o ancora: “Come può predicare l’amore se non sa cos’è l’amore?” chiede la fisioterapista al vescovo. “Lo fate anche con i figli. Predicate la famiglia e non sapete che cosa sia. Dite che i figli sono una benedizione ma non ne fate”.
Certo: il pensiero di Chiara non è per forza quello di Veladiano, ma dà voce a quel risentimento che nasce in seno a chi è sempre oggetto della predicazione altrui.
E sotto a ogni riflessione che si incardini sull’uomo – e su Dio – inevitabilmente soggiace quel sentimento motore universale che è l’amore, e che incarna il tradimento stesso, quando si agisce non in suo nome.
“Dio quanto ci si può amare” pensa la protagonista ricordando l’ex marito. “Eppure ci si perde. L’eternità è un bell’imbroglio” e nel tentativo di elevazione che porta alla fede (oppure leggendo gli stessi concetti in una chiave assolutamente terrena): “L’amore ha in comune con la morte il fatto di essere assoluto. Se ci si innamora, il mondo di prima non ha più l’ordine in cui vivevamo […] il futuro cambia di segno, se avevamo paura non ne abbiamo più. È quello che capita ai discepoli” fino alla confidenza del vescovo stesso che parla del suo rapporto con Gesù come di “un sentimento privato” che fa sì che non ci senta più soli.
E dal tradimento alla colpa paradossalmente il passo è breve, come se l’individuazione della responsabilità fosse sempre un fatto ambiguo. È anche su questo che s’incentra la perorazione della protagonista, il suo desiderio di verità, che necessita di essere detta perché “il linguaggio crea la realtà, costruisce il nostro pensiero”. E veniamo quindi a scoprire, leggendo, che il vescovo irlandese Cummeano del settimo secolo aveva scritto un Penitenziale “in cui l’elenco dei peccati sessuali è così preciso che oggi un qualsiasi mediocre psicoanalista gli raccomanderebbe un’adeguata terapia solo per il fatto di aver dedicato la vita a queste immaginifiche azioni peccaminose”. Il Penitenziale di Egberto arcivescovo di York nell’ottavo secolo prevedeva invece che un bambino vittima di violenza digiunasse cinque giorni. “Se è stato passivo e non si è opposto i giorni sono venti”.
E allora come potremo mai uscire da retaggi terreni, psicologici, sociali e culturali che ci ingabbiano prima ancora che mettiamo piede sulla terra?
Veladiano, oltre chiaramente a mostrare la via diretta – quella che la protagonista segue con caparbietà: la denuncia – ne suggerisce sottilmente un’altra. Non a caso, infatti, a muovere le fila della storia, e a dibattere con il vescovo, è una donna che per mestiere cura il corpo, ed è tramite il linguaggio del corpo, che è silente, che lei ha potuto comprendere l’inaccessibile e impronunciato dolore delle vittime.
“La violenza è corpo, dolore, fibre nervose che si infiammano, si accavallano, si contraggono, il nervo ascellare blocca il muscolo deltoide e l’ipotrofia muscolare impedisce di usare le braccia e poi più giù si infiamma lo psoas. Il muscolo dell’anima lo chiama la medicina orientale”.
Proprio così: il muscolo dell’anima. “L’anima, la nostra preziosa individuale interiorità, ha un principio materiale corporeo. Chi ci violenta il corpo ci sottrae l’anima”.
“ Chi ci violenta il corpo ci sottrae l’anima Mariapia Veladiano