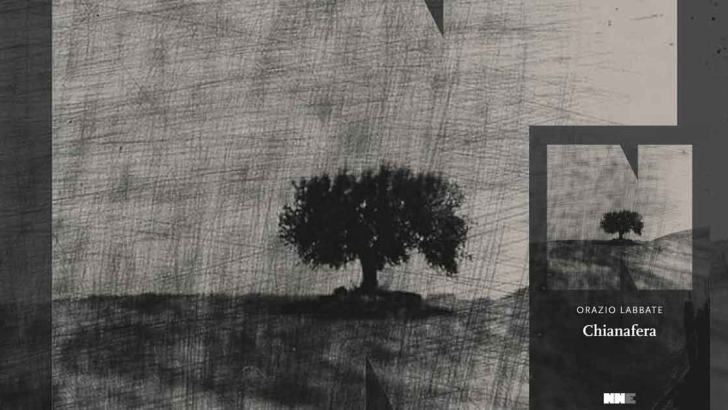Sullo scaffale: Corta è la memoria del cuore di Giuseppina Torregrossa
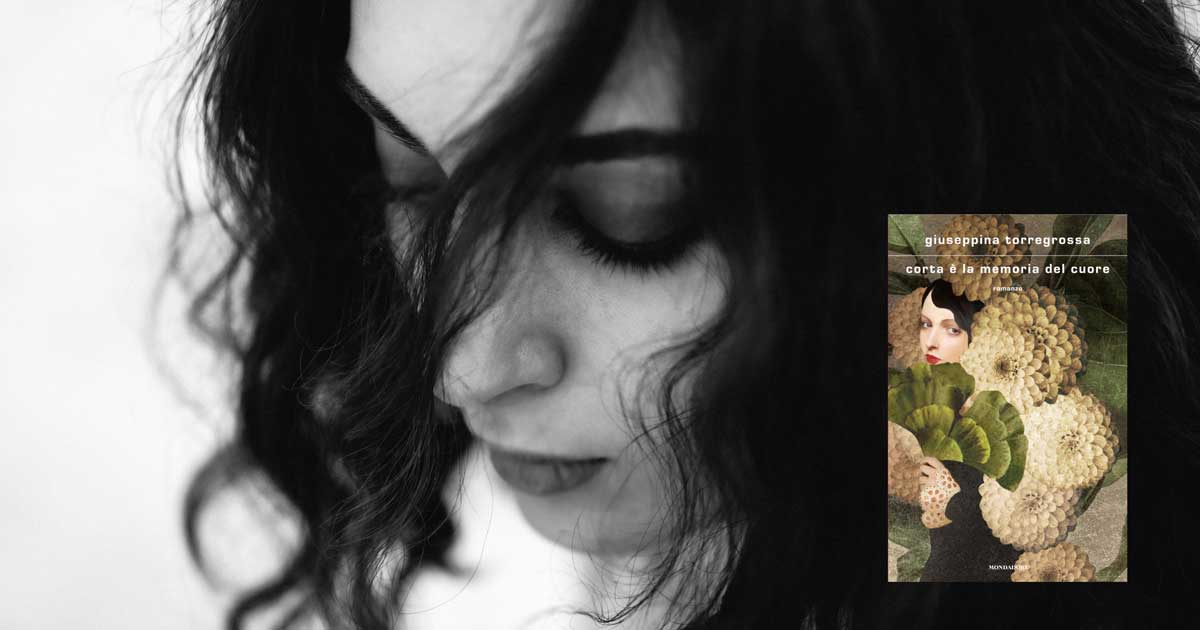
È una storia "di DNA mitocondriale", si potrebbe dir così, quella che Giuseppina Torregrossa mette sulla pagina nel suo ultimo romanzo, Corta è la memoria del cuore, uscito per Mondadori.
Si tratta infatti del racconto della vita di una famiglia narrato da parte di femmina: di madre in figlia, in figlia, in figlia. Teresa, la capostipite, “era donna, doveva solo fare figli per la patria, prendersene cura, tacere e ubbidire. E infatti si era sposata, lavava, cucinava, ma il contesto era cambiato, c’era la democrazia. […] Sapeva che sarebbero arrivati dei figli, ma quando rimase incinta si chiese: “È questo quello che voglio?””. Così “Elena [la figlia] non lo sapeva ma era fatta della stessa sostanza della madre. La disciplina cui era costretta alimentava la rabbia che le era stata passata con il sangue, con il latte”. Lo stesso per Marisina, figlia di Elena, e giù ancora.
Torregrossa cioè dipana una trama che, intessendosi sul tessuto della storia d’Italia dell’ultimo secolo – arrivando fino al lockdown e oltre – mostra come le evoluzioni del Paese si siano rispecchiate in seno al nucleo primigenio della famiglia. E in particolare sulle donne. Ma non solo su di loro, chiaramente. Il primo esempio tangibile di questa interrelazione narrato nel romanzo è la questione dei vaccini. Quando Teresa porta i figli dal pediatra, questi le propone: “Possiamo vaccinarli, ma è una sua scelta, perché il vaccino non è ancora obbligatorio”. “Lo chiedo a mio marito” risponde lei e Luigi, avvocato, si fa venire uno scrupolo. “Lo Stato fa le leggi per il bene dei cittadini, ma deve farsi carico di tutto quello che succede. E se qualcuno rimane danneggiato per aver ubbidito a una legge dello Stato, allora lo stesso Stato che l’ha formulata deve provvedere a un indennizzo” pensa l’uomo. “Due anni dopo lui era libero docente e il vaccino antipoliomelite obbligatorio”.
E se questo rappresenta il piano dei fatti tangibili, per certi versi maschile, la discendenza matrilineare si tramanda un potere magico chiamato “occhio pesante” che è una sorta di preveggenza: un intuito magico, ancestrale. “Ma il corpo” dove questa capacità si dispiega “era l’altro grande tabù della sua famiglia, non se ne parlava mai, non lo si esibiva, non se ne conoscevano le regole e il funzionamento”.
Diversa sorte aveva il linguaggio: “Le parole, tutto ruotava attorno a esse. Dette e non dette, scritte, sottintese, sbagliate, senza senso, a proposito o a sproposito, non erano una semplice espressione del suo sentire, ma la causa stessa. […] Attraverso le parole avrebbe potuto scoprire i segreti che si celavano nei silenzi, il motore silenzioso che regolava i rapporti umani. Doveva pur esserci una verità oggettiva, c’è in ogni vita, in ogni fatto”.
Torregrossa in questo suo ultimo lavoro è come smontasse e rimontasse con delicatezza il meccanismo delle relazioni umane, scrivendo un romanzo in cui l’identificazione del lettore è inevitabile. Perché se, a dirla con Tolstoj, “tutte le famiglie felici si assomigliano tra loro”, in realtà possiamo pensare che non sia la felicità l’elemento chiave della rassomiglianza, ma ci sia davvero qualcosa che si ripete: di famiglia in famiglia, di generazione in generazione. Quale figlia non ha avuto con sua madre un rapporto turbolento? O – viceversa – simbiotico?
Ciò che possiamo tenere a mente Giuseppina Torregrossa lo scrive incidentalmente a pagina 135: “Ognuno aveva una narrazione diversa della storia famigliare, ma nelle relazioni affettive non vale tanto il principio di realtà, quanto il percepito” e poi, ancora, a pagina 219: “Non è facile cancellare la madre, è sempre lì anche quando muore, a ricordare ai figli che sono al mondo solo grazie o malgrado lei”.
“ Nelle relazioni affettive non vale tanto il principio di realtà, quanto il percepito Giuseppina Torregrossa