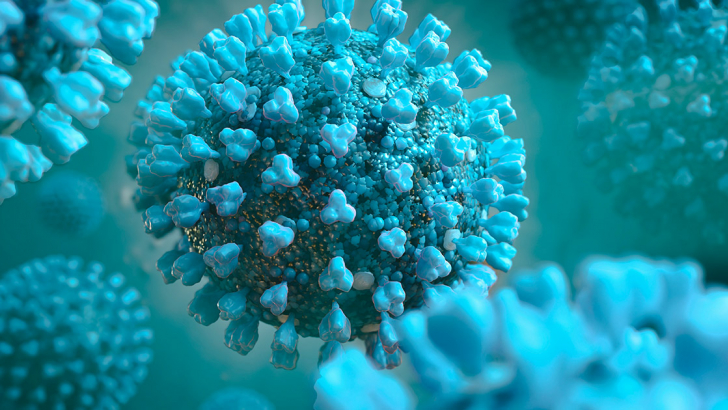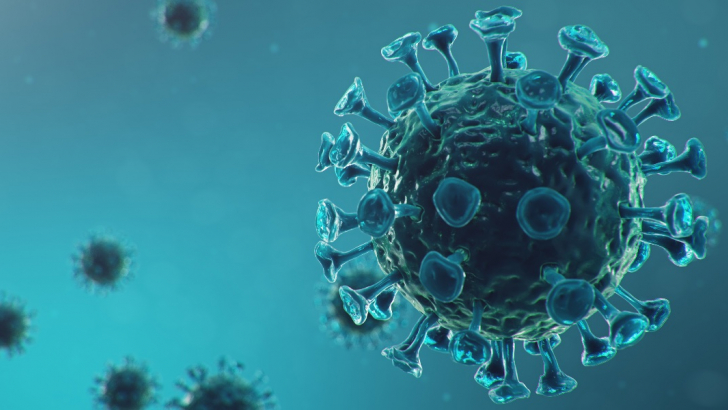Covid-19: gli anticorpi diminuiscono nel tempo ma la memoria immunologica dura più a lungo
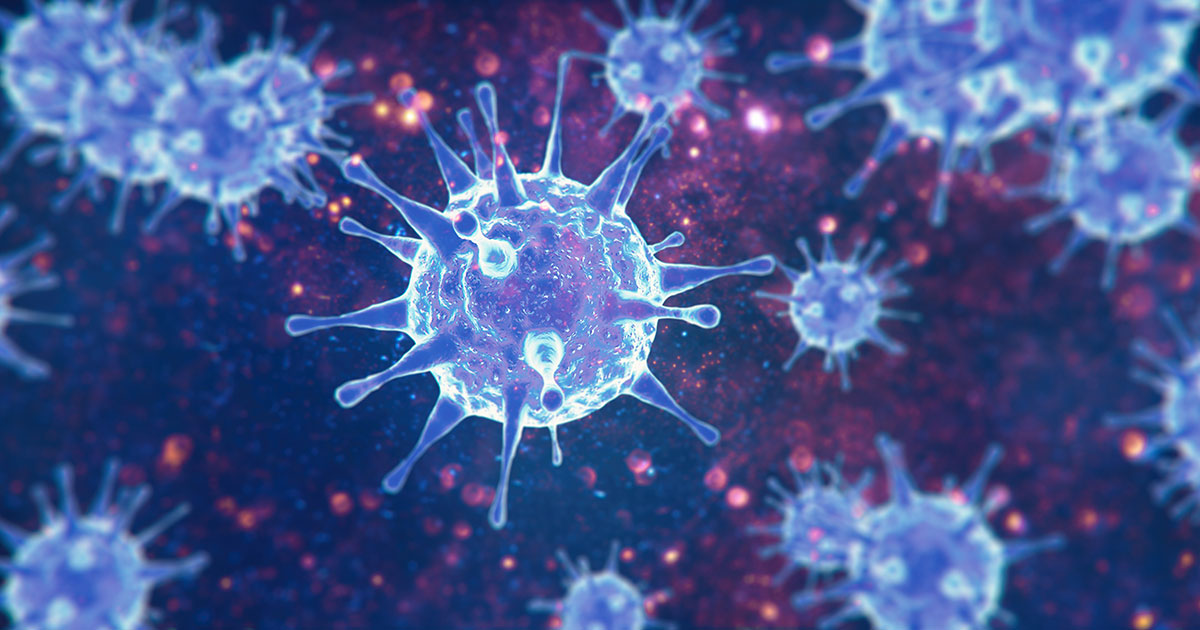
La durata della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 continua ad essere un tema ricorrente in questa pandemia. E non può essere diversamente: comprendere per quanto tempo una persona che ha già superato l’infezione possa considerarsi protetta è una priorità e con l'avvio delle vaccinazioni contro Covid-19 questa domanda ha acquisito ulteriori risvolti.
Per iniziare a conoscere la durata dell’immunità offerta dai vaccini dovremo aspettare almeno qualche mese, ma intanto hanno fatto molti passi avanti gli studi che avevano l’obiettivo di capire la persistenza degli anticorpi neutralizzanti e delle cellule della memoria tra le persone che in passato sono state contagiate.
A gennaio sono stati pubblicati tre lavori, uno su Science, uno su Science Immunology e uno su Nature, i cui risultati vanno nella stessa direzione: gli anticorpi, pur persistendo per il un periodo di almeno sei mesi, decadono nel tempo. Tuttavia questo non vuol dire che l’organismo umano, in caso di successiva nuova esposizione al virus, si ritrovi privo di protezione. La memoria immunologica si basa su meccanismi articolati e la capacità di riattivazione delle cellule B e dei linfociti T rappresenta una risorsa molto importante, anche se varia parecchio da una persona all’altra.
Lo studio condotto dai ricercatori del La Jolla Institute for Immunology è stato realizzato a partire dalle analisi dei campioni di sangue di 188 persone positive a SARS-CoV-2 (108 donne e 80 uomini), reclutate in diverse parti degli Stati Uniti e selezionate in modo affinché fossero rappresentative di tutte le forme in cui può presentarsi la malattia, da asintomatica a grave.
L’obiettivo era quello di analizzare in che modo tutti i componenti della memoria immunitaria evolvessero nel tempo. I risultati hanno mostrato che la risposta è ancora presente a distanza di otto mesi dall’infezione e che il prevedibile calo del titolo anticorpale, già osservato in precedenti ricerche, è compensato dal lavoro delle cellule della memoria che non lasciano l’organismo indifeso.
In more than 180 patients who had recovered from #COVID19, both antibody and immune cell responses were measurable for up to 8 months after symptoms appeared, in some cases, a new study by @Dani6020 @SetteLab @profshanecrotty & colleagues shows. https://t.co/WiDzCpw9wc pic.twitter.com/elV5DjZV4J
— Science Magazine (@ScienceMagazine) January 6, 2021
“I nostri dati suggeriscono che la risposta immunitaria è presente e rimane”, ha commentato Alessandro Sette, immunologo italiano di fama internazionale che si è trasferito da molti anni negli Stati Uniti ed è il primo autore dello studio insieme a Shane Crotty e Daniela Weiskopf. Il fatto che in una certa misura gli anticorpi diminuiscano nel tempo è normale, ha inoltre ricordato Sette, spiegando che le risposte immunitarie sono caratterizzate inizialmente da una fase di espansione, a cui fa seguito una contrazione che precede il raggiungimento di uno stato più stazionario.
Un aspetto molto rilevante riguarda la persistenza delle cellule B della memoria specifiche per la proteina spike del virus e dei linfociti T: a sei mesi dall’infezione le prime tendevano addirittura a crescere e anche entrambe le varietà dei linfociti T - le helper che aiutano e dirigono la risposta degli anticorpi e le killer che si occupano di distruggere le cellule infette - risultavano ancora presenti.
“Le diverse parti del sistema immunitario adattivo lavorano insieme”, hanno sottolineato gli autori dello studio precisando però che “l'immunità protettiva varia notevolmente da persona a persona”, con un intervallo di ampiezza che può essere anche di 100 volte. E in passato era stato già ipotizzato che la durata e la robustezza dell'immunità potessero dipendere, almeno in parte, anche dal decorso clinico della prima infezione.
Il fatto che la memoria immunitaria contro SARS-CoV-2 si mantenga nel tempo è un buon segno anche in funzione dell’obiettivo di raggiungere un’immunità di comunità attraverso i vaccini. “Gli studi sui vaccini sono nelle fasi iniziali e finora sono stati associati a una forte protezione. Ci auguriamo che un modello simile di risposte che durano nel tempo emergerà anche per le risposte indotte dal vaccino”, ha dichiarato Daniela Weiskopf, coautrice dello studio pubblicato su Science.
Daniela Weisskopf spiega i risultati dello studio pubblicato su Science. Video realizzato da Jenna Hambrick, La Jolla Institute for Immunology
Ad evidenziare il ruolo della memoria immunologica come forma di protezione contro SARS-CoV-2 è anche uno studio realizzato da diverse università australiane e pubblicato su Science Immunology.
Gli autori della ricerca, guidata da Menno van Zelm della Monash University, hanno analizzato campioni di sangue di 25 pazienti in un periodo che andava dal quarto giorno all'ottavo mese successivo all'infezione arrivando così a scoprire che gli anticorpi iniziano a diminuire già dopo 20 giorni ma che persistono le cellule B della memoria in grado di riconoscere il virus e di riattivare la produzione di anticorpi.
Memory B cells (mostly IgM+IgD+ and IgG1+) for #SARSCoV2 S and N proteins are more stable in blood than #antibody levels for up to 8 months after #COVID19.
— Science Magazine (@ScienceMagazine) January 9, 2021
Read more from the research in @SciImmunology: https://t.co/Z53k10BSGf
"Questi risultati sono importanti perché mostrano, in modo definitivo, che i pazienti infettati dal virus che è alla base di Covid-19 conservano in realtà l'immunità contro il virus e la malattia", ha commentato van Zelm aggiungendo che i dati alimentano la speranza di "una protezione a lungo termine da parte dei vaccini".
L'ultimo lavoro, in ordine di tempo, che si inserisce in questo filone di ricerca è stato pubblicato nei giorni scorsi su Nature e rafforza i risultati già precedentemente raggiunti da altri team, soffermandosi non solo sulla presenza delle cellule B della memoria ma anche sulla loro natura e qualità.
A paper in Nature reports on the evolution of the memory B cell response to SARS-CoV-2 over a period of 6 months. https://t.co/jfM87CFNTK pic.twitter.com/8Z1RwksAWx
— Nature (@nature) January 18, 2021
Gli studiosi, guidati da Michel C. Nussenzweig, della Rockefeller University di New York e dello Howard Hughes Medical Institute di Baltimora, hanno valutato la risposta anticorpale di una coorte di 87 individui positivi a SARS-CoV-2, una prima volta dopo 40 giorni dall'infezione e poi quando erano passati circa 6 mesi. E' stato così possibile scoprire che gli anticorpi neutralizzanti, diretti al dominio di legame del recettore situato sulla proteina Spike del coronavirus, continuavano ad essere rilevabili nella maggioranza delle persone ma diminuivano in modo significativo e attraverso esperimenti di laboratorio si è visto che la capacità dei campioni di plasma dei partecipanti di neutralizzare il virus risultava ridotta di cinque volte rispetto all'inizio.
Anche questa volta le notizie più incoraggianti sono arrivate sul versante delle cellule B della memoria: non solo a distanza di 6 mesi dal contagio il loro numero era rimasto invariato ma con il trascorrere del tempo si erano addirittura dimostrate capaci di produrre anticorpi più forti. Un aspetto di non poco conto, soprattutto in una fase della pandemia in cui aumenta l'apprensione per le nuove varianti di SARS-CoV-2. L'evoluzione dei linfociti B della memoria è infatti il punto più sorprendente dello studio perché i ricercatori hanno scoperto che queste cellule avevano subito numerosi cicli di mutazione anche dopo la risoluzione dell'infezione e che il nuovo set di anticorpi da esse prodotti era in grado di attaccarsi meglio al virus e poteva riconoscere anche versioni mutate di esso.
Abbiamo chiesto ad Enrico Lavezzo, docente del dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova di commentare gli ultimi studi internazionali che hanno indagato la persistenza nel tempo degli anticorpi contro SARS-CoV-2 e la funzione delle cellule della memoria nel rinforzare la protezione immunitaria in caso di nuova esposizione al patogeno.
Lavezzo è anche primo autore, insieme ad Elisa Franchin, del famoso studio di Vo’ approdato nel giugno scorso sulle pagine di Nature: il lavoro, intitolato Suppression of a SARS-CoV-2 outbreak in the Italian municipality of Vo’, ha contribuito in modo importante alla conoscenza del comportamento del virus SARS-CoV-2 ed è stato tra i primi a rivelare l’elevata presenza di contagi asintomatici e a valutare l’efficacia delle misure di contenimento dell’infezione. Dopo la prima fase il lavoro sulla coorte di Vo’ è proseguito con la sierologia, proprio con l’obiettivo di analizzare la durata della risposta anticorpale al patogeno. Gli autori hanno completato nei giorni scorsi il paper scientifico che illustrerà i risultati ottenuti, ma intanto Lavezzo ci conferma che quanto osservato tra i cittadini di Vo’ risulta in linea con gli ultimi dati pubblicati all’interno della letteratura.
L'intervista al professor Enrico Lavezzo, docente del dipartimento di Medicina molecolare dell'università di Padova, sulla persistenza degli anticorpi a SARS-CoV-2 e sui meccanismi della memoria immunologica. Servizio e montaggio di Barbara Paknazar
"Questo tipo di informazione - introduce Enrico Lavezzo, docente del dipartimento di Medicina molecolare dell'università di Padova - si sta aggiornando continuamente dal momento che prosegue la pubblicazione di articoli che vanno a ricercare la risposta immunitaria nei pazienti infettati da SARS-CoV-2 su una scala temporale che ovviamente è sempre più lunga, mano a mano che il tempo passa. Quello che si sta osservando è che la risposta immunitaria contro questo virus si sviluppa nella quasi totalità delle persone che vengono infettate, sebbene ci sia comunque una grande variabilità tra un individuo e l’altro". E questa eterogeneità dipende anche dal decorso clinico dell'infezione. "Tendenzialmente i soggetti che hanno avuto una sintomatologia più severa presentano titoli anticorpali più elevati rispetto alle persone in cui l’infezione ha portato a sintomi lievi o ai casi completamente asintomatici".
"A livello di persistenza della risposta anticorpale - prosegue il professor Lavezzo - ci sono ormai evidenze che fino a otto mesi dall’infezione è possibile rilevare la presenza di anticorpi specifici per SARS-CoV-2 nella grande maggioranza delle persone che erano state contagiate". Il docente entra poi nel merito dei risultati a cui è arrivato anche il suo team di ricerca nello studio realizzato sui cittadini di Vo'. "Nella nostra coorte abbiamo fatto un’indagine sierologica in due punti temporali distanti circa sette mesi l’uno dall’altro. Il primo screening è stato effettuato a maggio, quindi circa due mesi dopo il focolaio che era scoppiato a Vo’ tra febbraio e marzo, e in quel caso abbiamo testato quasi tutta la popolazione del paese andando a ricercare la presenza di una risposta immunitaria specifica contro diversi antigeni del virus, sia la proteina spike che la proteina N del nucleocapside. Successivamente tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, quindi a distanza di altri sette mese, abbiamo ripetuto il test solo sui soggetti che avevano dato un segnale di positività nei precedenti screening, sia a livello di sierologia ma anche nel caso in cui erano risultati positivi al tampone. Il nostro obiettivo era proprio quello di studiare degli anticorpi nel tempo e abbiamo rilevato la loro persistenza nella grande maggioranza delle persone: circa il 90% di chi era positivo al test sierologico effettuato a maggio è rimasto positivo anche a distanza di sette mesi".
Gli anticorpi a distanza di circa sette mesi erano dunque ancora rilevabili, sebbene con il trascorrere del tempo tendano a diminuire. "Abbiamo osservato una diminuzione dei titoli anticorpali che in alcuni test sierologici si è manifestata in modo significativo mentre in altri la differenza è stata più lieve". Ma c'è un altro dato significativo che illustra bene i meccanismi della memoria immunologica. "In alcuni casi abbiamo osservato un andamento opposto, quindi un boost di anticorpi. E molte di queste persone in cui si è manifestato questo comportamento ci hanno riferito di essere state esposte recentemente al virus. Possiamo quindi spiegare questi trend come veri e propri boost conseguenti alla riesposizione a SARS-CoV-2. Questo ci dice che il sistema immunitario di queste persone ha riconosciuto il virus e ha reagito in modo forte contro una reinfezione dallo stesso patogeno", spiega Enrico Lavezzo precisando che "nessuno di questi soggetti ha riportato sintomi".
Inoltre, nessuna delle persone il cui test sierologico ha rivelato una nuova spinta nella produzione di anticorpi è risultata positiva al tampone. Naturalmente questo può dipendere anche dal momento in cui è stato effettuato il tampone visto che la positività a SARS-CoV-2, soprattutto in assenza di sintomi, difficilmente supera le due settimane ma c'è anche un'altra possibile spiegazione. "Nonostante una riesposizione possa essere compatibile con una certa quantità di replicazione del virus ipotizziamo che sia molto più contenuta rispetto alla prima e quindi difficilmente rilevabile. E’ possibile che questa memoria immunologica abbia anche un impatto positivo sulla prevenzione della trasmissione del virus da parte dei soggetti riesposti", commenta al riguardo il professore del dipartimento di Medicina molecolare dell'università di Padova.
Ma come funziona nello specifico la memoria immunologica? "Permette di produrre sia anticorpi sia linfociti T specifici, in grado di riconoscere un patogeno che il nostro organismo ha precedentemente già incontrato. Queste cellule della memoria permangono nei nostri organi linfatici secondari anche per lunghi periodi e nel caso di una nuova esposizione al patogeno si riattivano e iniziano a proliferare in modo molto rapido e producono un’enorme quantità di linfociti B o T, a seconda della cellula di memoria di partenza, che sono esattamente quelli capaci di riconoscere il patogeno a cui eravamo già stati esposti in precedenza. I recenti studi che sono usciti anche su Science e Nature hanno dimostrato non solo che l’infezione da SARS-CoV-2 provoca lo sviluppo di anticorpi che permangono per molti mesi nel sangue delle persone guarite, ma anche che le cellule della memoria persistono senza diminuire per un periodo di almeno sei mesi. Non solo: sembra anche che durante questo periodo di permanenza maturino e si specializzino ancora di più nel riconoscimento delle proteine, degli epitopi principali del virus e siano quindi anche più neutralizzanti rispetto a quelle che vengono prodotte nelle prime fasi della risposta immunitaria", spiega Lavezzo.
E oggi questo filone di ricerche acquisisce una valenza ancora maggiore dal momento che ci si interroga su quale potrà essere l'estensione temporale della protezione offerta dai vaccini. "Questi studi sono assolutamente prodromici anche per la comprensione di quella che sarà la risposta alle vaccinazioni. Dovrà essere monitorata ma ci si aspetta un andamento comparabile", conclude il professor Lavezzo.