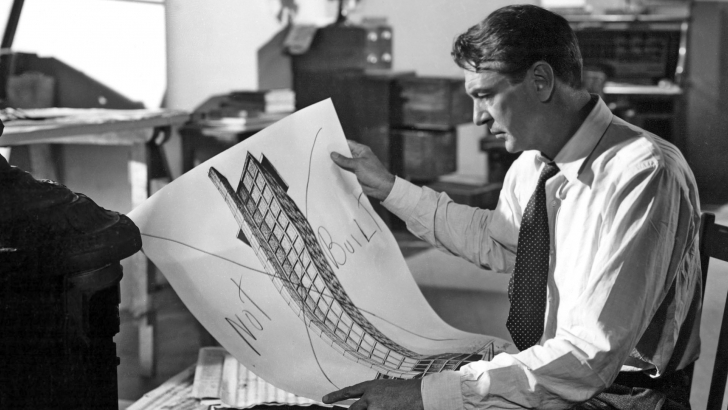CULTURA
Leggete subito questo articolo. Domani potrebbe essere troppo tardi

Scena da "The Quiet Earth", film di Geoff Murphy (1985)
La notizia è che no, il mondo non sta per finire, a dispetto di tutto l'inchiostro versato da quando si è sparsa la voce della fine del calendario Maya: una voce, davvero, proprio come le voci che seminavano il panico alla vigilia dell'anno Mille. Chi si è dato la pena di verificare la “profezia” (come Paolo Attivissimo nel suo blog Il disinformatico, utilissimo per disinnescare gli effetti perniciosi di bufale, dicerie e catene di sant'Antonio) ha già chiarito che effettivamente il calendario Maya dedicato ai lunghi periodi si chiude proprio in questi giorni, ma per aprire poi un'altra fase, il quattordicesimo baktun – proprio come ogni anno il primo gennaio segue il 31 dicembre, senza particolari angosce da parte nostra.
Se la fine di un calendario non comporta la fine del mondo, è certo però che l'idea di Apocalisse ha su noialtri umani un fascino inquietante, anche perché (quasi) sempre non esclude l'ipotesi che qualcuno scamperà alla catastrofe, che la vita continuerà. Ipotesi su cui Roland Emmerich, astuto confezionatore di monumentali sciagure cinematografiche, ha imbastito il suo 2012 – con tanto di tecnologiche arche di Noè (riferimento d'obbligo, quando si parla di fine del mondo) destinate a veleggiare verso l'Africa in un simbolico ritorno alle origini che piace sempre tanto alle megaproduzioni hollywoodiane. E la prospettiva di un nuovo inizio, o per lo meno di un mondo dove è ancora possibile dire “domani”, occhieggia in tanti libri e film post-apocalittici, anche in quelli all'apparenza più cupi, come La strada di Cormac McCarthy, portato poi sullo schermo da John Hillcoat, dove il legame tra padre e figlio rappresenta in qualche modo la resistenza dei valori morali, la proiezione verso un futuro non intessuto solo di desolazione. Non a caso Luca Briasco in un articolo intitolato Postmoderni narratori apocalittici inscrive il romanzo di McCarthy all'interno di “un modello narrativo fondato su quella che Friedric Jameson ha definito ‘nostalgia del presente’”. Come dire che si descrive un “poi” disastroso anche per rivedere in una luce favorevole il nostro desolato presente – tesi intorno alla quale ruota anche un saggio del 1999 di Thomas Berger, After the End, dedicato per intero alle rappresentazioni del post-apocalisse e basato sull'idea che queste narrazioni del dopo-catastrofe abbiano anche una funzione terapeutica o, forse, più precisamente, rassicurante, rispetto alle catastrofi reali che abbiamo dietro di noi e, alle volte, sotto gli occhi.
Non è sempre così. Ci sono – anche se non sono molti – libri e film dove “l'ultimo uomo” è, alla lettera, L'ultimo uomo (la prima a pensarci fu la geniale Mary Shelley, in un romanzo molto meno fortunato di Frankenstein) e dove “il mondo alla fine viene distrutto per davvero”, come recita il titolo di una pagina del sito io9, in cui si trova l'elenco di una quindicina di pellicole nelle quali the ending, il finale, coincide con the end, la fine. Si va dal grande classico Dottor Stranamore di Kubrick al recente Melancholia di Lars von Trier, ma qui ci piace chiudere con un film ormai quasi dimenticato del '59, L'ultima spiaggia, basato sull'omonimo romanzo dell'australiano Nevil Shute. Alle spalle c'è stata (naturalmente) la terza guerra mondiale, e una catastrofe atomica, che ha annientato l'emisfero Nord. Inutilmente Gregory Peck, comandante di un sommergibile, cerca scampo per sé e i suoi in Australia. Le radiazioni arriveranno implacabili e dimostreranno l'amara verità delle parole dello scienziato Julian Osborne (interpretato da un imprevedibile Fred Astaire): responsabile è «chi credette di poter mantenere la pace affidando la difesa ad armi il cui utilizzo sarebbe stato un suicidio». Parole che – ben più delle profezie Maya – varrebbe la pena di ricordare anche oggi.
Maria Teresa Carbone