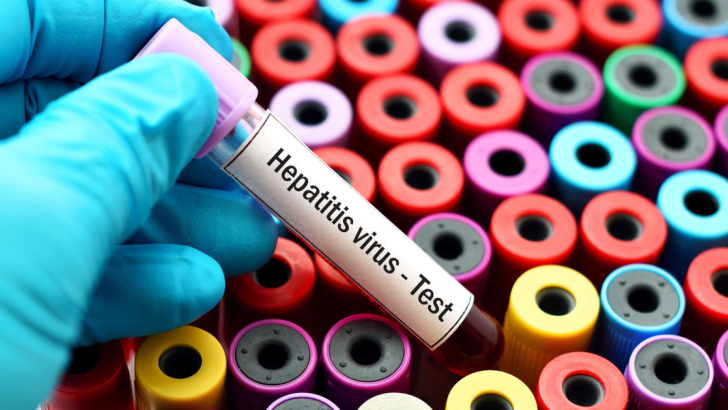In Salute. Alzheimer: dalla diagnosi alle terapie i risultati (tangibili) della ricerca

Foto: Adobe Stock
“Quando inizia realmente la patologia: quando la persona manifesta i sintomi o molto prima? Qual è il momento giusto per intervenire? Quando fare la diagnosi? Che farmaci usare? Per rispondere a tutte queste domande è necessario conoscere l'evoluzione, la fisiopatologia della malattia e oggi ci stiamo arrivando con informazioni sempre più chiare”. A parlare di Alzheimer è Annachiara Cagnin, responsabile del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze della clinica neurologica dell’azienda ospedale-università di Padova, che abbiamo incontrato a Palazzo Bo a Padova in occasione della Settimana mondiale del cervello (11-17 marzo 2024).
Più di 55 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di demenza – un milione e 100.000 in Italia – e ogni anno si registrano quasi 10 milioni di nuovi casi. La malattia di Alzheimer è la forma più diffusa e contribuisce circa al 60% dei casi. Sono, questi, numeri destinati a crescere se si considera il progressivo allungamento della vita media. Nel 2019, la malattia è costata alle economie mondiali 1,3 trilioni di dollari: circa il 50% dei costi è da attribuire all’assistenza fornita da badanti informali (ad esempio familiari e amici), che forniscono in media cinque ore di assistenza e supervisione al giorno.
Fino a poco tempo fa non erano noti strumenti diagnostici in grado di identificare la malattia di Alzheimer in fase precoce, cioè prima dell’insorgere dei sintomi, e nemmeno farmaci capaci di modificare l’andamento della patologia. Negli ultimi anni, tuttavia, la ricerca ha compiuto importanti passi avanti sia nel campo della diagnosi che del trattamento della malattia.
Diagnosticare la malattia prima dell’insorgere dei sintomi
Il morbo di Alzheimer attualmente viene diagnosticato attraverso l’esame clinico del paziente, test neuropsicologici che valutano funzioni cognitive come la memoria, il linguaggio, le funzioni visuospaziali, l’attenzione, ed esami strumentali di imaging cerebrale (TAC, risonanza magnetica, PET, SPECT). A seconda dei casi il medico decide di volta in volta quali accertamenti prescrivere e quanto approfondire la valutazione diagnostica. È importante infatti escludere altri tipi di patologie come i tumori cerebrali, la patologia vascolare cerebrale o problemi tiroidei, che pure possono causare sintomi simili alla demenza. In casi specifici lo specialista può prescrivere l’esame del liquor cerebrospinale prelevato con puntura lombare: è possibile in questo modo misurare i livelli di proteina beta-amiloide e proteina tau fosforilata (due importanti biomarcatori) che, in caso di Alzheimer, si accumulano nello spazio tra i neuroni e all’interno dei neuroni stessi. Se una persona è ammalata, nel liquido cerebro-spinale la proteina tau aumenta, mentre il peptide beta-amiloide diminuisce.
Oggi il paziente viene sottoposto agli esami clinici e strumentali del caso solitamente dopo la comparsa dei primi problemi di memoria: la proteina beta-amiloide però inizia ad accumularsi nel cervello già 10-15 anni prima dell’insorgere dei sintomi, i quali indicano dunque che la malattia sta progredendo da tempo. Grazie allo sforzo di molti ricercatori in questi anni, presto potrebbe essere possibile invece diagnosticare la patologia in una fase molto precoce e pre-sintomatica attraverso un semplice esame del sangue, riducendo in questo modo anche l’invasività e i costi di esami come la PET o la rachicentesi.
Intervista completa ad Annachiara Cagnin, responsabile del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze della clinica neurologica dell’azienda ospedale-università di Padova. Riprese e montaggio di Barbara Paknazar
“A febbraio è stato pubblicato su Nature medicine un articolo rivoluzionario che ha dimostrato, su popolazioni di migliaia di pazienti, che un particolare biomarcatore nel sangue dà una risposta equivalente o superiore a quella che si ottiene con la puntura lombare”. Si tratta della proteina p-tau2017 i cui livelli nel sangue risultano elevati già prima che la persona manifesti una compromissione dal punto di vista cognitivo.
“Una strumento diagnostico di questo tipo potrebbe essere disponibile in ambito sanitario a breve. Non stiamo parlando di 5-10 anni, ma di un tempo molto inferiore: già nell’arco di due anni potrebbe essere sul mercato e rivelarsi molto utile come metodo di screening. Il medico ovviamente rimane una figura di riferimento fondamentale: i risultati degli esami ematochimici devono essere interpretati e aiutano a stratificare il rischio di una persona di avere effettivamente la malattia. A seconda delle circostanze è lo specialista a definire poi il percorso diagnostico, che può essere più o meno intensivo”.
Un altro studio che si muove in questa direzione è stato pubblicato sempre a febbraio su Nature Aging. In questo caso i ricercatori hanno esaminato i campioni di sangue di 52.645 adulti sani, raccolti nella UK Biobank. Nel corso dei 14 anni di monitoraggio, 1.417 persone hanno ricevuto una diagnosi di demenza. Ebbene, delle 1.463 proteine plasmatiche considerate, gli studiosi hanno rilevato che Gfap, Nefl, Gdf15 e Ltbp2 sono risultate le più associate alla demenza per tutte le cause, alla malattia di Alzheimer e alla demenza vascolare.
Le nuove linee guida europee
Un traguardo particolarmente significativo per la presa in carico del paziente è stata la recente pubblicazione delle prime linee guida europee per la diagnosi di Alzheimer o altre forme di demenza. Le raccomandazioni sono state pubblicate su Lancet Neurology, dopo essere state condivise e approvate da un gruppo di lavoro multidisciplinare, composto da più di 20 esperti esperti di 11 società scientifiche europee nel campo della neurologia, psicogeriatria, radiologia e medicina nucleare, con il supporto di un rappresentante dell’associazione Alzheimer Europe. Il lavoro è stato coordinato da specialisti dell’università di Genova - Irccs ospedale Policlinico San Martino, dell’università di Ginevra e dell’Irccs Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia.
Il documento offre indicazioni sui percorsi diagnostici da intraprendere in persone che presentano i primi segni di demenza, per favorire un uso efficace dei biomarcatori nella diagnosi di Alzheimer o altre demenze, e con l’obiettivo di arrivare a individuare la patologia in tempi più rapidi possibili e con minori sprechi di risorse. Sulla base dei sintomi che il paziente presenta, suddivisi in 11 categorie a seconda del tipo di manifestazione clinica (in alcune persone per esempio può prevalere il disturbo di memoria, oppure di linguaggio, o ancora delle funzioni esecutive, con o senza altri segni neurologici), vengono di volta in volta indicati gli esami più idonei da eseguire per arrivare a una diagnosi il più possibile precisa e personalizzata. Le nuove raccomandazioni europee aiutano dunque lo specialista a sottoporre il paziente a un flusso logico di esami, scegliendo fra i molti disponibili quelli più adeguati e decidendo poi, in base ai risultati, se fermarsi o proseguire con ulteriori test. Si ritiene che in futuro, quando sarà possibile servirsi anche dei biomarcatori ematici, l’approccio suggerito dalle linee guida europee potrebbe contribuire a ridurre fino al 70% gli esami strumentali eseguiti oggi.
Anticorpi monoclonali al vaglio dell’Ema
I centri per i disturbi cognitivi e le demenze, cioè i servizi ambulatoriali dedicati alla valutazione, diagnosi e cura della persona con alterazione delle funzioni neurocognitive, sono nati negli anni 2000, cioè nel momento in cui furono disponibili sul mercato farmaci efficaci da somministrare ai pazienti. Si trattava, tuttavia, di medicinali che andavano ad agire sui sintomi e non modificavano la traiettoria di malattia. “La scienza – spiega Cagnin – sta tentando da decenni di trovare la strada giusta per aggredire gli attori principali della patologia di Alzheimer, cioè le proteine amiloide e tau, cercando di arrestarne la produzione, il deposito e l’espansione nel cervello”.
I primi farmaci con queste caratteristiche a essere sviluppati dalla comunità scientifica e approvati da un’agenzia regolatoria, la Food and Drug Administration (Fda) americana, sono anticorpi monoclonali progettati per attaccare e rimuovere i depositi di proteine beta-amiloide nel cervello. Sono stati classificati come terapie modificanti la malattia, che possono rallentare il progressivo declino cognitivo e mantenere i pazienti più a lungo nelle fasi meno sintomatiche. Nello specifico si tratta di aducanumab, approvato dalla Fda nel 2021 e già in commercio negli Stati Uniti, ma respinto dall’European Medicines Agency (Ema); lecanemab approvato nel 2023 dalla Fda ma non ancora da Ema; e donanemab in fase di valutazione sia da parte di Fda che Ema.
“L'efficacia di questi farmaci dipende dal livello di malattia dei pazienti i quali probabilmente non risponderanno tutti allo stesso modo alla terapia. Si tratta di medicinali molto efficaci nelle fasi iniziali della patologia, e questo spiega perché si presti particolare attenzione alla diagnosi precoce. Resta ancora molto lavoro da fare però per definirne in modo puntuale l’efficacia e dunque per l’utilizzo in real life. Il meccanismo d'azione è sicuro, e i due farmaci sono in fase di approvazione da parte dell'Ema: l’approvazione definitiva è attesa tra giugno e settembre di quest'anno. La comunità scientifica, i clinici dunque si stanno preparando alla possibilità di poter utilizzare dei farmaci che modificano la traiettoria di malattia se somministrati alle persone giuste, nel momento giusto, e conoscendo i possibili effetti collaterali”.
Prevenire l’Alzheimer, possibile? Sì
Negli ultimi 20 anni sul tema della prevenzione si è concentrata ampia parte della ricerca scientifica. Nel 2017 in particolare una commissione internazionale di esperti (Lancet Commission) ha individuato nove fattori di rischio potenzialmente modificabili per la demenza, che sono il basso livello di istruzione, l'ipertensione, i disturbi dell'udito, il fumo, l'obesità, la depressione, l'inattività fisica, il diabete e l'isolamento sociale. A questi nel 2020 ne aggiunge altri tre, e cioè il consumo eccessivo di alcol, i traumi cerebrali e l’inquinamento atmosferico. Ebbene, si stima che intervenendo su questi 12 fattori di rischio si potrebbe ridurre e prevenire lo sviluppo di circa il 40% dei casi di demenza.
Annachiara Cagnin precisa: “Non si previene l'Alzheimer o altre patologie neurodegenerative all’età di 60-70 anni. Si inizia da bambini stimolando il cervello con attività educative intra ed extra-scolastiche e mantenendo un sonno regolare. Data la forte connessione tra cuore e cervello, a partire dai 50 anni di età è importante controllare i fattori di rischio cardiovascolare, perché la salute del cuore a questa età si riflette poi sulla funzionalità cerebrale a 70 anni e oltre. In età avanzata infine si deve porre molta attenzione al contrasto dell'isolamento sociale, della depressione. È importante fare network, avere degli hobby, vivere la comunità. Oggi si parla di città per l’Alzheimer, cioè di centri non solo accoglienti per le persone con decadimento cognitivo, ma costruiti per prevenire la malattia con queste modalità”.
Per favorire sul territorio una gestione integrata della demenza, nella Legge di bilancio del 2021 è stato istituito un Fondo per l’Alzheimer e le demenze – primo finanziamento pubblico di questo tipo – che ha messo a disposizione di Regioni e Province Autonome una dotazione di 14 milioni e 100.000 euro per gli anni 2021-2023 e di 900.000 euro per l’Istituto Superiore di Sanità per finanziare le azioni previste dal Piano Nazionale delle Demenze. Ora con la Legge di bilancio 2024 il Fondo viene incrementato di 4,9 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.