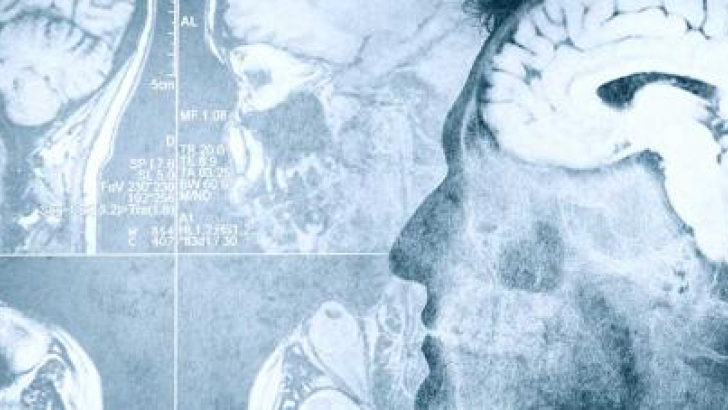SOCIETÀ
Il rompicapo della legge elettorale

Foto: Reuters/Yara Nardi
La Corte Costituzionale ha messo fine a uno scandalo che durava dal 2005, quello della legge elettorale maggioritaria che, alla Camera, assegnava 340 deputati su 630 alla coalizione che avesse ottenuto anche un solo voto in più dei principali avversari. Secondo il grecista Luciano Canfora uno scandalo perfino più grande delle elezioni politiche del 1924 che videro la vittoria del “listone” mussoliniano grazie alle violenze degli squadristi e alla legge Acerbo. Ora occorre trovare una soluzione che rispetti le indicazioni della Corte e che permetta al paese di tornare a votare, se necessario in tempi brevi: il governo Letta si regge su di una maggioranza assai precaria.
Non esistono sistemi elettorali “perfetti”: tutti hanno due obiettivi che non coincidono, la rappresentanza delle diverse opinioni presenti nella società e la formazione del governo. Non solo: i meccanismi tecnici per la conversione delle preferenze dei cittadini in seggi (la cosiddetta formula elettorale) possono dare risultati diversissimi a partire dalla stessa distribuzione dei suffragi. La Corte ha però giudicato una violazione del principio costituzionale del voto “eguale” il meccanismo di assegnare un premio in seggi al vincitore (cioè alla più grossa minoranza uscita dalle urne) di fatto lasciando in vita un sistema proporzionale.
Nel panorama mondiale dominano largamente le formule proporzionali: la filosofia di fondo, espressa nel modo più chiaro da John Stuart Mill, è di cercare di assicurare la corrispondenza tra voti espressi e seggi ottenuti da un partito: “Il primo principio della democrazia [è] la rappresentanza in proporzione ai numeri [dei voti]. E’ una parte essenziale della democrazia il fatto che le minoranze siano adeguatamente rappresentate” scrisse il filosofo inglese nel 1862.
Sistemi perfettamente proporzionali, come quelli in uso in Israele e in Olanda, rendono necessario formare governi di coalizione, spesso con numerosi partiti, a causa della frammentazione della Camera in numerose forze politiche. Per questo vari paesi hanno introdotto una soglia di sbarramento, cioè una percentuale minima di voti che occorre superare per essere ammessi al riparto dei seggi (in Germania, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Romania, e Serbia il 5%, in Spagna il 3%).
Lo stesso risultato si può ottenere dividendo il territorio in circoscrizioni senza recupero nazionale dei resti: circoscrizioni dove si elegge un solo deputato (come in Gran Bretagna o negli Stati Uniti) favoriscono i grandi partiti, circoscrizioni dove si elegge una pluralità di deputati permettono la rappresentanza anche dei partiti più piccoli. La soluzione più diffusa sono circoscrizioni che hanno una dimensione variabile fra 7 e 30 seggi, creando un quoziente (cioè la percentuale necessaria per ottenere un seggio) che varia fra il 3 e il 14%. Come si è detto, più numerosi sono i seggi di una circoscrizione e più facile è l’ingresso in parlamento dei partiti minori.
In Italia, 20 anni di sistemi maggioritari non hanno semplificato il panorama politico, né impedito massicci trasferimenti di deputati da una forza politica all’altra durante la legislatura. Quindi è illusorio l’obiettivo dei “semplificatori”, i sostenitori di sistemi che “permettano di sapere la sera delle elezioni chi ha vinto”. Per ottenere un risultato elettorale semplificato, cioè una netta maggioranza, occorre violare in qualche modo il principio di uguaglianza. Sistemi maggioritari sono per esempio quelli di Gran Bretagna e Stati Uniti, dove l’effetto distorsivo viene dalle circoscrizioni dove si elegge un solo deputato: la distribuzione dei voti popolari permette in alcuni casi di ottenere una maggioranza dei seggi anche con poco più di un terzo dei voti, come accadde nel 2005, quando Tony Blair ebbe 356 seggi alla Camera dei comuni pur avendo ottenuto solo il 35,3% dei suffragi. Negli Stati Uniti l’attuale maggioranza repubblicana alla Camera (234 seggi) si regge su quella che è una minoranza di voti rispetto ai democratici che hanno solo 201 seggi.
Si dice che il sistema proporzionale non garantisce la “governabilità” ma, come scrive Canfora, questo “famigerato concetto” è “residuo di una mentalità elitistico-giacobina (autorizzare una minoranza fortemente determinata a proclamarsi maggioranza)” e, in realtà, nasconde una sfiducia nello stesso principio di maggioranza. Maggioranza da ricercarsi attraverso il paziente lavoro di confronto e compromesso.
Una proposta interessante è stata avanzata alcune settimane fa da un gruppo di scienziati politici tra cui Giovanni Sartori e Piero Ignazi: adottare un sistema simile a quello francese in cui il territorio è diviso in circoscrizioni dove si elegge un solo deputato ma si vota in due turni se nessun candidato raccoglie una maggioranza assoluta di consensi nella prima votazione. Al secondo turno sono ammessi soltanto i candidati che hanno ottenuto almeno il 12,5% degli iscritti alle liste elettorali, quindi in pratica il 16-24% dei voti espressi (la cifra esatta dipende dalla partecipazione al voto). Normalmente, il ballottaggio è fra i due candidati più votati: “Il doppio turno riporta nelle mani dei cittadini la scelta del loro eletto e consente di riallacciare un rapporto fiduciario tra cittadini e rappresentanti” scrive Ignazi.
Il sistema ha anche il vantaggio di permettere la formazione di una maggioranza, però il meccanismo premia i partiti maggiori e conduce all’esclusione dal parlamento di forze politiche che possono anche superare il 20% dei voti, com’è il caso del Front National in Francia. Chissà cosa accadrebbe in Italia con tre forze politiche (Pd, Forza Italia e Movimento 5 stelle) di consistenza elettorale molto simile, attorno al 25%.
Fabrizio Tonello