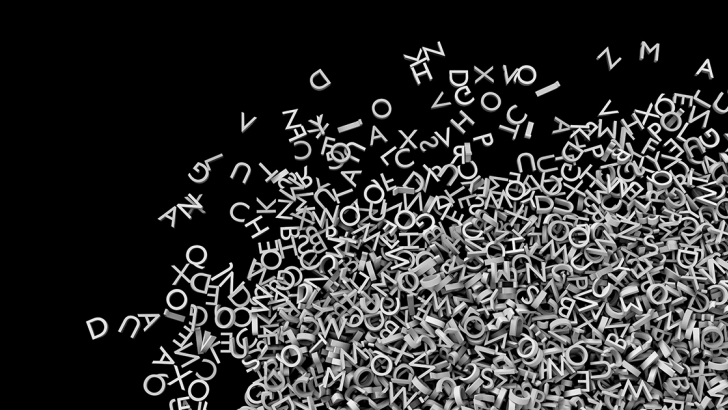Le radici evolutive del “baby talk”

Imparare a parlare non è facile, anche se non ce ne ricordiamo. Per un bambino, l’apprendimento di quella che diventerà la sua lingua madre è un processo piuttosto lungo e che richiede un’intensa attività cerebrale. Gli input acustici che consentono l’apprendimento vocale, naturalmente, provengono dall’esterno, attraverso l’ascolto degli adulti. Ebbene, in molte culture umane è diffuso il cosiddetto “baby talk” o “motherese”. Si tratta di quel modo di parlare con cui spesso ci si rivolge ai bambini più piccoli, caratterizzato da un tono di voce più acuto e cantilenante, espressioni del viso esagerate, ripetizioni e molte domande. Nella letteratura scientifica, questo tipo di linguaggio viene spesso definito con l’espressione infant-directed communication o child-directed communication (CDC) che significa, letteralmente “comunicazione diretta al bambino”.
Come riporta una review condotta da alcuni studiosi del Centro di studi interdisciplinari sull’evoluzione del linguaggio (ISLE) dell’università di Zurigo e pubblicata di recente su PLOS Biology, diversi lavori di ricerca hanno dimostrato che l’uso della CDC facilita l’apprendimento linguistico e migliora anche le capacità di interazione sociale. Questa forma di comunicazione aiuta i bambini non solo ad associare i significati alle parole più velocemente, ma anche a pronunciarle a loro volta e a comprenderne le modalità di utilizzo, imparando quindi a ripeterle in nuovi contesti. È stato anche dimostrato che i bambini preferiscono il baby talk rispetto al modo di parlare solitamente diretto agli adulti perché tale forma di comunicazione mantiene più alta la loro attenzione e intensifica l’attività cerebrale nei lobi temporali di destra e di sinistra. Inoltre, altri studi suggeriscono che una maggiore esposizione al baby talk sia associata a un vocabolario più ampio e persino a una maggiore capacità di elaborare testi scritti.
Eppure, l’uso della child-directed communication non è diffuso in tutte le culture umane, né tantomeno tra gli animali. Proprio la mancanza delle principali caratteristiche peculiari della CDC nelle altre specie porta gli autori a ipotizzare che tale comportamento linguistico sia una caratteristica evolutiva propriamente umana.
Communication is key for #language acquisition in children. Our new Essay from @johschka @caroline_fryns @FranzisWegdell @SimonWTownsend @sabine_stoll and colleagues sheds light on the #evolution of child-directed and child-surrounding #communication.https://t.co/60YsNrz3I2 pic.twitter.com/1x1WpCzr9M
— PLOS Biology (@PLOSBiology) May 9, 2022
Infatti, per quanto sia stato osservato che anche alcuni animali tendano a usare specifici movimenti della testa e del corpo o delle vocalizzazioni particolari per interagire con i cuccioli – un comportamento definito dagli autori Immature-directed communication (comunicazione immatura diretta) o IDC – sembra che non sia possibile riscontrare le caratteristiche proprie della CDC in nessuna altra specie animale, compresa quella dei nostri parenti più prossimi: le grandi scimmie antropomorfe.
Gli studiosi hanno osservato che in alcune specie di primati non umani, come gli scimpanzé e i gorilla, le madri usano gestualità e vocalizzazioni particolari per interagire con i piccoli, ma è improbabile che tali comportamenti giochino un ruolo nell’acquisizione della loro competenza comunicativa, perché i suoni in questione non sembrano avere una funzione pedagogica bensì, piuttosto, di richiamo. Eppure, gli studi condotti non sono ancora sufficienti per poter trarre conclusioni definitive sull’argomento.
C’è da dire, però, che in altre specie (tra cui le orche, i gibboni e gli uisiti comuni) le vocalizzazioni particolari usate dalle madri per rivolgersi ai cuccioli potrebbero stimolare il loro apprendimento vocale. Quello che ancora non è chiaro, però, è quali siano i tratti essenziali di questo tipo di Immature-directed communication per l’acquisizione del significato degli input vocali e per la loro riproduzione. Anche in questo caso, però, gli studi sull’argomento non bastano a stabilire con certezza che tali fenomeni siano lontanamente paragonabili al nostro baby talk, per cui non è possibile confermare né scartare completamente l’ipotesi che la CDC sia frutto di una convergenza evolutiva tra gli esseri umani e altre specie animali.
Un ulteriore quesito che sarebbe utile approfondire negli studi futuri riguarda la diffusione della CDC tra le specie umane primitive che abitavano il nostro pianeta prima della diffusione di Homo sapiens. Per questo motivo, approfondire con ulteriori studi le caratteristiche della IDC tra gli animali e le eventuali similitudini con il baby talk potrebbe fornire utili indizi per immaginare come i primi ominidi si rivolgessero ai loro bambini.
Infine, bisogna considerare che neanche tra le culture umane il baby talk è diffuso e strutturato allo stesso modo. Le caratteristiche tipiche associate alla CDC (espressioni facciali e gesti esagerati, ripetizioni, un tono di voce più acuto e sillabe scandite), infatti, possono variare tra le diverse società umane, specialmente tra quelle WEIRD (acronimo che sta per western, educated, industrialized, rich and democratic, ovvero “occidentali, istruite, industriali, benestanti e democratiche”) e non WEIRD (ad esempio, è stato osservato che nella comunità Maya dei K'iche' il tono di voce delle madri non si fa più acuto rispetto al solito quando si rivolgono ai bambini).
In molte di queste società, inoltre, l’uso della child-directed communication non è particolarmente diffuso e non rappresenta perciò l’input linguistico principale per l’acquisizione del linguaggio da parte dei bambini. Gli studi dimostrano, comunque, che anche i bambini che non hanno appreso la loro lingua tramite la CDC diventano degli adulti madrelingua assolutamente competenti.

In tali culture, l’input acustico alla base dell’apprendimento della lingua madre è costituito da quella che gli autori definiscono child-surrounding communication (“comunicazione che circonda il bambino”) o CSC. Tale espressione viene usata per descrivere ogni tipo di conversazione percepibile dal bambino anche se non espressamente diretta a lui. Stando ad alcuni studi, tale input acustico sarebbe meno funzionale all’apprendimento del linguaggio. Eppure, secondo gli autori della review pubblicata su PLOS Biology, la funzione di tale input linguistico non è stata sufficientemente approfondita nella letteratura scientifica sull’argomento. La loro ipotesi, infatti, è che nelle comunità in cui la CDC non è diffusa, la CSC costituisca un “input compensativo” essenziale per l’apprendimento del linguaggio.
Inoltre, per quanto sia stato sostenuto che un’elevata esposizione alla child-surrounding communication non sia associata all’uso di un vocabolario più ampio, non si può escludere (a causa della mancanza di dati scientifici) che tale forma di comunicazione non abbia una funzione altrettanto importante nell’acquisizione di altre proprietà linguistiche o grammaticali.
La tesi sostenuta dagli autori è che le modalità con cui i bambini possono imparare una lingua tramite il semplice ascolto delle conversazioni tra gli adulti non siano state approfondite adeguatamente nella letteratura scientifica, nonostante questa forma di apprendimento sia probabilmente più diffusa nel mondo rispetto a quella che prevede l’insegnamento diretto della lingua dall’adulto al bambino.
In conclusione, il ruolo della child-surrounding communication potrebbe essere stato sottovalutato. Approfondirne le caratteristiche e le funzionalità (così come è stato fatto per comprendere l’utilità della child-directed communication) potrebbe permettere di acquisire nuove informazioni sui meccanismi cognitivi associati alla trasmissione e all’apprendimento delle conoscenze linguistiche negli esseri umani di oggi e, perché no, anche in quelli vissuti centinaia di migliaia di anni fa.